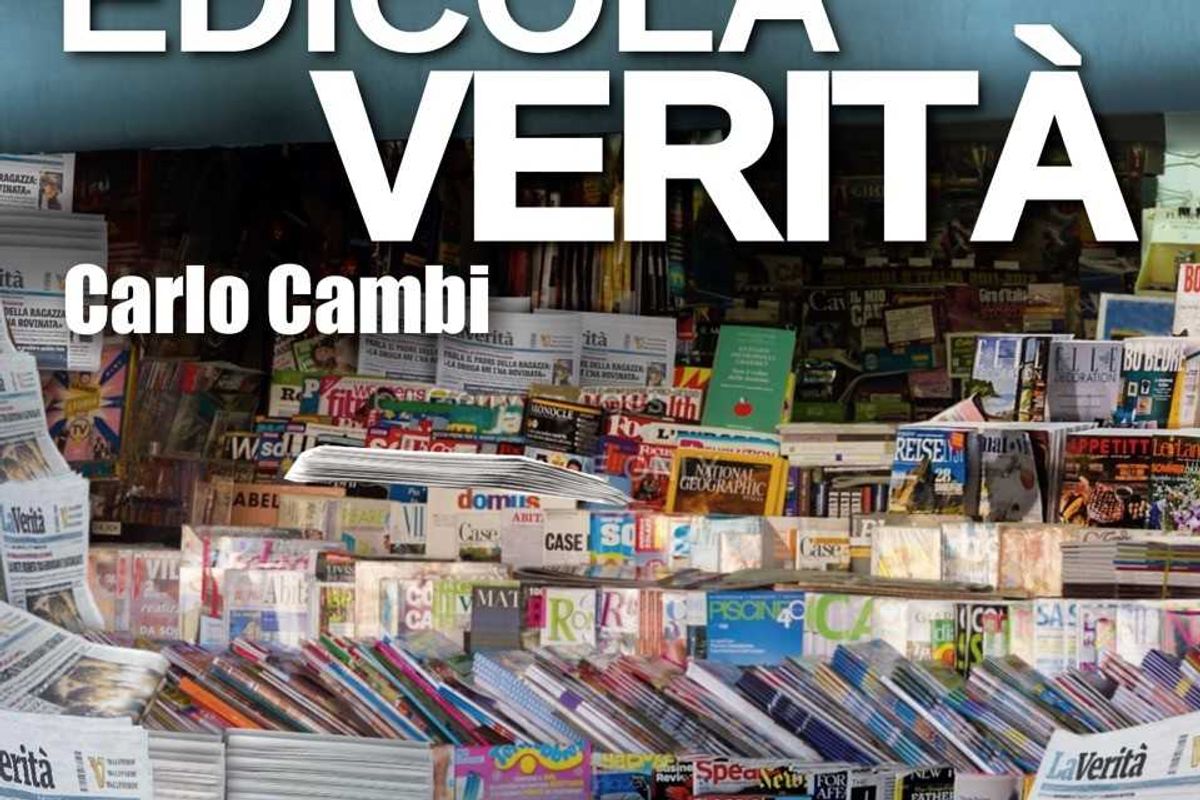Si brinda al Recovery ma è grazie alla Bce che l’Unione europea sta ancora in piedi

Giano è una delle divinità romane più antiche. Il dio bifronte, con il suo guardare al futuro e al passato contemporaneamente, oggi rappresenta la sintesi degli eventi della due giorni del Consiglio europeo in corso a Bruxelles e della riunione del Consiglio della Bce tenutosi ieri. Due giornate decisive per le sorti dell'Unione europea, sospesa tra passato e futuro. Da una parte il passato: estenuanti negoziati intergovernativi, regole di bilancio astruse ed anacronistiche, imposizione di vincoli esterni sulle scelte di spesa dei governi nazionali, un mostro burocratico di norme scritte in 24 diverse lingue, e controlli da applicarsi in 27 Paesi. Dall'altra il futuro, ovvero la normalità, con una Banca centrale che, pur sotto la pressione di eventi eccezionali, fa semplicemente il proprio lavoro, acquistando titoli del debito pubblico emessi dagli Stati membri sovrani, creando moneta con una semplice scrittura contabile. Il passato è la riforma del Mes e soprattutto, a dispetto del nome, il Next Generation Ue per il quale in serata ieri è finalmente arrivata la fumata bianca dell'accordo per sbloccare lo stallo creatosi tra Ungheria e Polonia ed il resto del Consiglio. Questi Paesi sono stati messi con le spalle al muro da un Regolamento che avrebbe dovuto condizionare l'erogazione dei fondi del bilancio pluriennale e del Ngeu al rispetto di regole di sana gestione finanziaria anche mirate alla prevenzione e alla adeguata sanzione di episodi di frode e corruzione nella gestione di tali fondi. Poi ci ha messo lo zampino l'Europarlamento, ampliando la casistica a situazioni tipicamente politiche, impropriamente fatte coincidere con lo Stato di diritto, e ai governi di Varsavia e Budapest non è restata altra scelta che mettere il veto sulla Decisione delle risorse proprie (le maggiori tasse con cui nei prossimi anni i cittadini europei ripagheranno i debiti fatti per il Ngeu) e sul bilancio pluriennale. La mediazione dovrebbe consistere in una dichiarazione interpretativa che consentirebbe ai Paesi, accusati di violare quel regolamento, di adire la Corte europea di giustizia, prima che la Commissione ed il Consiglio procedano.
Dopo il voto del Parlamento europeo previsto in sessione plenaria per il prossimo 14 dicembre, a gennaio dovremmo avere in Gazzetta ufficiale il regolamento che disciplina il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), la Decisione sulle risorse proprie, ed il bilancio 2021 con il quadro finanziario pluriennale fino al 2027. E qui cominciano i dolori.
Infatti in Italia, storditi dalla propaganda, in pochi hanno ancora rilevato che l'accesso a quei fondi contiene tali e tante condizioni da renderlo simile ad un percorso di guerra. Obiettivi intermedi, parametri quantitativi, task force a Bruxelles (già pronta) e a Roma (tuttora causa di divergenze nella maggioranza), un sistema informatico dedicato, vincoli stringenti sulla destinazione della spesa. Paletti tutto sommato comprensibili quando si attinge da una cassa comune, che quindi costituisce il vizio originario. Per non parlare della disciplina di bilancio ancor più stringente che saremo costretti a tenere non appena si allenterà il morso del Covid. Poi c'è il mondo normale. Poche ore prima dell'accordo annunciato dal presidente Charles Michel, Christine Lagarde aveva varato un ampliamento del programma di acquisti di titoli (Pepp, che riguarda per il 90% titoli pubblici) da 1.350 a 1.850 miliardi, il protrarsi degli acquisti fino almeno a marzo 2022 (dal precedente giugno 2021) e, dettaglio non trascurabile, il rinnovo dei titoli in scadenza almeno fino al dicembre 2023. Oltre ad un ampliamento della finestra temporale a disposizione delle banche per finanziarsi al tasso del -1% presso la Bce. Per l'Italia questo significa che, al presumibile ritmo di 30 miliardi a bimestre, la Bce aggiungerà nel 2021 altri 90 miliardi di acquisti, per raggiungere la somma di circa 200 miliardi di acquisti netti (contro i 180 del 2020). Già prima di questo annuncio, un recente studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio aveva calcolato che, a fronte di un fabbisogno statale di 146 miliardi, al mercato sarebbero rimaste le briciole. Ora c'è la certezza che nel 2021 la Bce che dovrà letteralmente strappare di mano al mercato (banche ed altre istituzioni finanziare, famiglie ed imprese) circa 60/70 miliardi. Debito (destinato a restare a lungo sui libri della Bce) che lo Stato potrebbe emettere per fare l'unica cosa necessaria e decisiva per l'economia in questo frangente: spendere. Bene, ovviamente, ma spendere. I dati pubblicati ieri mostrano una impressionante crescita dei depositi delle banche presso Bankitalia e di imprese e famiglie presso le banche. Tutto denaro «stampato» ma non speso. Infatti, ciò che conta ai fini della crescita e, soprattutto, ai fini della risalita dell'inflazione – che langue allo 0,2% e promette di risalire al 1,4% nel 2023 – è la moneta spesa. E l'agente più rapido ed efficace è lo Stato che si finanzia presso la Bce, senza essere intermediato dal mostro burocratico della Commissione.