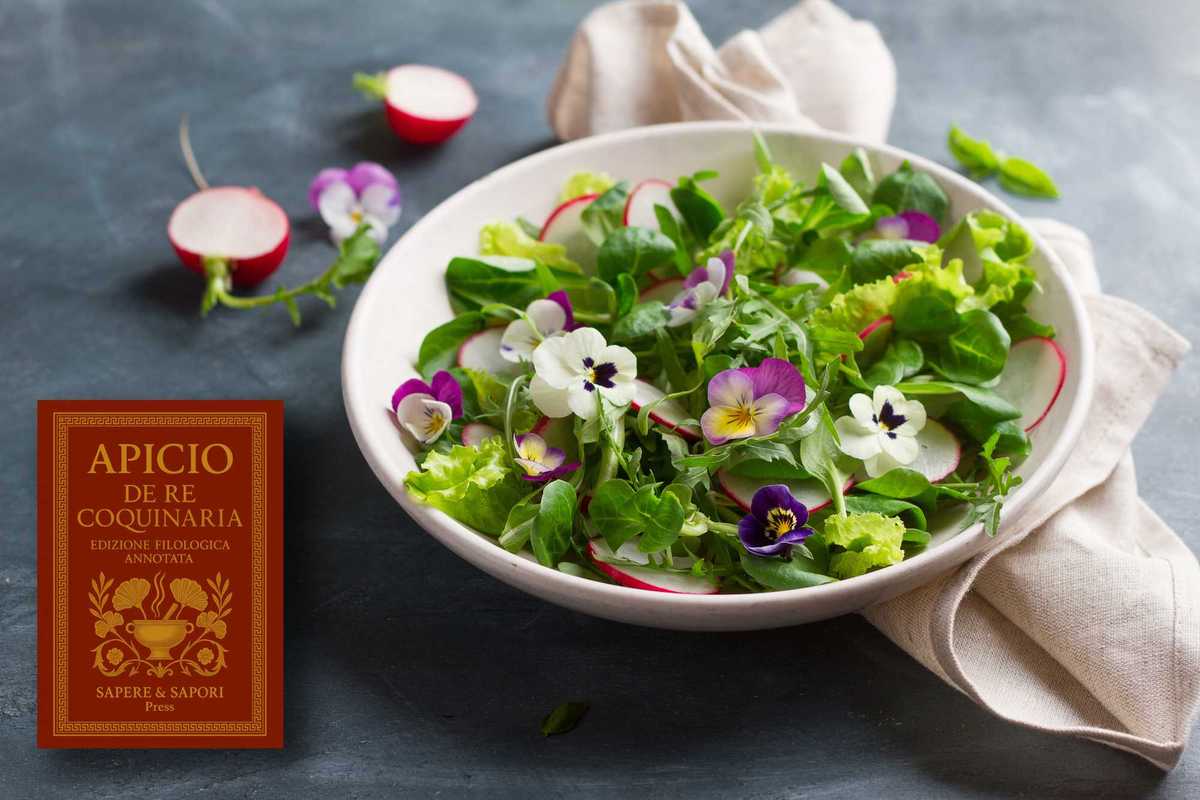La scienza feticcio dei «competenti» da 80 anni è ostaggio dei conformisti
«La scienza dirompente è in declino, e nessuno sa perché», titola l’autorevole rivista Nature. «Dirompente» è la traduzione - forse non del tutto soddisfacente - che abbiamo scelto dell’aggettivo disruptive. Provando ad articolare il concetto, per disruptive si intende qui qualcosa di sconvolgente, di rivoluzionario, di alternativo, capace di creare un «prima» e un «dopo», di mutare il corso delle cose anziché limitarsi a farlo lentamente avanzare nella direzione già esistente.
Nature non si limita a enunciare la tesi, ma la sostanzia con un grafico e con un’analisi storica: negli ultimi decenni si è assistito da un lato a un’incredibile moltiplicazione numerica delle pubblicazioni scientifiche, ma dall’altro a un clamoroso crollo di quelle - appunto - disruptive, come invece accadeva ancora negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso (la rivista cita ad esempio la rivoluzionaria intuizione della doppia elica del Dna nel 1953).
L’analisi di Nature, a sua volta tributaria di un lavoro di ricerca dell’Università del Minnesota, arriva a fissare un indice, il cosiddetto Cd index, che dovrebbe misurare proprio la disruptiveness di un paper scientifico, cioè la sua attitudine a rivoluzionare le acquisizioni preesistenti. Ecco, questo indice sarebbe crollato di oltre il 90%, tra il 1945 e il 2010, per quel che riguarda le pubblicazioni di ricerca. E ciò avrebbe riguardato le materie e le discipline più diverse: scienze sociali, tecnologia, scienze fisiche, biomedicina.
Di più: la diversa attitudine riguarderebbe non solo l’orientamento delle ricerche, ma perfino il lessico utilizzato: negli anni Cinquanta era più comune l’uso di verbi capaci di evocare i concetti di creazione o scoperta, come «produrre» o «determinare», mentre nel 2010 anche il linguaggio risultava più orientato semplicemente a un progresso incrementale («migliorare», «accrescere», eccetera).
Nature - con saggezza - fa notare che non necessariamente la disruptiveness sia positiva, così come non necessariamente la incremental science debba essere considerata come qualcosa di rinunciatario: anzi, «l’ideale», si legge nell’articolo, «è un mix salutare di ricerca incrementale e di ricerca disruptive».
Naturalmente, non tocca a noi spiegare come mai questo sia accaduto. E non saremo così presuntuosi da andare in corsia di sorpasso proprio dove Nature si ferma in corsia d’emergenza, concludendo di non avere certezze sulle cause di questo fenomeno. Tuttavia si possono azzardare tre osservazioni.
La prima è più ottimistica. Proprio la mole e la qualità disruptive delle spettacolari acquisizioni scientifiche avvenute in passato non rende facile compiere oggi nuove acquisizioni altrettanto forti e di segno profondamente diverso o addirittura diametralmente opposto. Banalizzando, è estremamente difficile - in ogni campo - replicare la portata di un rovesciamento da una visione tolemaica a una copernicana, per capirci.
La seconda osservazione è però assai più pessimistica. Forse a questa linea di prudentissima evoluzione, di approccio ultraconservativo - azzardiamo - può aver contribuito anche un forte grado di conformismo, specie in ambito accademico. Si può pretendere da tutti i giovani ricercatori l’atto di eroismo di andare controcorrente? Non è anche umanamente più facile muoversi su sentieri già tracciati e «sicuri»? Esempio: sarà più facile la carriera universitaria di un ricercatore che supporti le tesi maggioritarie in tema di climate change o invece quella di un suo collega che, per il solo distaccarsi dai sentieri più battuti, si veda subito scagliare addosso l’anatema e la scomunica come «negazionista climatico»? La sensazione è che in molti ambiti sia premiata più l’adesione a una tavola di valori generalmente accettata che non la propensione a nuotare controcorrente.
Comunque la pensiate, si arriva a una terza osservazione. Se - a torto o a ragione - l’approccio scientifico oggi prevalente è improntato a un cautissimo gradualismo, a una prudenza - ci fa capire Nature - forse perfino eccessiva, perché poi così tanti scienziati, quando entrano in contatto con i media, anziché restituire la dimensione (in quel caso sana) del dubbio, delle approssimazioni successive, del confronto tra tesi, accettano invece di farsi presentare come dei Mosè appena discesi dal Sinai con le tavole della legge? Se ci pensate, una delle cose culturalmente più devastanti avvenute nel triennio Covid è stata la quantità di volte in cui, perfino con nonchalance, un conduttore televisivo, dando la parola al virologo di turno, lo introduceva dicendo: «E ora ascoltiamo la scienza». Ma come? Se nel girone di andata (in laboratorio e nell’accademia) prevale la prudenza, perché in quello di ritorno (in sede di comunicazione all’opinione pubblica) si sceglie il dogmatismo e la tassatività? C’entrano sicuramente il sensazionalismo mediatico e la polarizzazione. Ma se siete tentati di evocare soprattutto il possibile uso politico di una posizione scientifica, rischiate forse di immalinconirvi, ma pure di azzeccare la risposta.