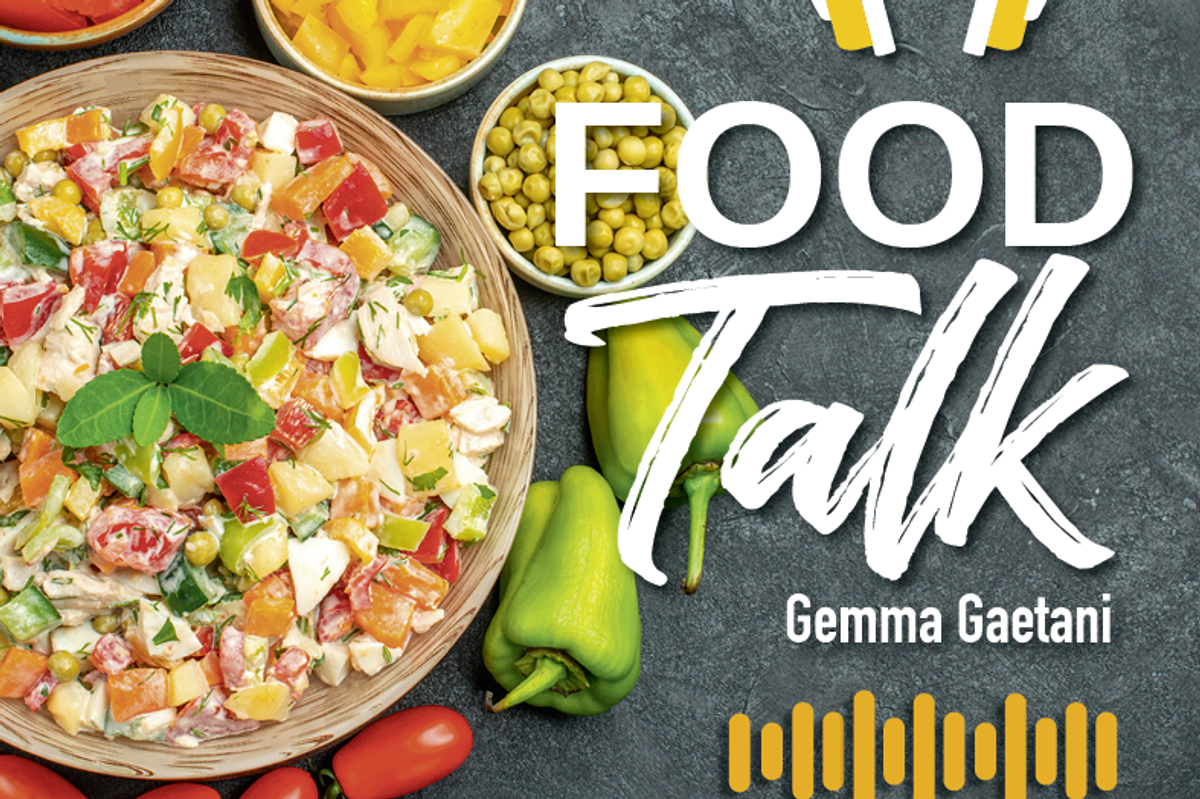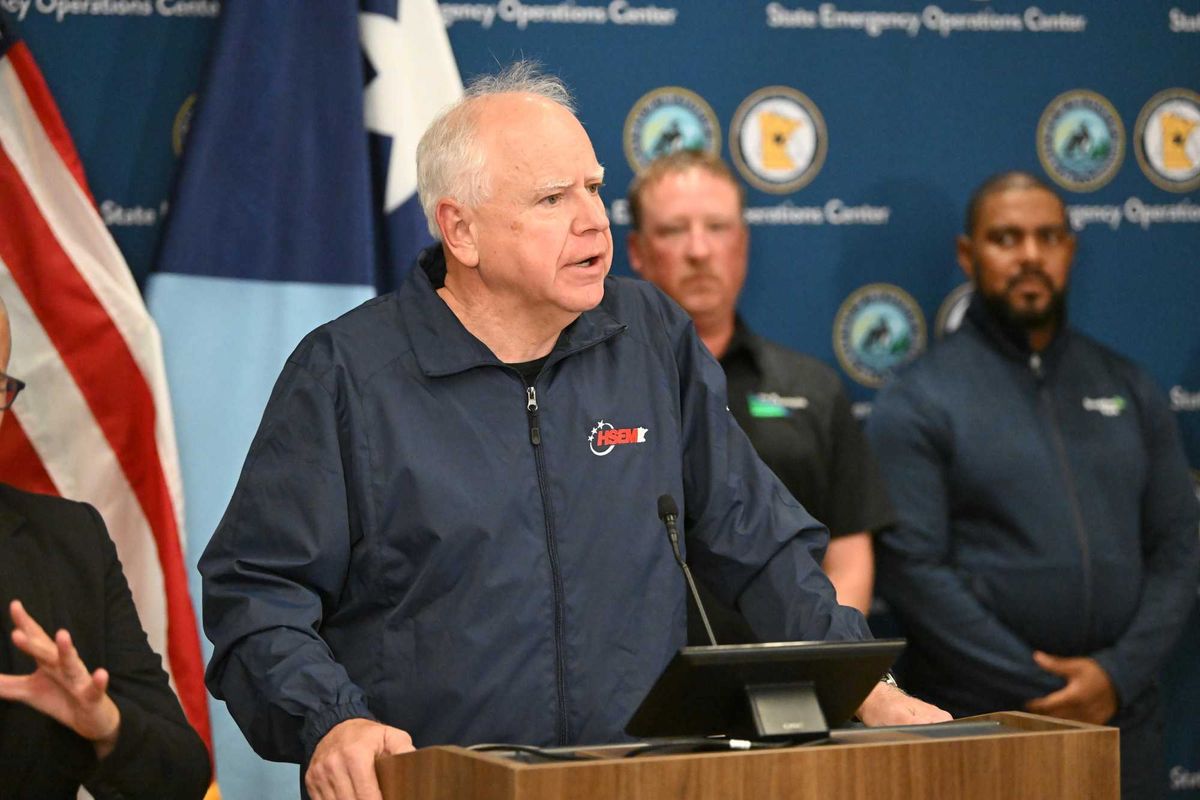Il Vaticano smentisce le fantasie di Scalfari: a «Repubblica» però se ne fregano

- La stampa internazionale racconta l'incidente sull'intervista al Papa che «cancella» l'inferno. In Italia, silenzio quasi totale.
- Micromega pubblica uno studio che svela dubbi e contraddizioni nel racconto del Fondatore. Già Italo Calvino lo aveva sgridato: «Smetti di dire che bisogna seguire la corrente».
Lo speciale contiene due articoli
Sparecchiava, forse, Eugenio Scalfari. Come nella insuperata scena di Amici miei, atto secondo. Sta di fatto che della smentita con cui il Vaticano (il Vaticano, non il bar all'angolo) ha completamente privato di senso l'intervista a Francesco pubblicata giovedì, su Repubblica di ieri non c'era traccia.
L'abitudine a travisare lievissimamente il pensiero papale pare invalsa nel fondatore: già nel 2013 ebbe a «dialogare» con padre Federico Lombardi, dopo aver scritto, il 29 dicembre, che Jorge Mario Bergoglio «è rivoluzionario per tanti aspetti del suo ancor breve pontificato, ma soprattutto su un punto fondamentale: di fatto ha abolito il peccato». Fu quella la prima eresia attribuita al pontefice argentino, e non era ancora arrivato il Sinodo. Il Vaticano, come due giorni fa, dovette per forza di cose correre al riparo e definire, con un certo understatement, «non pertinente» l'affermazione sul peccato. Del resto, oltre che con la misericordia, i toni bassi si giustificavano con il fatto che non puoi troppo squalificare un interlocutore che il tuo superiore (peraltro vicario di Cristo) ha così fortemente preso in simpatia da accordargli un'amicizia imprevedibile e sincera. Unica stoccata, allora, fu la frase: «Chi segue veramente il Papa giorno per giorno sa quante volte egli parli del peccato», seguita dalla considerazione che forse il giornalista «non si trova sempre a suo agio in campo biblico teologico», tanto da aver commesso una «inesattezza evidente» . Nello stesso articolo, in effetti, Scalfari ebbe a dire che il Papa era «gesuita al punto d'aver canonizzato pochi giorni fa Ignazio di Loyola», il quale salì all'onore degli altari nel 1622, una settantina d'anni dopo la sua scomparsa. Con piroetta da navigata ballerina, Scalfari tenne il punto evitando di ammettere lo sfondone: «Volevo segnalare che papa Francesco ha sottolineato l'importanza del fondatore della Compagnia di Gesù (...) Mi scuso per l'imprecisione lessicale».
Almeno, in tal caso, venne riconosciuta facoltà al Vaticano di parlare, e Repubblica diede conto della smentita. Stavolta, a fronte della dichiarazione vaticana secondo cui «nessun virgolettato» è da considerarsi come fedele trascrizione del pensiero di Bergoglio, nulla. Anche nel novembre 2013 e nel luglio 2014 due chiacchierate del Papa con Scalfari provocarono precisazioni di tenore simile, con il giornalista che si difese spiegando il suo metodo di lavoro (che non prevede di prendere appunti) e ammise che un po' di cose, insomma, non era certo di ricordarle esattamente, mentre altre «io glieLe faccio dire tra virgolette, Lei non le ha dette, ma io le ho incluse perché consideravo che, facendogli dire certe cose, il lettore poteva capire meglio chi è Lei». Anche in quel caso, comunque, Scalfari e il suo giornale in qualche modo reagivano alle smentite, ne prendevano quantomeno atto. Perlomeno la cosa faceva un minimo di casino.
Stavolta no: zero. Il precedente creato è che si può incontrare il Papa, mettergli in bocca delle eresie, e fottersene allegramente se il Vaticano dice - pure in modo cauto rispetto alla gravità dei fatti - che i virgolettati sono frutto di ricostruzioni, e dunque non riconducibili a Bergoglio.
Repubblica è peraltro in buona compagnia, se è vero che si contano sulle dita di un mutilato i giornali che hanno dato evidenza a un caso che, all'estero, ha registrato un'eco assai rilevante, dalle agenzie alle grandi testate (ieri era in prima sul Times, per dire), che hanno raccontato intervista, sbalordimento per la tesi sulla scomparsa dell'inferno, smentita e relativo, nuovo pastrocchio comunicativo in piena settimana santa.
I lettori italiani, salvo i nostri e quelli di Fatto, Foglio e pochi altri, di tutto ciò sono rimasti all'oscuro. Apprendevano dei crolli di calcinacci in San Pietro, dell'operazione alla cataratta che papa Francesco sosterrà nel 2019, ma non di un caso internazionale che vede coinvolti il pontefice, il diavolo e il decano dei giornalisti italiani. Probabilmente è una forma di tenera rimozione delle intemerate del venerabile cronista. Se è così, non la merita. Proprio perché Scalfari è un genio del mestiere, un fenomeno senza pari sia nell'editoria sia nel giornalismo in senso stretto: ha tempra e tigna da vendere a 93 anni, è reduce da un duello micidiale con il suo ex editore Carlo De Benedetti («Me ne fotto delle sue critiche», ha scandito in tv) e dà spettacolo anche, soprattutto con le sue roboanti puttanate. È cosa buona e giusta, pertanto, ricordare - restando confinati all'ambito ecclesiale - che Eugenio Scalfari nel 2007 ha scritto sull'Espresso che il libro del filosofo francese Jean Luc Marion aveva una «parte sostanziosa dedicata a una delle encicliche di papa Ratzinger», quando il testo risaliva al 2003, epoca in cui al soglio pontificio, a scrivere encicliche, c'era Giovanni Paolo II. Sempre di Benedetto XVI, Scalfari scrisse: «Non è un grande Papa, anche se l'ingegno e la dottrina non gli mancano: scrive bene, questo sì», bontà sua, ma è «lezioso». Il viziaccio si sarebbe manifestato nell'aver «riesumato in pieno la tomistica di Tommaso d'Aquino con tanti saluti a Origene, Anselmo d'Aosta e Bernardo». Ai sant'uomini, peraltro, Ratzinger dedicò, da papa regnante, fior di udienze generali, ma a questo livello evitare smentite è evidentemente parso un atto di minimale buonsenso.
Per il resto, ormai va preso atto che vale tutto. Ma al prossimo allarme sulle fake news montato da Repubblica è lecito scomodare di nuovo Amici miei, stavolta per parlare di purissima supercazzola.
Martino Cervo
Traballa pure la versione ufficiale sull’addio al fascismo di Barbapapà
Non è un buon momento per Eugenio Scalfari: bacchettato dal Vaticano per aver messo parole in libertà in bocca niente meno che al Papa, ora Barbapapà si trova a dover subire addirittura del fuoco amico su un vecchio nodo biografico mai sciolto: la sua giovanile adesione al fascismo.
Sul sito di Micromega, testata del gruppo Espresso, è infatti apparsa una ricostruzione del suo congedo dai ranghi mussoliniani sensibilmente diversa da quella raccontata dal fondatore di Repubblica stesso. L'autore della puntuale disamina storica è Dario Borso, studioso di Italo Calvino, che con Scalfari ha avuto una tumultuosa corrispondenza giovanile.
Già tempo fa, Borso aveva dimostrato come la pretesa scalfariana di aver esordito sulla carta stampata nella seconda metà del 1942, sulle colonne di Roma fascista, fosse in realtà contraddetta dalle lettere di Calvino, che all'amico rimproverava, senza lesinare irrisioni e insulti, di essere entrato nel «vivaio giovanile» del regime già nel febbraio del 1942, con articoli pubblicati su Gioventù italica e Conquiste d'Impero. Le nuove rivelazioni di Borso non hanno a che fare con l'inizio dell'attività giornalistica fascista di Scalfari, ma con la sua fine. Barbapapà ha raccontato di aver smesso la camicia nera dopo un incidente diplomatico accaduto a metà gennaio 1943. In un momento di assenza dei responsabili del giornale, Ugo Indrio e Regdo Scodro, il giovane Scalfari ne avrebbe approfittato per mettere in pagina, in un «neretto», un atto d'accusa contro i gerarchi che mangiavano sui cantieri dell'Eur.
Convocato dal vicesegretario del Pnf, Carlo Scorza, non potendo dimostrare chi avesse preso tangenti, fu cacciato come calunniatore. Questa fu la versione di Scalfari, che ovviamente, a posteriori, ne ha approfittato per dare a tutto il racconto un tono autoelogiativo a proposito del giovane puro cacciato dai burocrati corrotti, che così indirettamente gli mostrarono la realtà del regime. In una famosa intervista concessa a Pietrangelo Buttafuoco, Scalfari aveva descritto lo smarrimento provato dopo la sfuriata e il lento ritrovare sé stesso: «Avevo 18 anni e giorno dopo giorno prendo coscienza che forse avevano avuto ragione ad espellermi dal Guf. Forse non ero fascista». Troppo onesto, troppo amante della verità, troppo integerrimo per il fascismo, lui. Ma siamo sicuri che sia andata così?
Borso si è voluto documentare, ed ecco cosa ha scoperto: «L'unico numero di Roma fascista senza articoli di Indrio e Scodro è quello del 21 gennaio '43; né in prima pagina né nelle altre pagine di questo numero risultano neretti; in nessun numero di gennaio come dei mesi precedenti e seguenti c'è un minimo accenno ai lavori dell'Eur (tantomeno ai profittatori), per il motivo che essi erano fermi da un anno, e nessuno intendeva né poteva proseguirli, visti i rovesci militari. Che poi Scalfari, qualora espulso in gennaio, scrivesse sul mussolinissimo Nuovo Occidente fino al 19 giugno e su Roma fascista fino al 23 giugno '43, è fuori da ogni logica; e che infine lo tollerasse Scorza stesso, divenuto segretario nazionale del Pnf in aprile, è fuori da ogni grazia di Dio». Va da sé che mentire su quando si è diventati fascisti può essere una banale dimenticanza o un qualche vezzo in fondo innocuo. Falsificare le circostanze in cui si è cessato di esserlo è tutt'altro paio di maniche, soprattutto se poi, qualche anno dopo, si è diventati dei santoni dell'antifascismo. Quello scandalo, quindi, sembra che non ci fu. Quel dito nella piaga delle magagne del regime non venne mai messo. E, di conseguenza, non ci fu mai neanche quella lavata di testa, quelle mostrine stracciate dal bruto Sforza e quell'ostracismo contro il giovane cronista coraggioso. E allora come finì, il lungo viaggio di Eugenio Scalfari attraverso il fascismo? Forse in modo meno eroico, forse con un banale vivacchiare all'ombra del crollo del regime, chissà.
Di certo la sua militanza nei ranghi del giornalismo in camicia nera fu più lunga e articolata di quanto Barbapapà non abbia raccontato. Anche se, a giudicare dalle missive inviperite che gli mandava Calvino, non si trattò esattamente di un impegno disinteressato. Il 7 marzo 1942, così lo scrittore apostrofava il futuro fondatore di Repubblica: «Quando la finirai di pronunciare al mio cospetto frasi come queste: “tutti i mezzi son buoni pur di riuscire" “seguire la corrente" “adeguarsi ai tempi"? Sono queste le idee di un giovane che dovrebbe affacciarsi alla vita con purezza d'intenti e serenità d'ideali?». Evidentemente il tempo della schiena dritta e del giornalismo civile non era ancora venuto, per il giovane Scalfari. Di cui, tuttavia, ci restano gloriose prove giovanili, come l'indimenticato «Spiritualizzare la corporazione», uscito nel giugno 1942 su Conquiste d'Impero, diretto da Corrado Petrone, in cui leggiamo: «La battaglia spirituale è già stata iniziata, grazie all'opera e alle direttive precise del Duce, fin dai primi anni del fascismo. A noi spetta il condurla a compimento». A chi la coerenza, camerata Eugenio? A noi!
Adriano Scianca
- Scalfari intervista Francesco: "Il mio grido al G20 sui migranti ... ›
- Papa Francesco, Vaticano smentisce ancora Scalfari: "Nessuna ... ›
- Vaticano, Eugenio Scalfari si è inventato l'intervista con il Papa - Il ... ›
- Vaticano, papa Francesco smentisce l'intervista di Eugenio Scalfari ... ›
- PAPA FRANCESCO, VATICANO SMENTISCE INTERVISTA DI ... ›
- Eugenio Scalfari “bufalaro”: si inventa un'intervista a Papa Francesco ›
- Papa Francesco ha detto a Eugenio Scalfari che l'inferno non esiste ›
- CV Francesco Scalfari ›
- Scalfari e Francesco, la commozione di un illuminista inappagato ... ›
- Scalfari intervista il Papa Ma il Vaticano smentisce ›