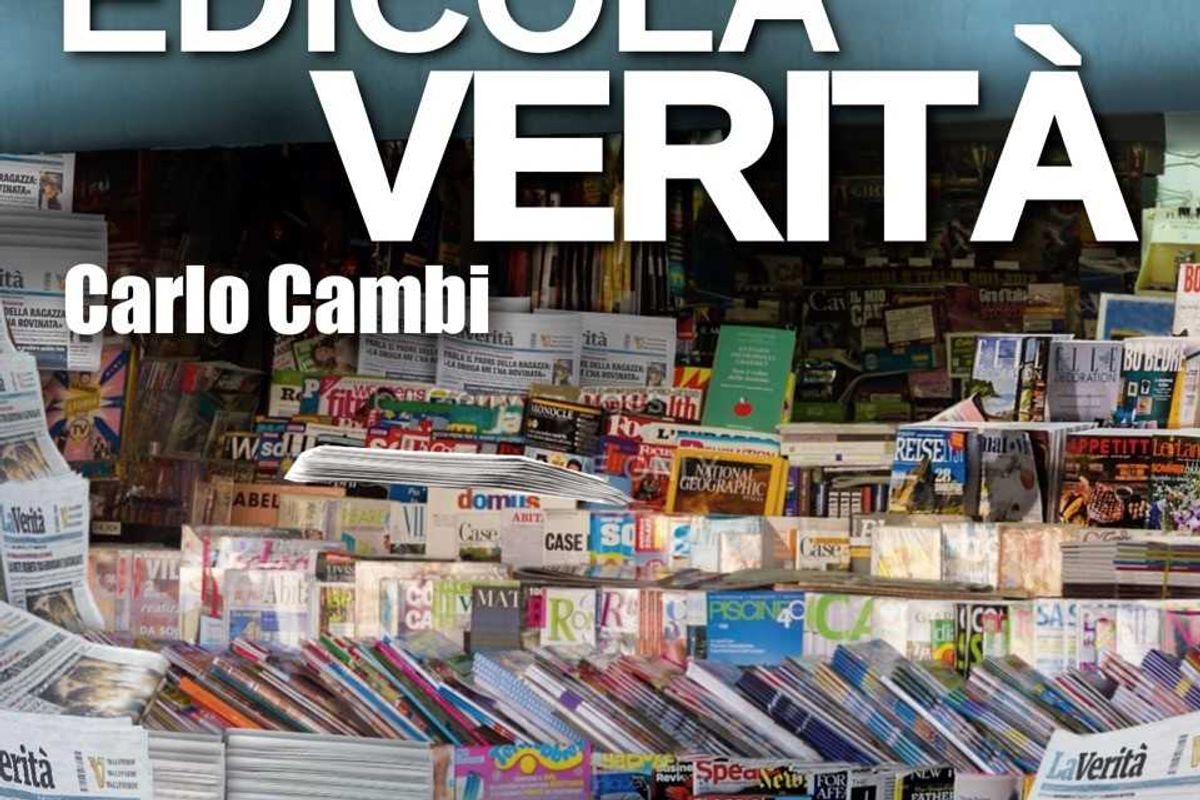«L’Epifania tutte le feste le porta via» recita uno dei proverbi più popolari liquidando in un amen le festività del periodo natalizio, il Capodanno e la Befana. Vade retro iperglicemia. Semaforo verde per insalate, moderazione a tavola e chili da smaltire. Ma sul serio noi italiani siamo così bravi? No. Nel sangue italico scorrono globuli festaioli: undici giorni dopo l’Epifania, il 17 gennaio, ci si rimette il tovagliolo al collo per celebrare Sant’Antonio Abate, il santo col porcellino, patrono degli animali domestici. I quali, in questa magica notte, parlano. Almeno così garantisce la leggenda.
Patrono pure di salumai, allevatori e macellai, Sant’Antonio Abate è uno dei santi più cari alla civiltà contadina. Ancora oggi, in moltissime chiese, i parroci benedicono il sale, focacce salate e dolci, pani particolari che poi saranno dati in pasto agli animali. Il 17 gennaio animali e umani fanno festa insieme nel nome del santo raffigurato fin dal Medioevo, nell’iconografia cristiana, con il maialino ai piedi. Ritenuto venerabile fin dai primi secoli cristiani, Antonio nacque in Egitto nel 251 dopo Cristo, visse da eremita fino a quando fu costretto dalla cerchia dei discepoli, che s’ingrossava sempre più, ad abbandonare la solitudine. Fondò una comunità della quale divenne abate. Morì nel 356 a 105 anni. È chiamato il santo del fuoco perché, Prometeo cristiano, scese all’Inferno per sottrarre un po’ di fuoco ai diavolacci e donarlo agli uomini. Tutt’altra cosa è il Fuoco di Sant’Antonio, infezione virale, herpes zoster, per guarire dalla quale un tempo si invocava il santo eremita.
Il giorno a lui dedicato, il 17 gennaio, è considerato il primo giorno di carnevale. È il giorno in cui tutta la golosa Penisola prepara piatti ghiotti e dolci tipici. Tutta roba che in teoria non c’entra con Sant’Antonio Abate che condusse vita ascetica, austera, resistendo alle tentazioni con cui il diavolo cercava di sedurlo e che Hieronymus Bosch, pittore fiammingo, rappresentò nel fantastico racconto del Trittico delle tentazioni di sant’Antonio. Eppure c’entra. Il suo giorno coincide con il periodo in cui i Romani celebravano riti propiziatori a Cerere, dea della terra e della fertilità, affinché facilitasse il passaggio dall’inverno alla bella stagione. Lo stesso facevano i Celti, caldeggiando con cerimonie rituali il ritorno della primavera. Il cristianesimo «occupò» queste feste pagane con il suo calendario e i suoi santi, Sant’Antonio Abate in primis.
Uno dei riti più suggestivi a lui dedicati si celebra a Mamoiada, nel cuore della Barbagia, dove i cupi Mamuthones, mezzo uomini e mezzo bestie col volto nascosto da terrificanti maschere nere, il corpo ricoperto di pelli di montone e con grappoli di campanacci (sa carriga) sulla schiena, percorrono le strade del paese ritmando una danza talmente antica che si perde nella notte dei tempi e dando inizio al carnevale barbaricino. Per tre giorni Mamoiada è illuminata da una quarantina di fuochi, uno per ogni rione, e per tre giorni i mamoiadini convivono con Mamuthones e Issohadores - personaggi positivi che indossano pantaloni bianchi alla zuava, giubbotto rosso, maschera bianca e cappello nero - bevendo Canonau e mangiando dolci tipici.
Spiega Pino Ladu, 45 anni, assessore alla Cultura di Mamoiada: «Con Sant’Antonio Abate inizia il carnevale. È la prima uscita dell’anno dei Mamuthones. È una festa sociale: per tre giorni la comunità vive davanti al fuoco benedetto. L’origine è pagana, un rito antico di passaggio stagionale rimodulato dal cristianesimo. Si mangiano su “popassinu nigheddo”, nero, fatto con sa sapa, il mosto cotto, e noci; su “popassinu biancu”, fatto con uvetta e coperto di glassa; le “caschettas”, pasta che avvolge ripieno di miele con zafferano e sapa, e su “coccone hin mele”, un pane dolce arricchito con miele e zafferano».
Anche in Romagna si usa il mosto cotto per preparare un pane fatto con farina, lievito, uvetta passa, pinoli, noci, cannella, saba e, rigorosamente, sale di Cervia, che il prete benedice passando di stalla in stalla o in chiesa. Pure il Vaticano si unisce a questa tradizione. Per la festa del santo, piazza San Pietro si riempie di mucche, pecore, galline, oche, gatti, cani e di cavalli «militari» bardati a festa. Tutti vengono benedetti da un alto prelato.
Sant’Antonio Abate è molto venerato nelle pingui campagne mantovane. Nelle stalle e intorno al Mincio è appesa, in protezione di vacche, vitelli e maiali, l’immagine del santo benedicente circondato da animali. Fin da bambini i mantovani imparano questa filastrocca che sembra croato, ma è dialetto gonzaghesco: «Sant’Antoni chisolér, al vegn al darsét da snér. Sensa chisöl a da so al solér». Traduciamo: «Sant’Antonio che cuoce la focaccia arriva il diciassette di gennaio. Senza focaccia crolla il solaio». Il chisöl è una focaccia dolce fatta con farina, lievito, burro, uova, zucchero. Il significato è chiaro: chi nel giorno del santo non rispetterà la tradizione di mangiare il chisöl intinto nel caffellatte o nel lambrusco (dipende dall’età) passerà grossi guai. Un altro piatto della tradizione lombarda, consumato soprattutto nel Milanese, è l’immancabile cassoeula, preparata con le parti meno nobili del maiale: cotenna, piedini, codino, orecchio, costine serviti con verze e cavolo. Anche in Liguria, nel Savonese, si cuoce un bollito, la zeaia, fatto con testina, costine, orecchie, piedini e codino.
C’è più rispetto per gli animali, nel giorno della loro festa, in Piemonte, almeno a Pinerolo, dove è ancora viva l’usanza di benedire il «caritun», un pane condito con pepe e sale e zafferano che si fa mangiare agli animali e ai cristiani ammalati. C’è chi giura che fa miracoli. Nel Biellese, a Galfione, frazione di Occhieppo Superiore, si prepara lo «scioet ad Sant’Antone», una polentina molto morbida arricchita di pezzi di toma magra, burro, carne di maiale rosolata e una macinata di pepe che trasforma la polentina in «scioet an peore».
A Collelongo, Comune abruzzese di 1.200 anime in provincia dell’Aquila, si stanno già scaldando le cuttore, pentoloni posti sopra fuochi di legno di ginepro, per cuocere il 17 gennaio i «cicerocche», granturco che viene lessato e poi passato in padella con olio e peperoncino. A Campobasso, capoluogo del Molise, il piatto della festa sono i Cavatiell, tracchiulell e carn e’ puorc, e cioè i cavatelli con le costine di maiale e sugo preparato con parti nobili del porco: polpa, pancetta, salsiccia.
Il viaggio nella gastronomia legata alla festa di Sant’Antonio Abate potrebbe durare ancora a lungo toccando la Toscana - dove, tra falò e benedizioni, si mangiano i più disparati prodotti maialeschi tra i quali spicca il lardo di Colonnata; l’Umbria - dove a Santa Maria degli Angeli si mangia il Piatto di Sant’Antonio Abate (maccheroni, due fette di carne in umido, quattro salsicce, due polpette), in onore del santo che a metà dell’Ottocento fermò un’epidemia che colpiva uomini e cavalli. Lo concludiamo in Campania con un dolce amputato… dall’igiene: il migliaccio. La tradizione contadina pretenderebbe l’aggiunta di sangue di maiale, ma questo è fuorilegge (come il sanguinaccio), così oggidì si fa con latte, ricotta, zucchero, uova, scorza d’arancio e di limone, aroma di fiori d’arancio, semolino e vanillina.