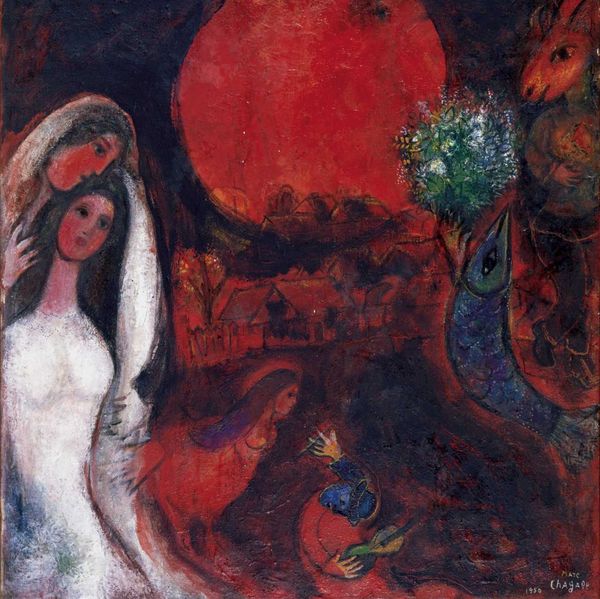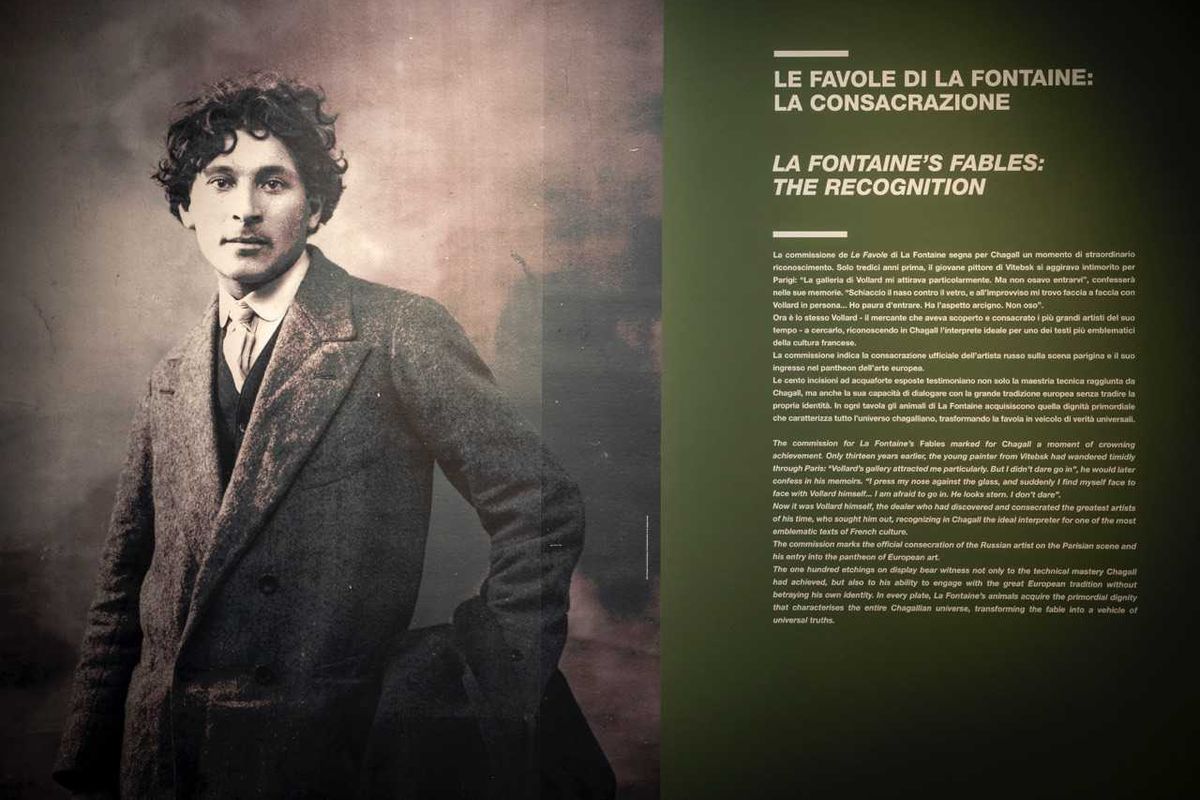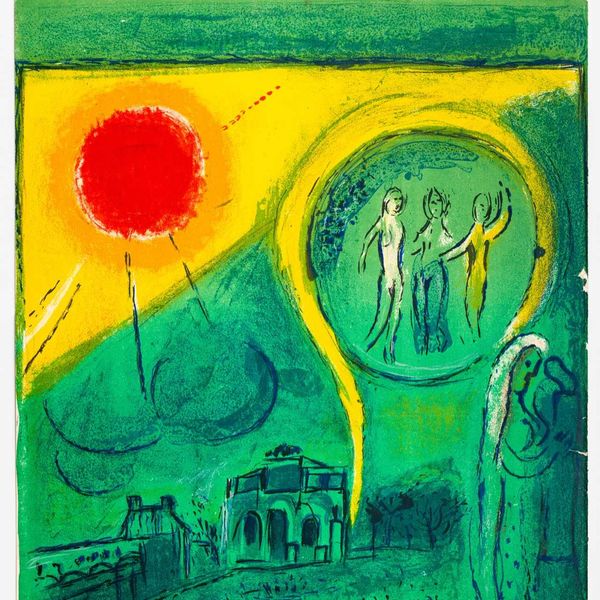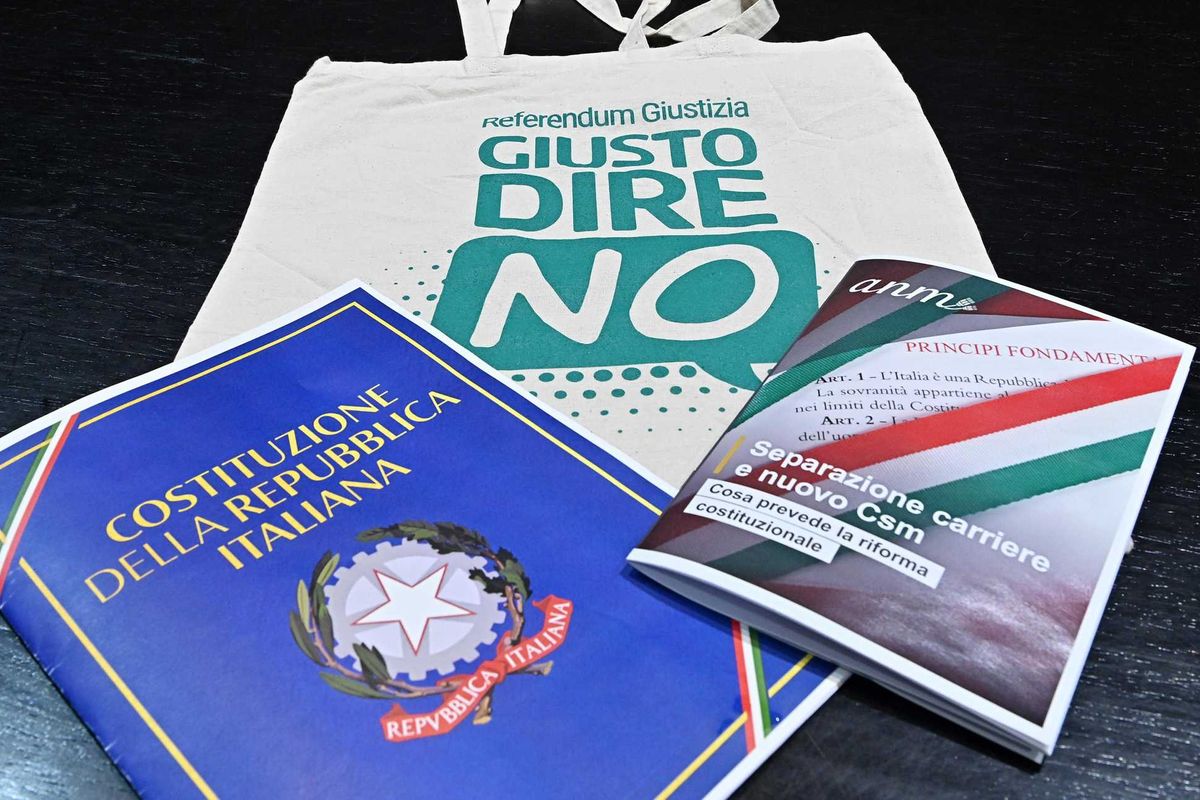Ogni epoca si caratterizza per alcuni tratti tipici, che la rendono unica nel corso secolare della storia. D'altra parte, ogni essere umano è unico e irripetibile, e anche ogni famiglia lo è. Ma pure ogni popolo, ogni società, ogni cultura degna di questo nome: il mondo è bello (anche) perché è vario. Ogni giorno che passa è diverso da quello che arriva, così come il nostro corpo impercettibilmente non cessa mai di mutare. E lo stesso vale per la nostra anima, che di esperienza in esperienza cresce e si sviluppa nel tempo e grazie al tempo che passa.
Anche le epoche storiche funzionano un po' allo stesso modo. I secoli precedenti alla venuta del Salvatore, pur dissimili l'uno dall'altro, hanno però tutti questa particolare nota spiacevole: l'assenza di un redentore, la mancanza di un esempio insuperabile e di un punto di riferimento assoluto e definitivo. I secoli successivi alla nascita e alla vita del messia sono tutti, lo sappiano o meno, illuminati dalla sua presenza spirituale e assiologica. I 2.000 anni dall'incarnazione del Signore in qua sono stati divisi dagli storici in epoca tardo antica, medioevale, moderna e contemporanea. L'epoca tardo antica è quella della prima diffusione del cristianesimo, durante le persecuzioni dell'impero di Roma. Ma anche quella gloriosa della freschezza del messaggio di Cristo, della virtù dei martiri e dell'evangelizzazione del mondo allora conosciuto.
L'epoca medioevale è senza dubbio l'apogeo della cristianità e dura circa un millennio. Anche se evidentemente non c'è un accordo perfetto sul suo inizio e sulla sua fine. Possiamo datarla dalla fine dell'impero romano d'Occidente (476 dopo Cristo) al 1300 o al più tardi alla scoperta dell'America da parte dell'eroico navigatore italiano Cristoforo Colombo (1492). L'epoca moderna comprende i secoli XV-XIX, mentre l'età contemporanea si impernia sul Novecento.
Tutte le epoche storiche hanno avuto grandezze e bassezze, ed esprimono contemporaneamente il genio dell'umanità con i frutti della ragione e della fede, ma anche la bruttezza del male, del vizio e dell'egoismo. Di certo però, l'epoca che simbolicamente coincide con la cristianizzazione della cultura, della società e delle istituzioni è quella medioevale, senza con questo voler demonizzare i secoli precedenti e successivi.
Papa Leone XIII (1878-1903) fu un pontefice colto e lungimirante, forse il primo Papa completamente moderno, con una profonda conoscenza della storia e della storicità (caducità) dei fatti umani. Con coraggio aprì gli archivi vaticani agli storici, fondando una autorevole Commissione cardinalizia per gli studi storici. Sul medioevo scrisse delle parole che si collocano agli antipodi delle caricature fatte dagli illuministi e dai riformatori. «Vi fu un tempo in cui la filosofia del Vangelo governava la società: allora la forza della sapienza cristiana e lo spirito divino erano penetrati nelle leggi, nelle istituzioni, nei costumi dei popoli, in ogni ordine e settore dello Stato (…). La società trasse da tale ordinamento frutti inimmaginabili, la memoria dei quali dura e durerà sempre, consegnata ad innumerevoli monumenti storici, che nessuna mala arte dei nemici potrà contraffare o oscurare» (enciclica Immortale Dei del 1885). E concludeva ricordando ciò che scrisse il vescovo Ivo di Chartres a Pasquale II: «Quando regno e sacerdozio (ovvero Stato e Chiesa) procedono concordi, va bene il governo del mondo, e fiorisce e fruttifica la Chiesa».
Ma quali sono i monumenti dell'epoca medievale che secondo Leone XIII restano immortali ad indicare l'armonia tra Stato e Chiesa, tra regno secolare e regno spirituale, e infondo tra scienza e coscienza, e tra ragione e religione? Si può pensare anzitutto ai tantissimi monumenti di pietra, come le bianche basiliche e le maestose cattedrali che in quei secoli hanno impreziosito in modo indelebile il nostro antico continente europeo. Ma la pietra è contingente e può crollare, lo spirito invece no. Il millennio che va da Benedetto da Norcia (480-547) a Bernardino da Siena (1380-1444) è stato il millennio della santità e della fede che sposta le montagne. Il motto del medioevo potrebbe essere questo: Dio al primo posto, l'uomo al secondo!
Ogni epoca ha avuto i suoi santi e ogni secolo ha figure di straordinaria grandezza. Il Novecento, pur così laico e secolarizzato, ha avuto un Padre Pio da Pietrelcina che ricorda nello spirito, nel tratto e nel misticismo, il fiore del medioevo italiano: Francesco d'Assisi (1181-1226). Ma il medioevo, come ricordava la citazione, è stata un'epoca di santità sociale culturale e politica, e proprio per questo i protestanti, gli illuministi, i marxisti e i modernisti non l'hanno mai amata. Perfino un autore onesto come Indro Montanelli osò intitolare una sua opera L'Italia nei secoli bui (1965). La storiografia recente e scientifica però ha fatto progressi e oggi molti conoscono la verità. Un faro fu acceso da Régine Pernoud col celebre saggio Luce del medioevo (1954). Ma solo ora possediamo delle opere veramente analitiche, complete e non più manichee che sanno cogliere l'essenza di quei secoli non nel relativo progresso tecnologico rispetto ai tempi, ma nello spirito medioevale. Se la tecnologia era ai primordi della sua avventura moderna, la sapienza dei medievali si espresse in figure che sfidano i secoli come Tommaso d'Aquino (1225-1274) o Bonaventura da Bagnoreggio (1221-1274). Ma anche nell'arte di Giotto, nella poesia di Dante, e in mille opere e realizzazioni come la prima fondazione di ospedali e università.
Anche le altre istituzioni tipicamente medievali sono da evocare e rivalutare. La cavalleria (lodata da san Bernardo), il feudalesimo e il monachesimo furono i tre assi portanti di quei secoli di fede e di misticismo. Di queste tre istituzioni mal conosciute parla un libro che fa rivivere il medioevo cristiano in tutto il suo splendore e che come tale è consigliabile a tutti coloro che tengono all'identità, al sapere e alle radici cristiane della nostra cultura (Umberto Benigni, Storia Sociale della Chiesa. L'Apogeo, edizioni CLS, 2018).
L'autore, un sacerdote e un amante della cultura medievale, individua questo rapporto tra il medioevo cristiano e l'epoca nostra: «Il trascendentalismo della mentalità medievale consiste in una tendenza a considerare tutto da un punto di vista assoluto, superiore, trascendente. È l'opposto della mentalità pratica, ristretta di visione e di scopo che distingue il moderno tecnicismo. Il pensiero medievale amava veder tutto sub specie aeternitatis». Tutta la realtà, letta e valutata anzitutto dal punto di vista di Dio e delle leggi naturali da lui istituite. In questo senso specifico possiamo anche noi uomini del XXI secolo essere profondamente medievali. Non servono i castelli, le dame, i giullari, i menestrelli e cattedrali gotiche.
Padre Agostino Gemelli è un celeberrimo sacerdote, psicologo e medico della prima metà del Novecento. Ha lasciato ai posteri delle Università e quasi 2.000 pubblicazioni che spaziano dalla storia alla mistica, dalla psicologia alla teologia, dalla medicina alla sociologia. Eppure, nel primo numero della rivista Vita e Pensiero (1914) l'editoriale dovuto alla sua penna è un Manifesto medievalista, che voleva contrapporsi al Manifesto futurista di Marinetti e gli altri, uscito poco prima. Gemelli lo pubblicò non per fermare il progresso ma per fermare il regresso, in nome della tradizione.
E l'attualità del 2019? Eccola. L'ecologia, l'animalismo, il vegetarianesimo, le medicine biologiche e il ritorno alla natura a cosa alludono, al di là della scorza laicista di questi movimenti sviluppatisi a sinistra nei dintorni del Sessantotto? Al ritorno a un rapporto più equilibrato con la natura e con gli animali? All'idea di sfavorire le megalopoli e i centri commerciali faraonici per rilanciare il patrimonio locale e paesano? Meno globalizzazione asfissiante e più borghi e comunità omogenee? Benvenuti nel medioevo prossimo venturo!