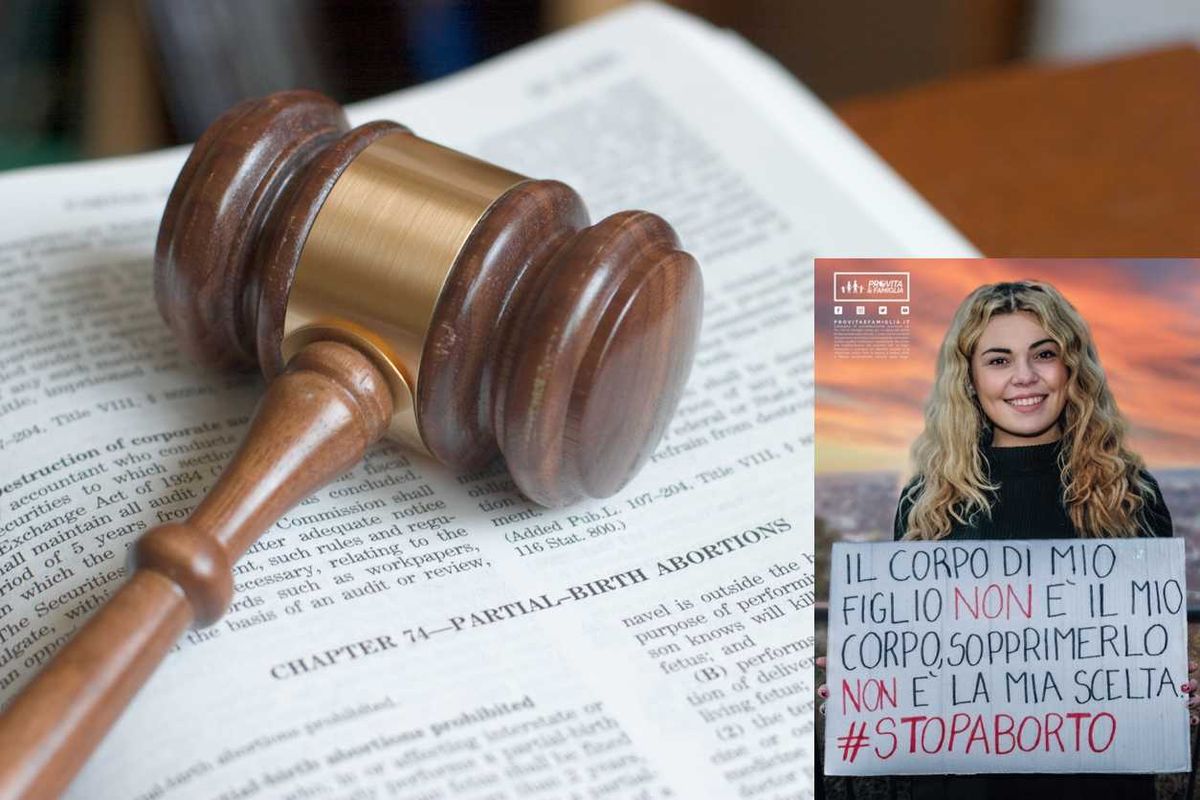«Ricevere la vita è un dono immenso per il quale è impossibile sdebitarsi»

Andrea Temporelli (Borgomanero, 1973) vive nella provincia novarese, a Borgomanero, dove è nato e dove insegna alla scuola secondaria. Cofondatore della rivista Atelier, attiva da 1996, è poeta e saggista. Tra le sue opere: Il cielo di Marte (2005, Einaudi), La buonastella (in Poesia contemporanea. Settimo quaderno italiano, 2001, Marcos y Marcos), Poeti nel limbo (2005, Interlinea), Terramadre (2012, Il ponte del sale), Tutte le voci di questo aldilà (2015, Guaraldi). La voce poetica è stata raccolta nelle più note antologie dedicate alla sua generazione. La nuova raccolta di poesie s’intitola L’amore e tutto il resto (Interlinea).
Nonostante una certa insistenza e diversi proclami nei quali sosteneva di volersi ritirare dalle patrie lettere, questa sua voce non ne vuole sapere di scomparire… Marco Merlin e il suo alias Andrea Temporelli continuano a scrivere, a comporre, a pensare, a meditare, a dire. Come nasce L’amore e tutto il resto?
«L’amore e tutto il resto è il lento e inesorabile formarsi di una costellazione. Solo adesso si è composta e posso leggere il mio oroscopo. Ho dovuto prendere coscienza di alcuni miti personali e fare i conti con loro. Adesso sono responsabile, artisticamente, della mia nascita. E, forse, sono più libero. Magari anche di scomparire davvero, chi può dirlo? In parte, però, il processo si è attuato: Marco Merlin non firma più nulla. Ora esiste solo Andrea Temporelli, che non è nessuno. Anzi, che è nessuno».
Dal 1996 ad oggi: ovvero dalla fondazione di Atelier, che ha riunito tanti poeti, ai nostri giorni. La poesia vale la pena di essere vissuta con tanta fiducia ed entusiasmo? Che spazio esiste attualmente in Italia per la poesia?
«No, la poesia non vale la pena di essere vissuta, nel nostro tempo. Chiunque sia in grado di smettere di frequentarla, è bene che lo faccia. Come quando per salvare un amore si deve dire addio a un amore. Lo spazio concesso alla poesia, in Italia, è quello del nostro ombelico. Ci vogliono produttori e consumatori allo stesso tempo, ingranaggi di un congegno autoreferenziale, esattamente come in una bolla “social”. E, in effetti, ci siamo tutti adeguati. Oggi persino chi ti cerca, chi ti manda dei testi, chi ti attribuisce un valore, solitamente ti sta soltanto usando come un mezzo per scavalcarti e, quasi certamente, nemmeno ha letto un tuo libro. Non esistono maestri, ma solo grimaldelli. Per questo i veri maestri si chiamano fuori… Chi resta dentro è un furbacchione che usa lo schema per rovesciarlo a suo favore».
Tornando a L’amore e tutto il resto ci sono due poesie che mi hanno colpito più di altre. La prima si intitola Le sillabe comete, inizia così: «Io non morirò mai / perché mi è già successo troppe volte / e se adesso mi uccidono / faccio finta di finire il film». Di che morte parla? Individuale o letteraria? Avrebbe voluto qualcosa in più da quel che ha ricevuto come poeta del proprio tempo?
«Tutti moriamo più volte, durante la vita. Per un grave lutto familiare, per un amore che finisce, per un fallimento esistenziale o lavorativo. Dobbiamo imparare a riconoscere queste morti per attraversarle e trasformarle in occasioni. Gli antichi, di fronte alla morte, rifuggivano verso la vita: “carpe diem!”, ovvero: “spassatela!”. Nel Novecento l’esistenzialismo ci ha piegati a “esseri-per-la-morte”, consegnandoci a un’angoscia perenne. Io penso si debba imparare a mettersi la morte alle spalle. Ho composto per questo un poemetto, Terramadre. Spero di essere all’altezza di quello che ho scritto, nel resto della mia vita. Pensa alla questione dei femminicidi: l’uomo, il maschio soprattutto, non sa più morire, nell’identità di coppia, e quindi, rifiutando la morte in sé e la possibile rinascita, proietta la morte persino sull’oggetto del proprio amore. Quando alla tua ultima, puntuta domanda, ogni artista credo sia perennemente insoddisfatto. Alla poesia ho dato molto di più di quanto abbia ricevuto, se devo misurare in termini “terreni”. Ma non voglio ammantarmi di nessun eroismo o autocompensazione ideale, quindi mi ripeto che è giusto così, che così deve essere. Lo scrivo nella poesia Calendario di buona fortuna. Se ami davvero, del resto, ami senza calcoli, senza che ci sia un riscontro. Ami persino ciò che lasci andar via… Così, se apro il mio libro e mi leggo, sento, al contrario, nella totale povertà e solitudine del poeta, di aver ricevuto e di ricevere molto, molto di più di quanto ho dato».
La seconda poesia di cui mi interessa parlare è Ninna nanna con esorcismo: è parte di una serie di componimenti rivolti o innescati dalla figura del figlio / figli, con una valenza multipla: il figlio del padre, il figlio che si è stati, il figlio d’inchiostro che scrive e in qualche modo prende distanza, si origina da noi e diventa qualcosa di distinto. Quanto è importante questa dimensione nella sua scrittura e nella sua esperienza?
«La paternità e la maternità sono la nostra primaria e naturale esperienza di compartecipazione alla creazione. Riceviamo un dono immenso, la vita, per il quale non possiamo sdebitarci, per cui rilanciamo il dono in avanti. La stessa dinamica, in fondo, avviene all’interno della creazione artistica: apparteniamo a una tradizione che ci forma, in essa diventiamo noi stessi, vogliamo testimoniare il dono a chi verrà. Naturalmente, c’è chi realizza questa dimensione al di là della stessa paternità o maternità effettiva. Anche chi decide di non procreare partecipa, a suo modo, del dono ricevuto e lo difende, seguendo il proprio destino».