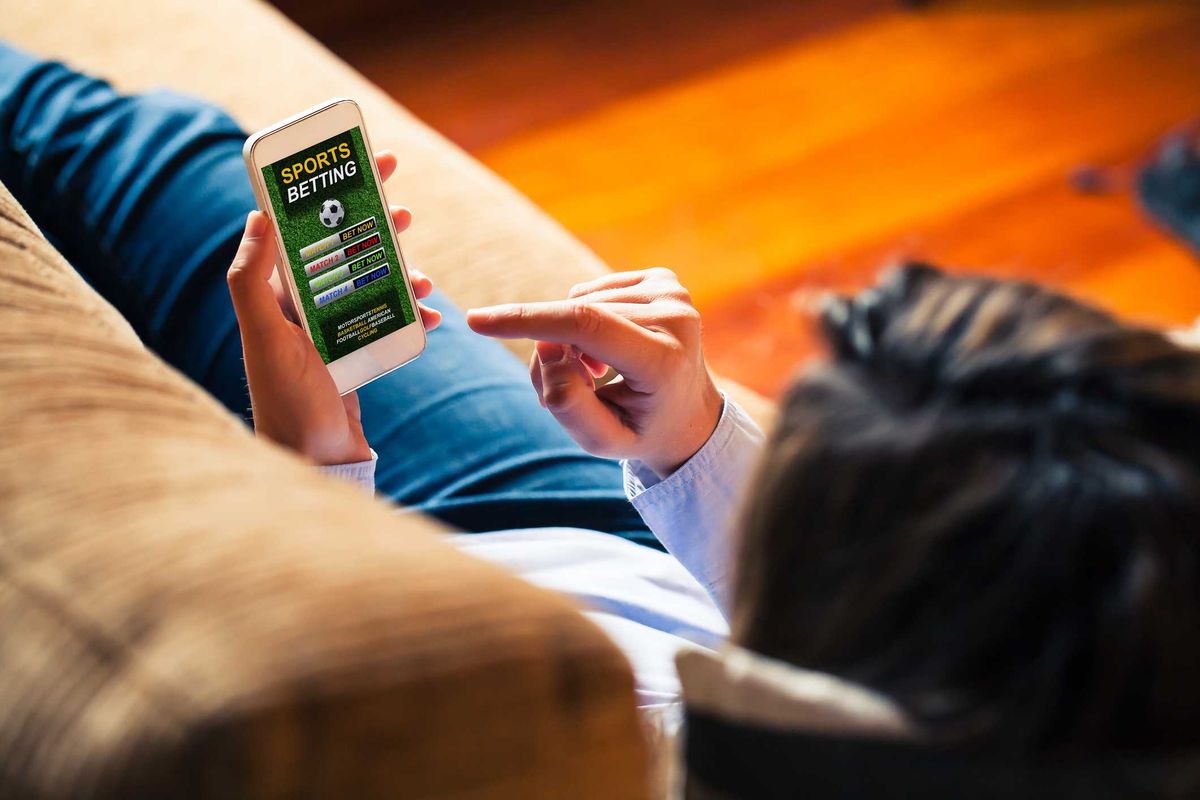2022-12-09
Radiografia di dieci anni di disastri Ilva
Dagli errori della confisca ai Riva allo stop alla produzione, fino allo scudo penale saltato e al contratto con Arcelor Mittal che non permette allo Stato il controllo prima del 2024. Ora il governo cambia le carte: bonifico da un miliardo ma per l’aumento di capitale.Quando fu inaugurato lo stabilimento tarantino dell’Ilva, allora di proprietà della Finsider, al Colle sedeva Giuseppe Saragat. Era il 1965 e fu lui a tagliare il nastro. Da allora il mondo ha visto l’allunaggio, il Web, i robot e l’intelligenza artificiale. Una linea retta verso la produttività e la crescita che ha plasmato un po’ tutto il territorio italiano ed europeo. Con una sola eccezione. Nel 1965 la capacità produttiva dell’Ilva di Taranto era di 3 milioni di tonnellate di acciaio, nelle sue diverse forme. La stessa azienda chiuderà il 2022, a 57 anni di distanza, non riuscendo a superare i 3,7 milioni di tonnellate di produzione. È il simbolo plastico di una strage industriale, di un decennio di errori iniziato con la confisca dell’impianto alla famiglia Riva, lo stop della produzione, la trattativa per la vendita ad Arcelor Mittal, l’abolizione dello scudo penale, la rinegoziazione del contratto con i franco indiani e lo slittamento a maggio del 2024 della data in cui lo Stato prenderà il controllo della holding a capo delle attività. Se siamo arrivati al pericoloso pantano attuale è perché in tutti questi anni si sono sommati gli errori senza mai cercare di prendere in pugno la situazione e inserire il polo produttivo nel contesto internazionale che andava a formarsi. Per un lungo periodo si è invece finiti in un buco nero e lasciato che le scelte della magistratura dettassero le linee industriali del Paese. Nei fatti tutto nasce nel 2011 quando il ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, mise mano a un ampio documento, oltre un migliaio di pagine, destinato a mettere ordine allo stabilimento e ridurre le emissioni inquinanti diventate nel frattempo insostenibili. Va detto che nei decenni precedenti, attorno all’impianto fu costruito un quartiere che a oggi ospita circa 18.000 abitanti. Una scelta folle di cui nessuno degli amministratori locali ha mai risposto in alcuna sede. Eppure all’indomani dell’emanazione dell’Autorizzazione integrata ambientale la risposta è arrivata dalla magistratura pugliese che, per tramite del gip di Taranto, ha disposto il sequestro dello stabilimento «senza facoltà d’uso». In pratica si è presa l’Ilva e la si è infilata su un binario con la premessa più sbagliata possibile. Si è messo a confronto la salute con il lavoro, presupponendo che si potesse scegliere solo uno dei due. Premessa sbagliata perché ha di fatto azzoppato un colosso che aveva sicuramente molte colpe ma che garantiva all’Italia un posto d’onore nel consesso del G7 e perché non ha rispettato le linee della Costituzione nella quale lavoro e salute sono messe allo stesso piano. Due concetti di semplice buon senso. Purtroppo perché l’impianto venga definito «strategico» bisogna aspettare un anno. Da lì gli altoforni ripartono anche se a singhiozzo e si susseguono numerosi custodi giudiziari da un lato e commissari dall’altro. Nel 2014 viene promulgato un nuovo piano ambientale, con un handicap di fondo. A gestire la baracca è il commissario Piero Gnudi e l’input del governo è vendere il tutto così come è. Non una grande idea se si vuole ottimizzare quello che resta e riparare ai danni precedenti. Cambia governo e cambia commissario. Con Matteo Renzi, Ilva spa viene finalmente posta in procedura di amministrazione straordinaria. Renzi, bisogna dargli atto, capisce che spetta allo Stato sistemare la produzione e l’ambiente soltanto dopo vendere gli asset. Nel frattempo nonostante l’impianto sia tornato a poter produrre 10 milioni di tonnellate deve tenere il freno tirato: non può superare i 6 milioni per via delle norme ambientali successive. E quindi via di cassa integrazione. Una premessa che non ha aiutato la fase successiva dell’impianto. Se ne va Renzi e arriva Paolo Gentiloni. Sempre con il freno tirato si decide però di mettere in vendita il gruppo. Si fanno avanti due cordate. Una guidata da Cdp, turchi, indiani e Arvedi e l’altra capeggiata da Arcelor Mittal, con la partecipazione del gruppo Marcegaglia. Da subito Renzi si dice contrario ai franco indiani ritenendo che la presenza tricolore sarebbe stata troppo leggera mettendo in pericolo la strategia nazionale. Eppure avviene il contrario. La cordata Cdp perde e vince l’altra. Offerta economica superiore a fronte di un bando per il 50% basato solo sull’entità dell’assegno. Dopo poco Marcegaglia si diluisce e perde il suo 15%. Esattamente il rischio previsto. Arcelor Mittal nel 2018 resta così sola a gestire gli impianti e a portare avanti la propria strategia. Che non è quella di rilanciare la produzione ma di affossare un Paese competitore. In più riesce a farlo con i soldi dei contribuenti italiani che nel frattempo vengono stanziati dal governo. A quel punto e, siamo nel 2019, se pensavamo di essere arrivati al fondo, il Movimento 5 stelle insegna agli italiani che c’è sempre la possibilità di scavare. In ottemperanza alle richieste dei commissari nel 2015 viene creato uno scudo penale che difende gli amministratori da illeciti ambientali compiuti nell’ambito di un percorso di bonifica. I 5 stelle alla fine del 2019 fanno saltare in Parlamento lo scudo penale (confermato da Conte e previsto a livello contrattuale) così Arcelor Mittal, dopo aver stappato una bottiglia di Champagne, prende la scusa per chiedere una revisione del contratto. Cosa che avviene e ci porta alla situazione attuale. Stato e Arcelor Mittal a dicembre 2020 pattuiscono una joint venture, fissando alla data di maggio 2022 la scadenza per il cambio di controllo. Cioè Il passaggio delle quote di Invitalia dal 38% di minoranza al 60 di maggioranza. Arrivati a ridosso della data, i franco indiani fanno di nuovo pesare i cambi normativi e ottengono una proroga di due anni. Il governo Draghi si beve la cosa e non fa nulla per cambiare la rotta. Nel frattempo vengono stanziati ben due miliardi. Uno per le bonifiche e l’altro per la società. Con un problema di fondo che l’attuale governo sta cercando di bypassare. A quanto risulta a La Verità è stato comunicato alla controparte che il bonifico non sarà più senza condizioni. Se Acciaierie d’Italia (questo il nome della joint venture) vorrà incassare i soldi dovrà ricapitalizzare e quindi per Arcelor Mittal significherà o scendere nel capitale o cacciare oltre un miliardo e mezzo per mantenere il controllo. Diversamente non si può fare. Palazzo Chigi e il ministero delle Imprese hanno le mani legate dal contratto. Un esproprio sarebbe una pubblicità così negativa da rendere l’opzione non percorribile. La palla passa nelle mani di Lucia Morselli. Inutile pensare che il presidente Franco Bernabè sblocchi la situazione. In tutto ciò abbiamo dimenticato la famiglia Riva. A Taranto la Corte d’Assise li ha condannati per reati ambientali, mentre a Milano li ha assolti per non aver causato alcun crac: l’accusa usata in sostanza per perpretare l’esproprio. Riavvolgendo il nastro come sarebbe cambiata la storia? Chissà. Sappiamo solo che Adolfo Urso, il ministro che ora guida la locomotiva, ha annunciato che Ilva è su un binario morto. Dovrà fare scelte drastiche per non deragliare.