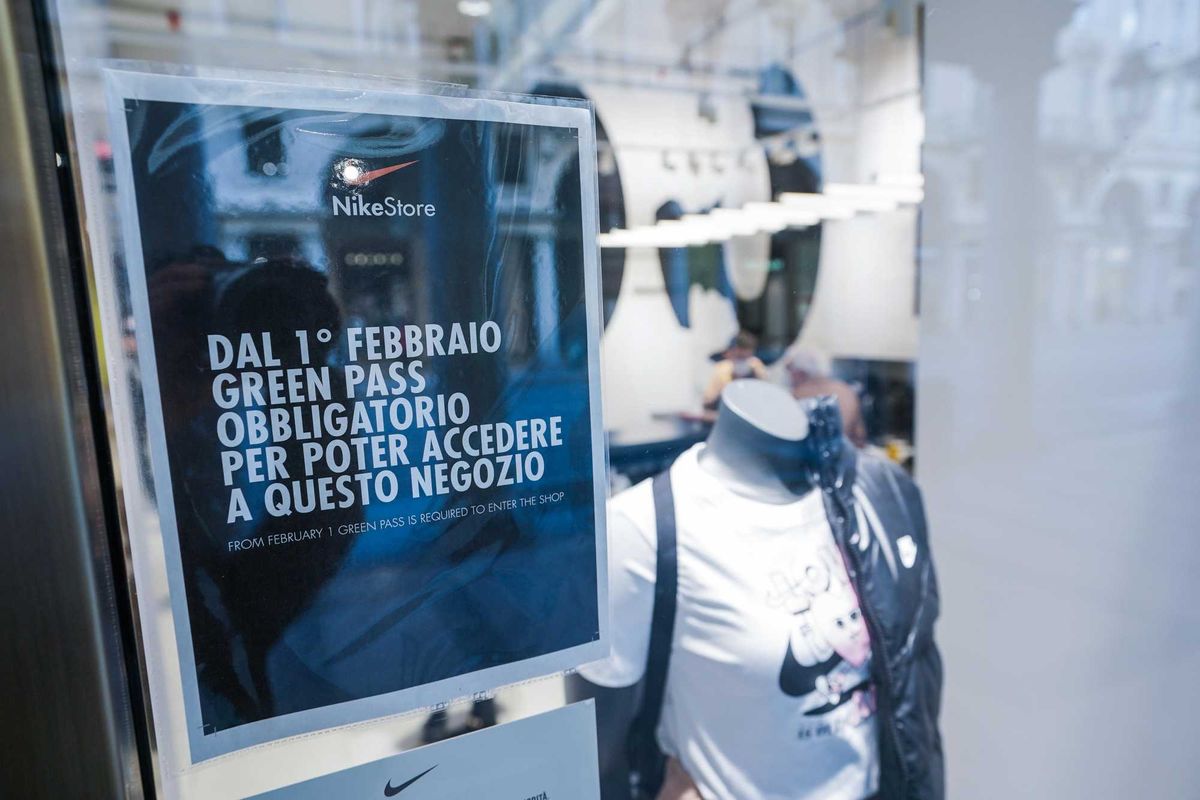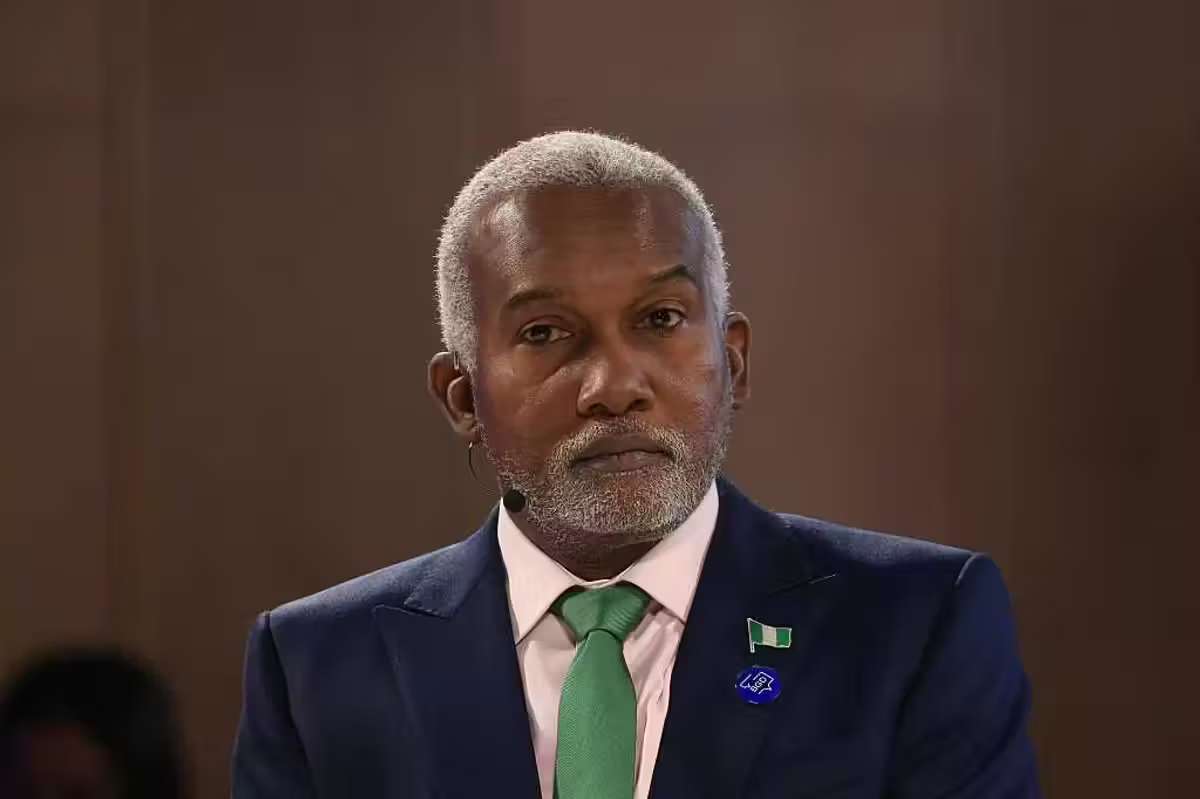La cremonese? Bella e buona. Un trionfo di rotondità e colori con un vispo caratterino. Ama sposarsi con partner tosti, sapidi. La vicentina, al confronto, è un po' più aggressiva e pungente. S'accompagna volentieri con caratteri forti, anche selvaggi, capaci di reggere la sua personalità. La mantovana è rinascimentale, aristocratica. Adora l'ambiverso, amaretto o dolce che sia. La bolognese è asprigna, ma estroversa, pronta ai matrimoni borghesi e a quelli contadini. Ogni riferimento è alla mostarda e ai cibi con i quali si abbina: formaggi, carni bollite, arrosti, selvaggina, tortelli di zucca, ravioli, dolci contadini. Alcune mostarde stanno bene perfino con i gelati.
L'Italia è ricca di mostarde, diverse - anche diversissime - l'una dalle altre. Proprio per la loro differenza vocabolari e ricettari faticano a catalogare la mostarda, preparato culinario al confine tra le salse, i condimenti e i dolci. Pellegrino Artusi, il biblista della gastronomia italiana, non sapendo dove collocarla nell'indice di La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene (1891) relegò la ricetta della mostarda all'uso toscano («eccita l'appetito e favorisce la digestione») nella sezione «Cose diverse», insieme con il caffè, al the e ai funghi sott'olio. La stragrande maggioranza degli italiani quando pensa alla mostarda la vede sottoforma di frutta- intera o a fette o pestata- sposata a cotechini, zamponi, lingua bollita, cappone. O maritata a formaggi saporiti: grana, caciocavallo, provolone, bagoss, pecorino, asiago e avanti popolo.
La mostarda, come la intendiamo noi oggi, nasce negli ultimi due secoli del medioevo e sale con un'identità già sua sulle tavole dell'era moderna. I primi riferimenti storici risalgono alla fine del 1200. Il liber de coquina nato alla corte angioina di Napoli, sollecitato con tutta probabilità dallo stesso Federico II, tratta de musto et mustarda e insegna la ricetta per preparare il composto lombardico: mosto bollito e semi di senape da lavorare insieme e conservare in una piccola botte per quattro mesi prima di usarla come salsa su carni di maiale o sulla tinca sotto sale. Di mostarda parla un testo francese del 1288. Il nome nasce dall'unione di due parole latine: mustum ardens. L'«ardente» è riferito sia al mosto bollente, sia, soprattutto, al mordace sapore del composto, dovuto ai semi di senape che infiammano la bocca. A questo punto s'impone una distinzione tra mostarda italiana e gallica, anche se l'origine del nome è comune. I francesi chiamano moutarde la pianta della senape, la senape e, per estensione, tutti i prodotti senapati. La nostra mostarda, invece, è, nella versione più conosciuta, a base di frutta con l'aggiunta di zucchero ed olio essenziale di senape.
Il primo uso che si fa del mustum ardens riguarda la conservazione dei cibi. Della frutta, innanzitutto. Sciroppandola si poteva allungare la stagione di consumo di cotogne, pere, ciliegie, fichi e altri frutti. Anche di ortaggi come la zucca. Un'arte ben conosciuta nelle cucine conventuali del XIV secolo anche se i monaci non avevano inventato niente: già gli antichi romani, vedi Columella e Apicio, usavano il mosto addensato dopo lunga cottura ottenendo la sapa, o defructum, per conservare mele, more, fichi. Era un uso che non prevedeva l'impiego della senape, adoperata piuttosto per la preparazione di salse e conosciuta per le proprietà digestive. Plinio il Vecchio consigliava di frantumarne i semi con pinoli e mandorle tritate.
Grazie alla senape e all'aggiunta di zucchero e spezie come la cannella e i chiodi di garofano, la mostarda veniva utilizzata per conservare le carni, oltre che per insaporirle. Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano dal 1395 al 1402 non aveva dubbi sulla mostarda da scegliere e come impiegarla. Goloso della frutta candita e senapata, se la faceva arrivare da Voghera. Nel dicembre del 1397 spedì un'epistola al podestà del paesotto dell'Oltrepò pavese, raccomandandogli di far preparare allo speziale «Petrus de Murris uno zebro grande de mostarda de fructa cum la senavra cum lu sa fare che la piace alla illustrissima madonna nostra consorte (Caterina) e a tucti li familiari et che la sia cume semper stata bona che bone fa le robbe de lo disnare et li caponi el la cacciagione et li viteli boliti et allo spiedo. Haremo gratissimo questa mostarda che ve racomandemo de mandare in persona prima de Sancto Natale».
L'epistola del Visconti è un punto di riferimento per la storia della mostarda e delle tradizioni gastronomiche. Innanzitutto ci informa che già 623 anni fa si abbinava la mostarda con bolliti e arrosti. Secondo: era considerata dai signorotti medioevali - il popolo non poteva permettersela - cibo rituale natalizio, una tradizione arrivata fino ai nostri giorni: non c'è pacco regalo natalizio che tra un pandoro, uno spumante, una confezione di lenticchie e un pezzo di grana non presenti anche un vaso di mostarda. Interessante, infine, il cenno allo «zebro», cioè alla botticella che conteneva la mostarda. Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, prima dell'avvento dei supermercati e del confezionamento industriale degli alimenti, non c'era negozietto alimentare che per Natale non esponesse un mastello di mostarda cremonese a frutti interi e coloratissimi da vendere sciolta, a peso, nella carta oleata.
I ricettari del '400 traghettano la mostarda dal medioevo al rinascimento. Maestro Martino, l'Enrico Crippa del 15° secolo, cuoco del patriarca di Aquileia, famoso in tutta Europa, nel Libro de arte coquinaria suggerisce tre ricette di mostarda, ma sono, più che altro, salse per insaporire i cibi: la prima è generale (senape, mandorle, aceto, mollica di pane bianco), la seconda, mostarda roscia o pavonaza, conta tra gli ingredienti anche uva passa e cannella, la terza è una mostarda da viaggio, da portar in pezi cavalcando: polpette con senape, uvetta passa, cannella e chiodi di garofano da stemperare con aceto o vin cotto.
Sull'insegnamento di Martino si muovono i cuochi e i cronisti che non disdegnavano di intrecciare la storia con la gastronomia. Brillano, tra loro, due scrittori nati e cresciuti in terre dove la mostarda è una religione: il cremonese Bartolomeo Sacchi, detto Platina, che fu dopo la metà del '400 al servizio di due papi, e il mantovano Teofilo Folengo, il Dante Alighieri del latino maccheronico. Il primo parla della mostarda nel De honesta voluptate et valetudine, il secondo descrive nel Baldus la teoria di piatti serviti in un banchetto reale: «lexi, rostum, pernas (prosciutti), fasanos, caprettos, lepores...» accompagnati dalle salse più svariate, tra le quali la mostarda «quae per nasum mittit senapram». Che manda, cioè, la senape su per il naso pungendo le mucose.
Oltre alle celebrate mostarde di Cremona e Voghera (a frutta intera), di Mantova - fatta, quella tradizionale, con le sole mele campanine - e Vicenza, godeva un tempo di buona fama anche la mostarda di Carpi. Era degna del desco papalino. Il modenese Alessandro Tassoni ne La secchia rapita (1621) testimonia che a un alto papavero della corte pontificia furono donate «due cupelle di mostarda di Carpi isquisitissime».
E le mostarde dell'Italia del Sud? Invertono la rotta, tendenzialmente, verso il dolce. In Puglia chiamano mostarda una confettura d'uva. La mostarda siciliana è un dolce gustoso e aromatizzato a base di mosto cotto e farina di grano duro. Sempre in Sicilia, a Militello, la si produce col succo dei fichi d'India e viene celebrata a ottobre in una sagra. Da non dimenticare i mustazzoli preparati con farina e miele o con mosto caldo dal quale prendono il nome. La mostarda calabrese è un antico dolce al cucchiaio che si prepara nel periodo della vendemmia: mosto cotto, farina, una spolveratina di cannella e frutta secca varia.