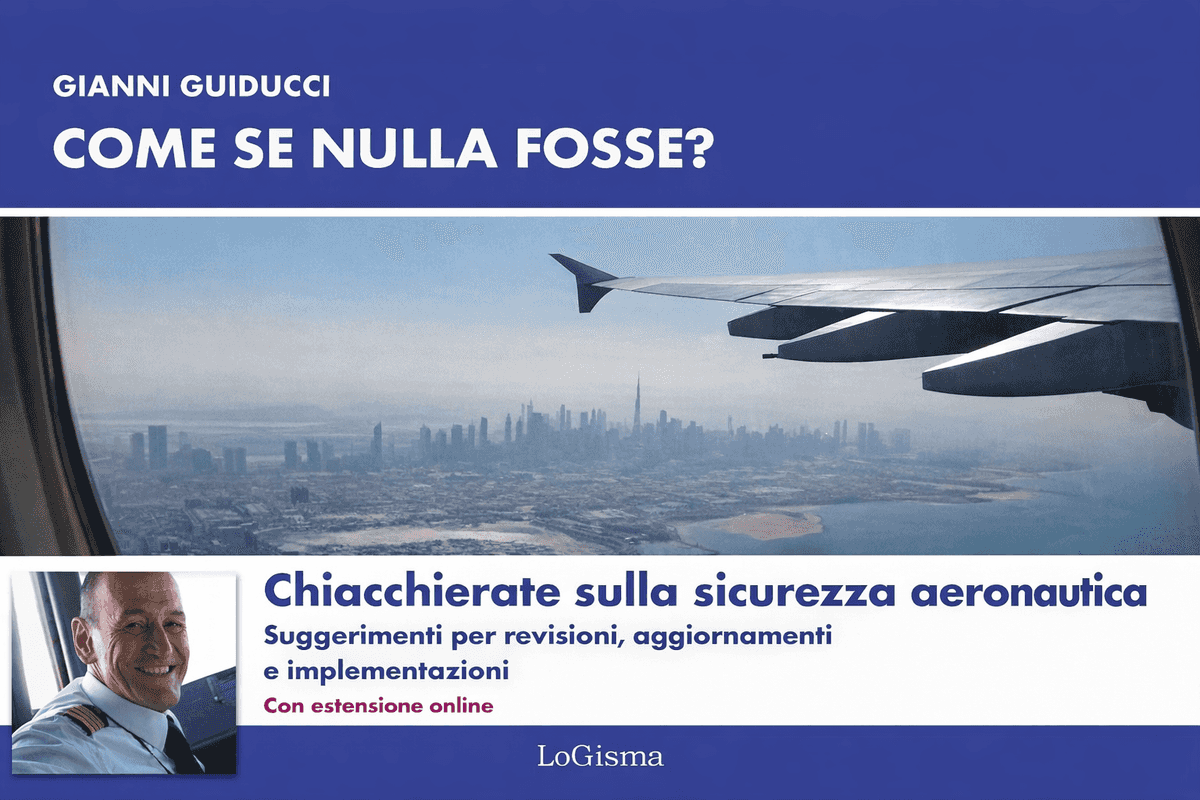L'Italia è un Paese dalla lunga storia, frutto di contaminazioni con culture diverse. È curioso notare come molte elaborazioni, che noi diamo per acquisite, abbiano una matrice ebraica. In Piemonte questa presenza è stata importante, con la vicina Lomellina lombarda. Matrice comune l'allevamento dell'oca, con diverse elaborazioni arrivate sino a noi, anche se ormai il salame d'oca di Mortara, nel suo disciplinare Igp, prevede anche l'utilizzo della carne suina. Altra specialità il collo ripieno, che si può trovare in diverse varianti. Nella pianura lombarda i tortelli di zucca sono l'orgoglio di ogni campanile, eppure anche qua c'è lo zampino ebraico. I Gonzaga vollero per le loro cucine il meglio dei cuochi europei. Molti di questi erano giudei i quali, unendo alla tradizione della pasta sfoglia la loro cultura con la zucca protagonista, fecero sì che questa preparazione si diffondesse poi nel territorio.
A Venezia è sorto il primo ghetto europeo, nel 1516, e se a questo aggiungiamo gli importanti commerci di spezie con le rotte orientali, ci si spiega l'origine di molti piatti, a iniziare dalle sarde in saor (conservate sotto cipolla per l'alimentazione dei marinai in navigazione), ma arricchite con uvetta e pinoli, che incontreremo anche nelle carote sofegae. La tecnica del saor poi si diffuse anche a radicchio, zucca, scampi. Sarde in saor che lo storico Bepo Maffioli ricorda come simbolo della Festa del Redentore, la terza domenica di luglio. Oca protagonista anche a Nordest, con le gribole (la pelle d'oca fritta) intrigante contraltare ai ciccioli suini. Ma è lungo l'elenco dei piatti con la benedizione del rabbino, quali ad esempio in bigoli in salsa (con sardine e cipolla) o l'oca in onto, grande classico della bassa padovana. Zucca protagonista, fritta o desfada (una crema con zucchero e pinoli), per non parlare della suca baruca, una zucca marina di Chioggia, protagonista di un episodio delle Baruffe Chiozzotte di Carlo Goldoni.
Scendendo lungo la costiera adriatica una tappa d'obbligo è a Ferrara, le cui storie del ghetto sono state rese immortali dalle vicende dei Finzi Contini, raccontate da Giorgio Bassani. Qui troviamo lo storione del Po, le cui uova erano diventate oggetto di culto, in epoca rinascimentale raccontate da Cristofaro di Messisbugo, cuoco degli Estensi, e riprese poi, negli anni Trenta, da Benvenuta Ascoli, della Nuta, con bottega nel ghetto ebraico. Erano talmente ricercate da far concorrenza al più blasonato caviale ed esportate pure all'estero. Dopo varie peripezie la ricetta è giunta ai giorni nostri, come ben raccontato in un bel libro da Michele Marziani. La particolarità era che queste uova venivano cotte nel forno a fuoco bassissimo, sì da acquisire un intrigante retrogusto di nocciola. Un'altra storia curiosa è quella della spongata, o torta degli ebrei, tibuia, con capitale Finale Emilia. Un impasto di farina, burro e parmigiano. Era uno dei segreti custoditi con orgoglio dalle famiglie ebraiche, sino a che tale Mandolino Rimini, nel 1861, si invaghì di una ragazza cristiana. La famiglia di lui, contraria alle nozze, lo allontanò di casa e lui sostituì il grasso d'oca con il burro divulgando la ricetta della tibuia a tutto il territorio. Il foie gras d'oca è un patrimonio culinario che si ritrova in tutta la dorsale Nord appenninica, tanto da arrivare sino ad Ancona, dove si dice fosse complice d'alcova tra Giacomo Casanova e una fascinosa bellezza ebraica del luogo.
Scendendo in Puglia altra sorpresa. Qui le orecchiette con le cime di rapa sembra siano dovute a una riuscita contaminazione portata da ebrei provenzali nel medioevo. Uno dei simboli del cibo di strada siciliano è il pani cà meusa (il panino con la milza). Al tempo gli ebrei palermitani che lavoravano nei macelli non venivano pagati con moneta, ma con avanzi delle interiora. Da lì a inventarsi la golosità da passeggio il passo fu breve. A Roma c'è la più antica comunità ebraica del mondo occidentale. Con l'editto del 12 luglio 1555 Paolo IV istituì il ghetto, cui giunsero anche comunità in fuga dalla penisola iberica e dalla Sicilia. Molte le limitazioni. Era proibito l'uso di carni ricercate e anche sul pesce i paletti erano stretti. Far di necessità virtù divenne un imperativo quotidiano. Ecco allora affermarsi piatti senza tempo, come i carciofi alla giudia, la cui irresistibile croccantezza è dovuta ad un doppio passaggio in olio bollente, ma anche le melanzane fritte, le triglie alla mosaica (con uvetta e pinoli), gli aliciotti con l'indivia, il baccalà alla romana, fritto e ripassato in salsa di pomodoro e, ancora, la pasta e broccoli con il brodo di arzilla (razza), l'agnello alla giudia, con carciofi e fave. Ma era con le frattaglie che si conciliava il gusto con le penitenze imposte: ecco allora la milza in padella, le animelle con i ceci, la trippa con l'agliata. E pure sui dolci non si scherzava: su tutti il tortolicchio, considerato afrodisiaco, con mandorle, miele, anice e arancia e, ancora, la pizza di Beridde, con uvetta, frutta secca e candita e la nocchiata, una sorta di torrone di noci, mandorle e nocciole fritte nel miele.
Risalendo in Toscana il riferimento va a Livorno che, nell'Ottocento, diventò la più importante comunità ebraica nazionale. L'unica città che non volle mai istituire un ghetto, tanto è vero che vi giunsero molte famiglie in fuga dalle miserie romane. Baccalà protagonista, classico l'abbinamento con i fagioli. Alici a scapece, minestra di lenticchie, di contaminazione romana il pasticcio di cervella e carciofi. Il cuscussù è una rielaborazione frutto dell'arrivo di comunità in fuga dalla Sicilia che, a loro volta, avevano assimilato il cous cous arabo, cui venne aggiunto il locale rosmarino. Mirabile l'ode dedicata da Angiolo Oliviero, con un passaggio che la dice lunga: «Onde sentor d'Etruria / io colgo nel sapore dei deserti». Rosmarino anche in un'altra leccornia locale, i panini ramerini. Pare che lo zampino giudeo sia presente pure nella nascita del cacciucco, originariamente solo una zuppa di merluzzo, cui in seguito vennero aggiunti ingredienti non kosher, crostacei e molluschi: ecco che la comunità locale rispose arricchendolo con pomodoro e aromi vari.
Passando dalla costa tirrenica alla Toscana interna è un tripudio dolciario. Si potrebbe iniziare con Ortensio Lando che già a metà del Cinquecento segnalava come Jacob di Consiglio, il più importante banchiere ebreo di Siena, inviava del marzapane a Cosimo dè Medici, quale omaggio identificante che ben sottolineava, al ricevente, la qualità del donatore. Ma poi troviamo il biancomangiare, con latte di mandorle e riso o la pignoccata, con pinoli e cedro candito. Dna giudaico che incrociamo in preparazioni entrate stabilmente nei manuali di cucina: dallo scapece, pesce fritto poi marinato in aceto con spezie e aromi, al carpione, dove prima avviene la marinatura in salamoia con aceto, e poi la frittura. L'amatriciana (alla giudea) la si può gustare usando la carne di manzo al posto di quella di maiale e facendo un fioretto saltando il formaggio. Così pure la carbonara, rielaborata in due varianti. La si può servire bassari (a base di carne) sostituendo la pancetta con carne secca di manzo, uova e non formaggio, oppure halavi (di latte), carburata di grana e usando le zucchine fritte al posto della pancetta.