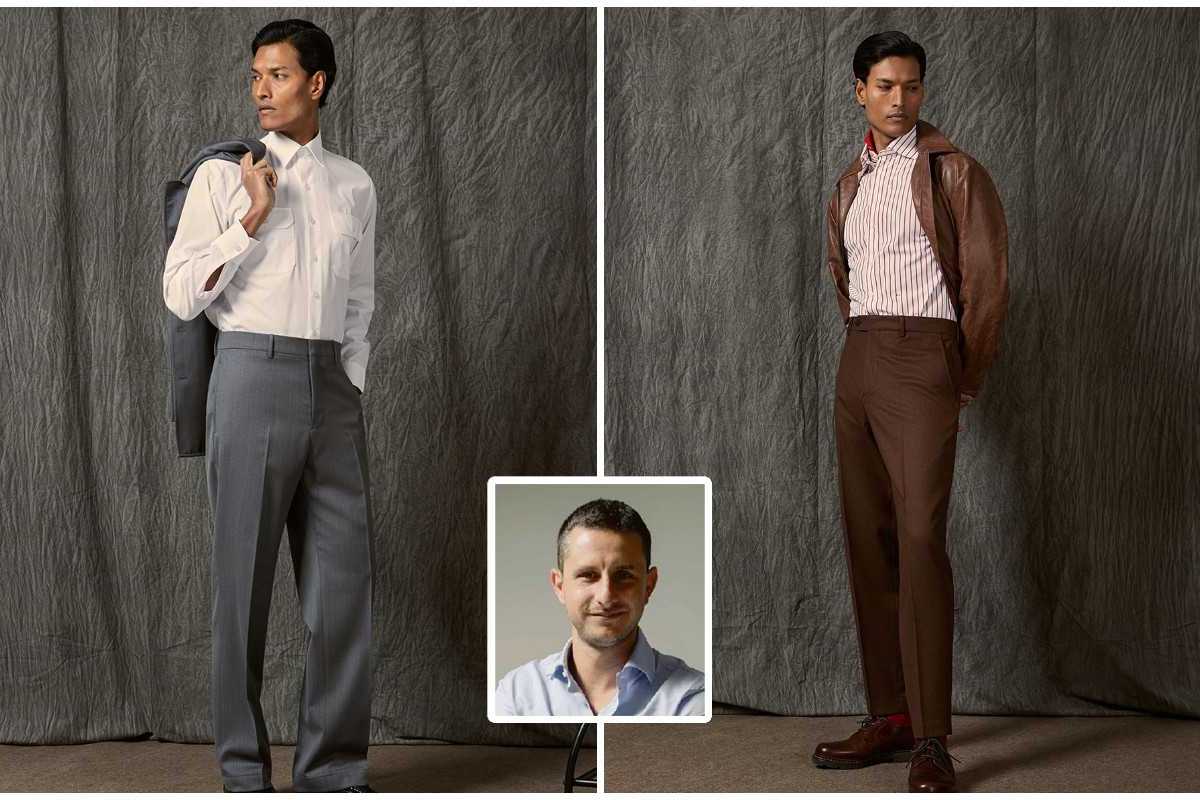Se tra i parlamentari dominasse, come sarebbe bello credere, un’alta coscienza della loro funzione, uno solo dovrebbe essere il comune criterio da seguire nella scelta dei quattro giudici costituzionali destinati a subentrare a quelli il cui mandato è scaduto o sta per scadere: il criterio, cioè, per cui requisito indispensabile dei nuovi giudici dovrebbe essere quello che siano tutti fermamente orientati verso una visione della Costituzione analoga a quella conosciuta negli Usa (ove attualmente prevale nella Corte suprema) come «originalista». Questa visione è fondata - in contrapposizione a quella definibile come «evoluzionista», da tempo dominante in Italia - sul principio che la Carta fondamentale vada interpretata per quello che originariamente si era inteso farle dire e non per quello che, ignorando o distorcendo, non di rado, il suo stesso tenore letterale, le si voglia far dire attualmente; cosa, questa, che equivale a trasformarla in mero strumento per dare una fittizia base giuridica a decisioni determinate, in realtà, da valutazioni puramente ideologico-politiche. Tra queste, ad esempio, le decisioni con le quali la nostra Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali, in tutto o in parte, norme come quella che sanziona penalmente l’aiuto al suicidio o quella per la quale il figlio nato in costanza di matrimonio assume automaticamente il cognome del padre.
Vero è che la visione «originalista» è generalmente ritenuta propria soprattutto della destra, per cui - potrebbe obiettarsi - non si vede per quale ragione le forze politiche di opposto orientamento presenti in Parlamento dovrebbero condividerla. A ciò può rispondersi considerando che dovrebbe essere l’intero Parlamento, al di là delle divisioni politiche, a rendersi conto della necessità di recuperare l’esclusività delle proprie attribuzioni, quale unico legittimo titolare del potere legislativo, a fronte della sempre più marcata tendenza della Corte costituzionale a esercitare anch’essa, in via di asserita supplenza, quel medesimo potere, così esorbitando dai limiti propri di un organo di mera garanzia, quale doveva essere nelle intenzioni dei Padri costituenti.
Manifestazione di detta tendenza è, ad esempio, quella costituita dall’essersi la Corte, da diversi anni, autoattribuito il potere, pur quando un decreto legge sia stato regolarmente convertito in legge, di dichiararne l’incostituzionalità, unitamente a quella della legge di conversione, per la sola ragione costituita dalla ritenuta mancanza, all’origine, delle condizioni di straordinaria necessità e urgenza richieste dall’art. 77 della Costituzione; condizioni la cui verifica, implicando valutazioni di natura politica, spetterebbe invece, in realtà, solo al Parlamento.
Altra manifestazione è quella costituita dalla ricorrente pronuncia di sentenze che vengono definite «additive», in quanto non cancellano la norma sospetta di incostituzionalità ma ne estendono l’applicabilità a casi originariamente non previsti che, invece, secondo la Corte, il legislatore avrebbe dovuto prevedere. La prima di tali sentenze è probabilmente quella, risalente addirittura al lontano 1970 e recante il numero 190, con la quale la Corte dichiarò l’incostituzionalità di una norma del codice di procedura penale allora vigente nella parte in cui non prevedeva che tra gli atti istruttori cui era ammessa a partecipare la difesa fosse compreso anche l’interrogatorio dell’imputato.
Da notare, tuttavia, che in quella occasione si manifestò una diffusa resistenza da parte dei giudici ordinari ad applicare la decisione della Corte, proprio perché ritenuta esorbitante dai suoi poteri e, pertanto, illegittima. La situazione fu sbloccata dal quasi immediato intervento del legislatore che modificò, con un apposito decreto legge, la norma in questione nel senso che la Corte aveva indicato. Ma va detto che a quell’intervento il legislatore non era in alcun modo obbligato, per cui, senza di esso, qualora la resistenza da parte dei giudici ordinari si fosse generalizzata, la decisione della Corte costituzionale sarebbe stata inevitabilmente destinata a restare lettera morta. Ciò vale a dimostrare che una efficace resistenza alle decisioni della Corte, quando questa esorbiti dai suoi poteri, come era possibile allora, lo sarebbe ancor oggi, essendo rimasto immutato, nel frattempo, il quadro normativo di riferimento; quadro che, in particolare, continua a comprendere anche il pressoché dimenticato e negletto, ma tuttora vigente, art. 28 della legge n. 87 del 1953, per la quale «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento».
Sta di fatto, però, che quel primo tentativo di resistenza, di cui si è detto, è stato anche l’ultimo, per cui la Corte costituzionale ha potuto impunemente non solo continuare a pronunciare sentenze «additive» della più varia natura, ma anche aggiungevi altri tipi di pronunce (sulle quali non è qui il caso di entrare in dettagli) sempre più lesive delle prerogative del Parlamento. E ciò avvalendosi anche, con sempre maggiore frequenza - sulla base di un’assai disinvolta interpretazione del principio di uguaglianza affermato all’art. 3 della Costituzione - dell’autoattribuitosi potere di giudicare della legittimità costituzionale o meno di una norma di legge a seconda che la stessa, a suo insindacabile giudizio, sia o meno da ritenersi «ragionevole». Il che (esempio fra i tanti) l’ha indotta, di recente, a inventarsi», letteralmente, con la sentenza n. 120/2023, l’attenuante del caso di «lieve entità» nel reato di estorsione, previsto dall’art. 629 del codice penale, ritenendo «irragionevole» che essa non fosse stata prevista dal legislatore nella formulazione di detto articolo; attenuante che, peraltro, si sarebbe, allora, dovuta estendere anche al reato di rapina, parente stretto dell’estorsione e punito con identica pena.
Negli ultimi anni, poi, la Corte, oltrepassando anche il limite della cosiddetta «soluzione costituzionalmente obbligata» che, in passato, si era sempre autoimposta, è giunta ad affermare, con la sentenza n. 99/2019 e numerose altre successive, che, qualora dalla ritenuta incostituzionalità di una norma di legge derivi un vuoto normativo, essa stessa abbia il potere di creare, per riempirlo, una nuova norma, operando a sua discrezione una scelta fra le varie soluzioni possibili, alla sola condizione che esse siano «costituzionalmente adeguate» e «si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore»; il che è quanto di più vago e generico si possa immaginale, per cui può dirsi che siamo quasi, ormai, alla completa esautorazione del Parlamento. Sarebbe ora, quindi, che quest’ultimo, come dicono a Roma, si desse una sveglia.
Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di cassazione