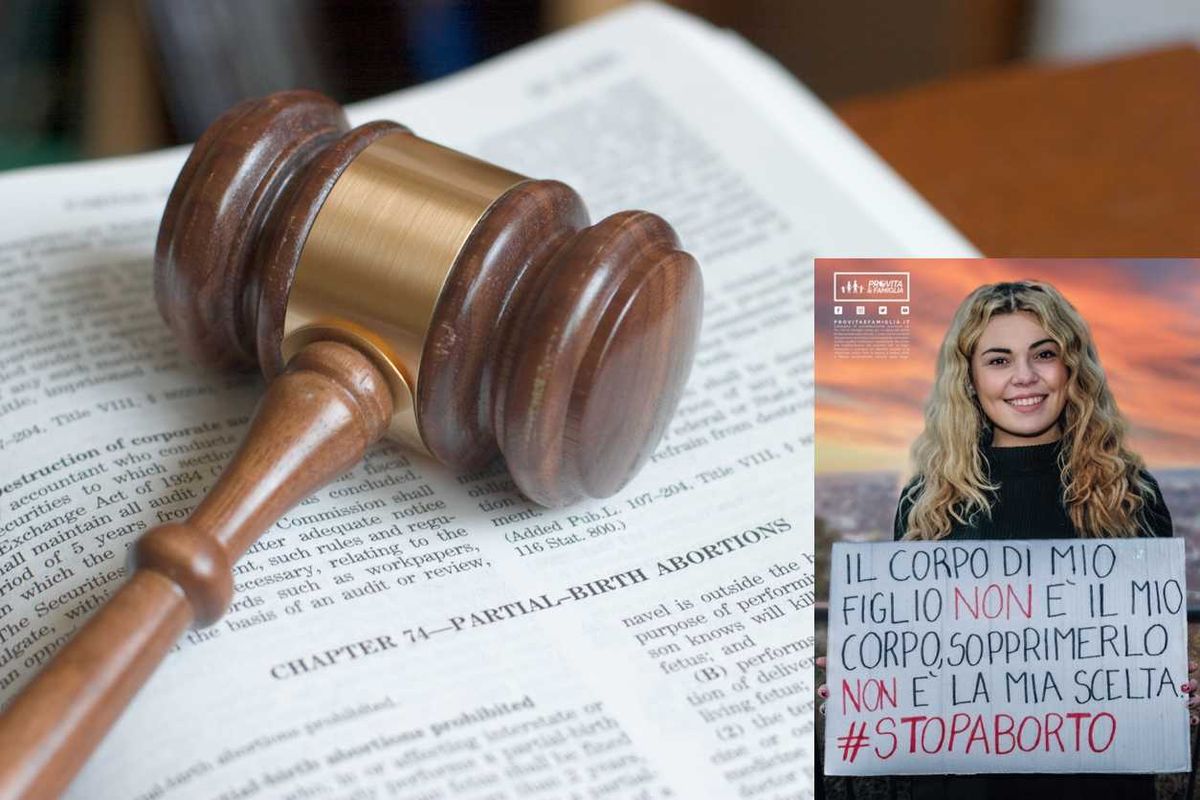L’antimafia dimenticata: la militanza a destra di Paolo Borsellino

Il giudice martire della mafia non ha mai rinnegato la sua adesione al Fuan durante gli anni universitari. E persino in uno dei suoi ultimi discorsi finirà per citare il fascista spagnolo José Antonio Primo de Rivera.
Il clamoroso arresto del boss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza ha riacceso i fari sulla mafia e riaperto la relativa polemica politica. La mafia è di destra o di sinistra? E l’antimafia? Messi così, i quesiti sono ovviamente senza senso: la mafia fa affari con chi può e l’antimafia ha avuto mille colori. Nessuno ne ha l’esclusiva. Una certa narrativa volta ad accreditare alla destra una maggiore inclinazione alla collusione mafiosa ha tuttavia spiccato il volo negli ultimi anni ed è riemersa anche in relazione all’arresto di Messina Denaro. Qualche anno fa fece scandalo, del resto, uno sceneggiato televisivo sulla mafia in cui un boss veniva ritratto mentre sfogliava un quotidiano di centrodestra. Come se fosse un automatismo. Ma è proprio così? Ci si dimentica, in realtà, di alcuni pezzi della storia. Del prefetto Mori, che pur non essendo fascista di suo fu comunque la clava usata dal Regime per dare alle cosche forse la mazzata più poderosa dell’intera storia italiana; ci si dimentica del giornalista Beppe Alfano, ex Ordine Nuovo e poi missino, ucciso dalla mafia nel 1993; ci si dimenticano, infine, le origini politiche mai rinnegate di uno dei più importanti martiri di mafia dell’Italia repubblicana, ovvero Paolo Borsellino.
La storia è in realtà nota, anche se si fa per lo più finta di non conoscerla e nelle commemorazioni ufficiali non se ne fa menzione: nato il 19 gennaio a Palermo, nel quartiere della Kalsa, il giovane Borsellino frequenta il liceo classico "Giovanni Meli" e poi si iscrive a Giurisprudenza. Qui, dopo una rissa tra studenti simpatizzanti di destra e sinistra, finisce in tribunale, ma viene dichiarato estraneo ai fatti. Nel 1959, però, si iscrive al Fronte Universitario d'Azione Nazionale, di cui diviene membro dell'esecutivo provinciale. Viene anche eletto come rappresentante studentesco nella lista del Fuan «Fanalino» di Palermo. Va precisato che, a differenza del Fronte della gioventù, in cui albergavano spesso idee eretiche ma in cui alla fine il controllo del partito dei «grandi» era più stringente, il Fuan era spesso un vero laboratorio politico alternativo, riottoso rispetto alle linee guida più borghesi dell’establishment missino. Era anche il movimento che diede per primo grande visibilità, in Italia, al simbolo della croce celtica, proveniente dagli ambienti francofoni e privo di una vera connotazione politica nostalgica, tant’è che per molto tempo diversi militanti chiameranno quel simbolo semplicemente come «il Fuan».
Uscito dall’università, Borsellino lascerà la politica militante, dedicandosi alla carriera di magistrato. Nelle aule, tuttavia, la sua fede politica non è certo un mistero. Ha ricordato l’ex magistrato Giuseppe Ayala: «Lo chiamavo “camerata Borsellino”. E lui con grande bonarietà non se la prendeva, ci rideva su. Io entravo sguainando il braccio destro nel saluto romano e lui rispondeva allo stesso modo. Alcuni suoi veri amici erano gli stessi che frequentava negli anni dell’università. Penso a Giuseppe Tricoli, il professore di storia con il quale passò l’ultimo giorno della sua vita. O ad Alfio Lo Presti, un bravo ginecologo. A Guido Lo Porto, il deputato del Msi. Queste amicizie forti di Paolo mi hanno fatto riflettere su un punto, sull’assurda criminalizzazione dei missini fra i quali ci sono tantissime persone perbene».
Nel 1990, e ci sono le foto a dimostrarlo, Borsellino partecipò a Siracusa alla festa nazionale del Fronte della Gioventù, insieme a Tricoli, a Gianni Alemanno e Fabio Granata.
Il retaggio di una certa cultura politica lo accompagnerà per tutta la vita. Il 20 giugno 1992, a una veglia per Giovanni Falcone, l’amico magistrato che conosceva fin da bambino e che lo aveva preceduto nell’estremo sacrificio, Paolo Borsellino pronuncia a Palermo un discorso in cui cita José Antonio Primo de Rivera, fondatore della Falange spagnola ucciso dalle forze repubblicane durante la guerra civile spagnola, un vero mito per la generazione della giovane destra di cui egli aveva fatto parte. Parlando del capoluogo siciliano e del rapporto che con essa aveva Falcone, Borsellino ricorda «questa città degradata e disperata che tanto non gli piaceva, che gli cagionava sentimenti di ripulsa e avversione per lo stato in cui era ridotta e si andava riducendo. Città che proprio per questo, perché tanto non gli piaceva, egli amava e amava profondamente, proprio come nel famoso detto di José Antonio Primo de Rivera “nos queremos España, porque no nos gusta” (amiamo la Spagna perché non ci piace). Sì, egli amava profondamente Palermo proprio perché non gli piaceva. Perché se l’amore è soprattutto “dare”, per lui e per coloro che gli siamo stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo ha avuto e ha il significato di dare a essa qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e professionali per rendere migliore questa città e la Patria cui essa appartiene».