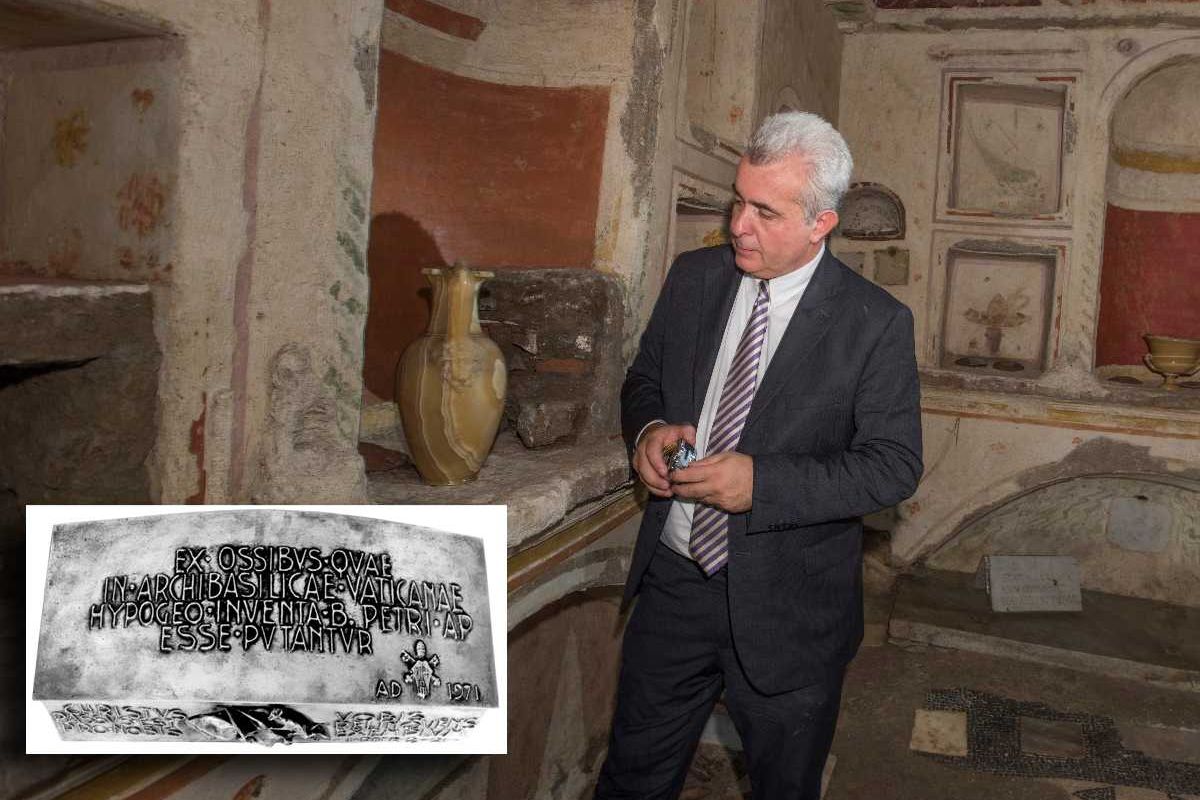Quest'anno, per la prima volta, il fatturato dei panettoni artigianali ha superato quello della grande industria, con il 52% sul totale complessivo. Panettone uscito dalla culla madre meneghina e declinato nelle diverse varianti a tutto stivale, Sicilia compresa. Ma se panettone e, a ruota, pandoro rappresentano oramai un consolidato linguaggio comune nei riti della dolciaria natalizia, è interessante un viaggio di recupero nei «dialetti culinari» sparsi nel Bel Paese. Partiamo da Napoleone, con la sua prima campagna d'Italia, nel 1797. Vuolsi che sia dovuta a lui la nascita della bisciola, che non è un rettile, ma una tradizione della Valtellina. In realtà all'uomo di Ajaccio nulla è dovuto in quanto la bisciola era frutto dei recuperi dalle madie casalinghe di quanto si trovava: fichi, uvetta, noci. Ambasciatore della sua valle assieme ai più noti bitto & bresaola.
In Liguria troviamo il pan dolce. Le radici a metà del XVI secolo quando Andrea Doria, per rendere omaggio al matrimonio tra il nipote Gian Andrea e la nobil donna Zanobia del Carretto, stimolò i suoi maestri pasticceri a inventarsi qualcosa degno simbolo delle virtù di Zena. Nutriente, ma resistente nel conservarsi nelle cambuse dei marinai. Una liturgia ben consolidata divenuta patrimonio domestico. Tradizione voleva che fosse il più giovane di famiglia a portarla in tavola, consegnandola al senatore di casa, padre o nonno. Mentre questi la tagliava, la mamma recitava una novena beneaugurale «Vita lunga con questo pane! Prego per tutti tanta salute, come oggi così domani». Come ben ricorda Mitì Vigliero Lami seguivano le poesiole recitate dai bambini ritti sulla sedia, dopo che il loro babbo ne aveva letto le piccole letterine di auguri a tutta la famiglia. Se ne conservavano due fette. Una destinata al primo povero che avesse suonato all'uscio, l'altra da dividere assieme il 3 febbraio, giorno di San Biagio, protettore dei mal di gola e altri accidenti invernali. Un dolce in cui la corretta lievitazione faceva la differenza, alimentata da un calore costante, tanto che molte madri di famiglia se lo portavano a letto, protetto sotto le coltri assieme al «prete», lo scaldino che si usava un tempo. Veniva poi cotto nel runfò, la cucina a legna. Fornai e pasticceri lo preparavano solo su ordinazione per i «foresti» che se lo volessero portare appresso in altri luoghi, come documentato in un testo del 1863 da Giovanni Battista Ratto.
Trasferendosi lungo la dorsale appenninica, arrivati a Bologna ecco il certosino che, a suo tempo, si chiamava panspeziale, frutto dell'estro creativo, all'approssimarsi delle feste, di farmacisti e speziali. L'arte era nel saperlo impastare con abilità e mano ferma, non solo per dargli l'ideale forma rotonda, ma soprattutto saperne gestire la ricca decorazione con frutta candita e mandorle croccanti tanto che, alcune forme «erano tanto grandi da sembrare i rosoni di una basilica romana». Attorno al Settecento se ne presero cura i frati della Certosa, da cui deriva il nome attuale. Dolce che raramente ha superato i confini petroniani, con qualche eccezione, come quando salì al soglio di Pietro Benedetto XIV, al secolo il bolognese Prospero Lambertini, un papa illuminato che fece grandi riforme, forse perché ispirato dalle sue passioni golose. Certosino tutelato dalla ricetta originale depositata una ventina di anni dall'Accademia Italiana della Cucina, marchio di garanzia.
Tra i sette colli di Roma tradizione trova il pangiallo, un cui antenato era citato da Apicio nel suo De re coquinaria, testimone dello stato dell'arte in quel tempo: «mescola nel miele pepato del vino puro, uva passita e della ruta». Nasceva in concomitanza con il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. Per forma e colore ricordava il sole, un bene augurio quindi all'arrivo della nuova stagione e quindi dei raccolti. Dall'originale impasto a base di farina, mandorle, sale e zafferano via via si è arricchito di altre componenti quali cannella, canditi, noce moscata. Alla base del miele riscaldato in un tegame cui, via via, si aggiungevano le varie componenti. Fino alla metà del secolo scorso le massaie usavano i noccioli conservati di prugne e albicocche in luogo delle più attuali (e costose) mandorle e nocciole. Le mogli dei contadini lo regalavano ai notabili locali. Vi era una sorta di marchio di fabbrica a denotare lo status della famiglia che ne faceva omaggio. Il colore giallo poteva derivare da uno strato di pastella d'uovo, come invece da una pennellata di più nobile zafferano.
In Puglia il dovuto omaggio al pesce in pasta di mandorle. «Lu luce te li signori» (il dolce dei signori). Incubatrice le cucine delle suore benedettine cui diede il cambio di passo vincente la badessa Anna Fumarola, del monastero di San Giovanni Evangelista. Spesso, infatti, queste figure provenivano dalle nobili famiglie del territorio e quindi portavano a livello monastico quanto l'eredità del loro status era patrimonio consolidato. Dentro l'involucro della pasta reale (a forma d'agnello nel periodo pasquale) veniva confezionata la «faldacchiera» una crema arricchita con confetture di frutta, canditi e cioccolato. Uno degli omaggi più ricercati e apprezzati in terra salentina.
Varcato lo Stretto è un bengodi goloso di cui fare sintesi con il buccellato. Siamo a Palermo, crocevia di popoli e rotte commerciali. Un melting pot mediterraneo di cui il buccellato può essere una sintesi. L'etimo rinvia al buccellatus romano, pane bucato, una sorta di ciambella di lunga conservazione e facilmente trasportabile per il rancio di legionari e marinai, inanellato su bastoni. Con il tempo si è arricchito con frutta secca per arrivare alla forma attuale, ricoperto da una glassa e varie decorazioni, dai pistacchi al cioccolato. Ingrediente fondamentale i fichi, asciugati ed essiccati in lunghi fili di spago e poi «incannati», cioè infilzati su spiedi di canne. Viene preparato in occasione della festa dell'Immacolata e, da lì, compagno di coccole golose sino all'Epifania. L'uso della frutta candita rinvia alla presenza araba in Sicilia, mentre la forma lo vede apparentarsi con un cugino simile presente in Lucchesia, pur se con ingredienti diversi. Qualcuno ha individuato in questa contaminazione l'eredità dell'antica Roma in terra toscana, arrivata poi in Sicilia grazie a una comunità commerciale proveniente dalla costa tirrenica. La liturgia tradizionale prevedeva un'apposita «sala operatoria» domestica, composta dallo scannaturi, una tavola di legno levigata che veniva appoggiata su due sedie. In questo modo le massaie avevano un ripiano più basso su cui scaricare le loro energie manuali volte a formare un impasto ricco di tutto un po'. Il tocco d'artista con la stigghia pu' cucciddatu, ovvero un ferretto realizzato appositamente dal fabbro con in testa una rotellina che serviva a modellare la cornice rotonda del buccellato dandogli una sorta di forma che ricordava le torri merlate di un tempo, sì da poter intravedere il ben di dio dell'impasto all'interno. Ma, dato che «anche l'estetica ha il suo peso, come una chiesa barocca il buccellato viene arricchito da alcune cucchiaiate di miele riscaldato, tanto da renderlo più splendente che mai», accanto alla frutta candita messa a golosa decorazione. Vi sono i buccellatini, in forma mignon. Mentre il classico buccellato è la principale decorazione in tavola che rinvia alla celebrazione del Natale. Una piccola curiosità è legata alla presenza dei «diavulicchi», piccole code di zucchero, che tradizione vuole ispirarsi alle omologhe dei diavoletti presenti in un famoso affresco dello storico palazzo della Zisa, guardiani di un tesoro, mito arrivato sino a noi di una sfortunata storia d'amore tra Azel Comel e la sua El Aziz che fuggirono dalla Libia per coronare i loro sogni, ma mancati anzitempo per i tragici incroci del destino.