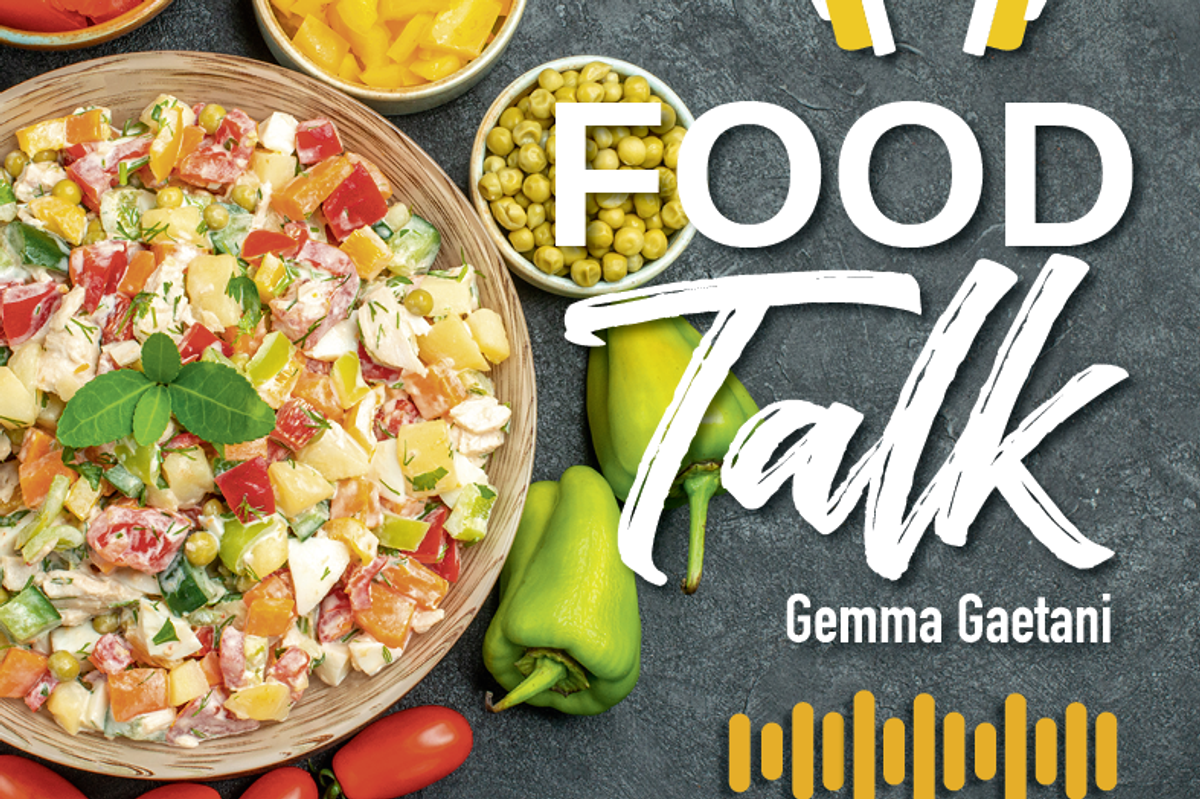- Il grande regista Ermanno Olmi è morto a 86 anni. Cattolico sui generis, ha messo in scena l'anima dell'Italia meglio di Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci. Per lungo tempo non si è fatto prendere dal furore ideologico post sessantottino. Per questo non è stato celebrato come meritava.
- L'unica caduta di stile nel 2011, quando presentò a Venezia «Il villaggio di cartone», troppo intriso di luoghi comuni.
Lo speciale contiene due articoli.
L'Italia del boom economico guardandosi allo specchio si trovò diversa. Con rapidità aveva mutato volto. Era andata a dormire con la camicia da notte del contadino e, al risveglio, indossava l'abito fabbricato in serie. Era stata povera, perlopiù legata alla terra, poco alfabetizzata, non troppo pulita, lenta e sedentaria. In un batter d'occhio si lasciò alle spalle la povertà, il mondo contadino, i sermoni dei preti, il dialetto. Il corpo divenne un bene da curare. Scoprì che era ancora povera ma bella, ricca di belle ma povere e di poveri ma milionari (come recitano gli azzeccati titoli della «trilogia» cinematografica di Dino Risi, realizzata tra il 1957 e il 1958). La Lambretta, la Vespa e la Fiat 500 motorizzano e velocizzarono il Paese. L'elettrodomestico più desiderato, il televisore, a partire dal 1954 riuscì persino nel miracolo di unificare la lingua. E, infine, la migrazione di massa: dal Meridione al Settentrione; dalla campagna alla città; dal piccolo borgo di poche anime alla cintura più popolata, industrializzata e tecnologizzata.
Il processo non fu così ridente e indolore come spesso viene rappresentato. Fu anche gravido di tensioni, paure, disagi, rancori. «Affrica!», commentano due donne milanesi quando vedono arrivare sul carretto stipato di povere cose alcuni immigrati lucani in Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti. Chiusa la stagione neorealista (1945-1954), lo schermo italiano si tinse di rosa, zeppo di «maggiorate» e «bersagliere», «marescialli» e «bellimbusti». La «paure» del dopoguerra (quando il furto di una bicicletta nel 1948 portava alla rovina) vennero sopraffatte delle «speranze» del benessere. E gli italiani si tuffarono nel mare senza confini della commedia. Ma lo specchio del divertimento aveva anche un lato oscuro, o diverso, che nessuno seppe raccontare.
O, ad essere precisi, pochi ci provarono. I racconti sui «segreti di Milano» di Giovanni Testori (il primo episodio de Il ponte della Ghisolfa è del 1958) ispirò a ViscontiRocco e i suoi fratelli. Ma Visconti, genio impegnato a mescolare decadenza e ideologia, D'Annunzio e Gramsci, lì si fermò. Pier Paolo Pasolini prima con i romanzi (nella seconda metà degli anni Cinquanta), e poi con i film Accattone (1961) e Mamma Roma (1962), fece affiorare il mondo delle borgate romane. Ma il vero interprete della mutazione antropologica italiana del secondo Novecento è stato il bergamasco Ermanno Olmi.
Tra il «disimpegno» rimproverato alla commedia e l'«impegno» rivendicato dal tardo neorealismo e dal nuovo cinema d'autore, Olmi in Il tempo si è fermato (1958), Il posto (1961), I fidanzati (1963), Un certo giorno (1969), Durante l'estate (1971) e La circostanza (1974), elabora uno stile di regia assolutamente personale, lontano dalle mode correnti ed estraneo al progressismo di sinistra che ha contagiato il cinema italiano.
Olmi è un cattolico per nulla toccato dal «dissenso» dilagante negli anni intorno al Sessantotto. Il furore «conciliare» non è pane per i suoi denti, come dimostra E venne un uomo (1965), ricostruzione biografica di Giovanni XXIII priva di quell'agiografia che accompagna immancabilmente il profilo del «papa buono». Il cattolicesimo di Olmi è figlio della Tradizione contadina. La secolarizzazione e il neomodernismo cattolico stanno uccidendola.
La «città secolare» non sa più che farsene di un universo e di un cattolicesimo superati, arcaici, inadatti a rispondere alle esigenze del mondo nuovo. E Olmi, a questa deriva, reagisce con un capolavoro assoluto, L'albero degli zoccoli (1978), ambientato nella campagna bergamasca tra il 1897 e il 1898. Il film ha lo stesso valore simbolico de I promessi sposi del Manzoni. Una grande allegoria morale e cristiana. La società dei consumi ha condannato a morte il cristianesimo contadino. La moderna città ha deciso di fare a meno della divinità. O meglio, è carica di nuove divinità, ma secolari. Dio sta tramontando nell'orizzonte umano.
Per Olmi nella tradizione contadina non vanno rintracciati i germogli della «rivoluzione». Nelle modeste case bergamasche non c'è il ritratto di Lenin, come in quelle socialiste di Novecento (1976) di Bernardo Bertolucci (che comunque, storicamente, non c'era). Ci sono le immagini votive. La legge di Dio, immutabile nei secoli, ha regolato un mondo certo difficile da abitare, spesso spietato, ma ricco di umanità. La lotta di classe e la dialettica marxista di Bertolucci; l'antropologia cristiana e la dialettica evangelica di Olmi. Usciti più o meno nello stesso tempo, a L'albero degli zoccoli non venne riconosciuta, rispetto a Novecento, l'importanza che meritava.
Appariva più conforme la già scricchiolante ferraglia del tardo comunismo di Bertolucci, allungata in salsa cinese e con una spruzzata di freudismo. Segno dei tempi. Ma proprio il trascorrere del tempo ha riequilibrato le oscillazioni della bilancia. Oggi, chi osserva senza pregiudizi di natura ideologica gli estremismi di Bertolucci, li trova pesanti, artificiali, datati. Le immagini di Olmi, nella loro originaria semplicità, ci restituisco invece la verità di un universo scomparso. La civiltà contadina italiana è come la città di Atlantide: inabissata. Ermanno Olmi l'Atlantide della campagna bergamasca l'ha riportata in superficie attraverso la finzione. L'ha fatto talmente bene da trasformare il contenuto «falso» delle immagini, nel «vero» della ricostruzione. Ermanno non ha mai dubitato dell'esistenza del Paradiso. E con L'albero degli zoccoli se n'è guadagnato, giustamente, il biglietto valido per l'ingresso.
L’unica caduta di stile sui migranti e la Chiesa trasformata in Onlus
Per fortuna quello non fu il suo ultimo film come aveva annunciato. Sarebbe stato una sorta di suicidio artistico se la carriera di uno dei registi di più elevato spessore umano e religioso del Novecento si fosse conclusa con Il villaggio di cartone. Era un molto discutibile apologo sull'accoglienza e la solidarietà, rivolta a un gruppo di clandestini nordafricani arrivati sulle coste del Salento.
Bergamasco di nascita, milanese di adozione, ritiratosi infine nell'altopiano di Asiago, Ermanno Olmi aveva già annunciato il ritiro dal cinema di finzione dopo Centochiodi, anche quello un'allegoria ribelle alla casta dei teologi, in favore, però, di un cristianesimo tanto ruspante quanto naif. Ci aveva ripensato pure quella volta, licenziando il nuovo film, presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia del 2011. Nella prima inquadratura, dentro una chiesa sconsacrata dove si è ritirato a vivere un vecchio prete in crisi, si vede calare a terra il crocifisso. Una scena di grande impatto simbolico. Ripensando alla propria storia, l'anziano sacerdote impersonato da Michael Lonsdale (Il nome della rosa, Uomini di Dio) dice: «Ho fatto il prete per fare del bene, ma per fare il bene non serve la fede». Era il gigantesco equivoco di quel film. Il compito dei cristiani è l'accoglienza. Anzi, l'accoglienza conta più di ogni altra cosa: «Il bene è più della fede», completava la riflessione il prete. E, dunque, per accogliere i profughi tra i quali si celava anche un terrorista, il crocifisso non serve. Ai poliziotti che bussavano alla porta della canonica nella ricerca dei clandestini, il sacerdote opponeva il silenzio di una distorta carità.
«Il crocifisso è un simulacro di cartone», sosteneva all'epoca un indispettito Olmi. «Sono stanco di questo Cristo che mi insegue. Ha sofferto per noi, certo. Ma è successo molti secoli fa. Invece che davanti al crocifisso i cristiani dovrebbero inginocchiarsi davanti agli immigrati, a chi soffre davvero, ai ragazzi persi nella droga». L'equivoco di Olmi era doppio. Non solo la teorizzazione di un'accoglienza indiscriminata, comprensiva anche verso i violenti, come se solo tra gli immigrati si nascondesse «il bene» e la possibilità di farlo. Ma anche la riduzione del cristianesimo a filantropia, a beneficenza sociale. La trasformazione della Chiesa in una gigantesca onlus. Se glielo dicevi rifiutava la critica. Si irritava. Per fortuna quello non rimase il suo ultimo film. Tre anni dopo, prima del recente documentario sul cardinal Martini, arrivò il poetico Torneranno i prati. Riposi in pace.
Maurizio Caverzan