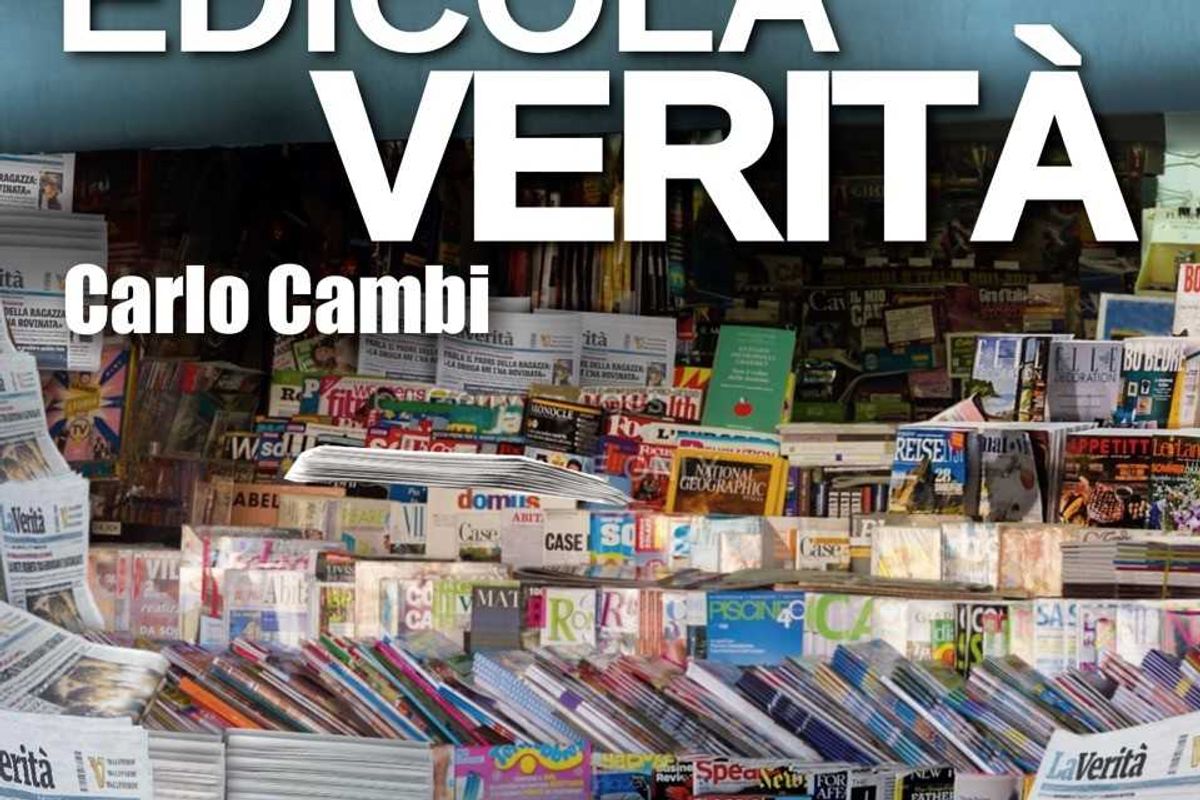Il pensiero critico torna al suo posto: il nostro docufilm visto alla Sapienza
Il pensiero critico è tornato nel luogo cui dovrebbe appartenere per eccellenza - l’università - e da dove era stato esiliato durante la gestione pandemica, i cui postumi ora si fanno sentire. Uno dei più inquietanti, essendo destinato ad impattare profondamente sulle nostre vite, è il controllo sociale: per riflettere sui rischi della dipendenza da quella tecnologia digitale che lo sta rendendo possibile, l’Università Sapienza di Roma ha ospitato sabato scorso un incontro aperto a studenti e docenti che ha messo al centro gli argomenti contenuti in «Covid19, dodici mesi di pensiero critico», il docufilm prodotto dalla Verità.
Questa rassegna ragionata di quanto accaduto negli ultimi anni spiega infatti come la pandemia sia stata l’occasione per accelerare una digitalizzazione già programmata dalle autorità Ue, e avente finalità molteplici: la raccolta di una banca dati sanitaria europea, il controllo dell’informazione, il monitoraggio del consumo di energia, il cambiamento della struttura economico-finanziaria. Il tutto nell’ottica di una maggiore sorveglianza.
La proiezione di alcuni passaggi del docufilm ha messo in evidenza come il green pass sia stato lo strumento usato dai decisori per attuare, nel minor tempo possibile, una transizione tecnologica sul maggior numero di persone: l’introduzione del certificato verde ha infatti segnato l’ingresso in un ambiente 2.0 di una vasta platea di soggetti, i quali sono stati censiti, fatti confluire su una piattaforma tramite il rilascio di identità digitali certificate, e subordinati, attraverso questi, nell’esercizio di determinate facoltà. Un passaggio che può sembrare la mera prosecuzione di meccanismi già in uso nel campo dell’e-commerce e dei social, ma che comporta gravi conseguenze quanto ai diritti, alle libertà, alla capacità giuridica delle persone. Sono infatti in gioco i rapporti tra cittadini e stati nazionali, che così finiscono «privatizzati», assumendo forme e logiche tipiche delle relazioni economiche con le BigTech, con gli Stati ridotti a fornitori e i cittadini a utenti consumatori.
Non solo: il green pass non è stato archiviato definitivamente e si fonda su una tecnologia interoperabile (tra Stati e, al loro interno, tra soggetti della pubblica amministrazione), modulare (ovvero capace di adattarsi a picchi di carico improvvisi) e scalabile (cioè pronta per altri impieghi e scenari): elementi che fanno presagire futuri utilizzi in caso di nuove emergenze, da quella green a quella energetica a quella alimentare. «Con il Covid abbiamo fatto un salto enorme nella direzione della digitalizzazione, trasformando ciò che prima era un’opportunità in un obbligo» hanno sottolineato gli studenti.
Un’evoluzione che ha spinto il gruppo di studenti universitari di Roma e Firenze organizzatori dell’incontro in Sapienza ad attivarsi con un lavoro di sensibilizzazione presso scuole e atenei sui danni della dipendenza digitale e sui pericoli di una transizione non governata: quella svoltasi alla Sapienza è infatti la prima di una serie di iniziative messe in campo per suscitare consapevolezza critica, tra le quali rientra la collaborazione con un gruppo di studenti newyorchesi che ha smesso di usare smartphone e device digitali.
Per gli studenti il cambiamento deve avvenire a più livelli: «Dallo sciopero del digitale, che riteniamo la nostra vera “arma” nel nuovo millennio, al recupero di luoghi di socializzazione, come centri dopo scuola che facciano stare insieme i ragazzi». Un punto dolente, a loro avviso, è la formazione: «Scuole e università veicolano ogni tema in modo tecnico, materialista e funzionalista», mentre l’attività di ricerca è sempre più eterodiretta: «i fondi, provengano da Pnrr o da organismi transnazionali, sono subordinati all’accettazione di un certo modo di pensare, con il risultato che i nostri coetanei finiscono per confondere ciò che è reale con il virtuale; quello che è umano con ciò che non lo è».
In questo contesto, su cui si affacciano le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale con novità come ChatGpt, si è concluso che diventa cruciale mostrare la disumanità di un certo impianto e del futuro che viene preparato. Come ha chiosato una studentessa: «Si tratta di recuperare uno sguardo protettivo sull’uomo, di tornare a riunirsi, e di trovare i modi per «contaminare» gli altri, ma superando i blocchi che ora dividono: chi è molto dipendente dai dispositivi digitali spesso nasconde delle fragilità, che vanno rispettate e non giudicate».