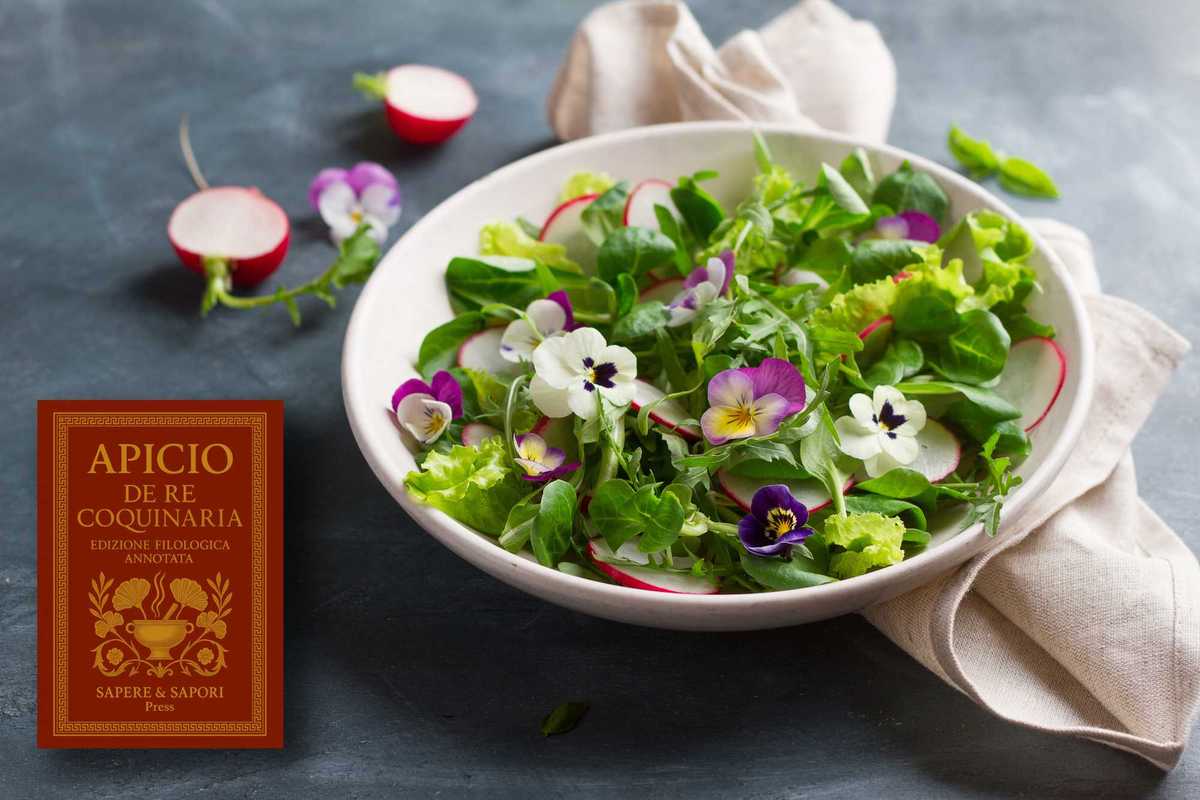L'attuale congiuntura pandemica ha limitato in vario modo i pellegrinaggi (anche golosi) tra le regioni dello Stivale, ma non può blindare un viaggio che vada a esplorare cosa ci tramandano tradizioni e liturgie che appartengono alla straordinaria biodiversità delle varie regioni. Se l'omologazione modernista dei palati tende ad appiattire le calorie tra i soliti noti (tortelli in brodo, bolliti e panettoni assortiti), in realtà, anche a cavallo delle feste, il Belpaese conferma di essere un bengodi goloso a ogni latitudine. Si aprono così scenari inediti se usciamo dai carillon dei caroselli omologati e andiamo a spulciare un po' di annali e tradizioni con golose sacche di resistenza che perpetuano tradizioni secolari.
Salpiamo dalla Liguria che ci presenta due preparazioni che trovano, nei giorni di festa, la loro massima celebrazione. Il cappon magro è un gioco di parole che potrebbe trarre in inganno. Non si tratta del pennuto messo a dieta, ma di un piatto che ha avuto una sua evoluzione propria. Il termine deriva da chapon, un francesismo a indicare quelle gallette che si portavano i marinai nelle stive, capon de galea. Una volta ammollate con l'acqua facevano da base per accompagnarsi con quello che offriva il pescato. In terraferma, con gli avanzi delle cucine nobiliari, la servitù si concedeva qualche strappo alla regola. Poi ha avuto un'evoluzione «da parata», a iniziare dal Rinascimento. Era il piatto delle grandi occasioni, riccamente decorato, tra pesci di varia esca e verdure bollite. Lo chapon sempre presente a fare da base. Alla sua cima del cuore ha dedicato una canzone Fabrizio De André, genovese purosangue: «Carne tenera non diventare scura, non diventare dura, e nel nome di Maria tutti i diavoli da questa pentola andate via».
Stavolta troviamo al piatto la cima alla genovese. Leggenda racconta che, per tenere lontane streghe malefiche, vi fosse una scopa all'entrata della cucina, amuleto indispensabile. Una tasca fatta con lo stallo, umile taglio vaccino. Cucita con mano sapiente, veniva riempita di uova, piselli e frattaglie. Una volta cotta veniva modellata per il servizio in tavola. Posta sotto un peso era poi servita il giorno dopo, a rifreddo, una tecnica che ritroviamo in altri classici, il vitello tonnato su tutti, ma il cui termine è stato dimenticato dalla modernità culinaria.
Volando dal Tirreno ligure all'Adriatico marchigiano gettiamo l'ancora per gustare un'altra storia, i vincisgrassi. Anche qui l'etimo gioca a nascondino. La memoria emerge dalle nebbie del tempo grazie ad Antonio Nebbia, un cuoco letterato che, nel 1779, raccontava di una salsa per il princisgras composta da prosciutto, tartufi e panna. Dopo qualche anno rimangono solo i tartufi a maritarsi con dei quadratini di pasta (guai chiamarli lasagne!) che vanno a formare una specie di timballo con un trittico animale composto da pollo, agnello e maiale. Il cambio all'anagrafe ricettaria, cioè vincisgrassi, attorno alla metà dell'Ottocento. Un piatto molto amato da marchigiani veraci quali Giacomo Leopardi e Giacomo Puccini e che stregò un certo Orson Welles, che lo scoprì ad Ancona, nel 1952, mentre era intento a girare con Totò L'uomo, la bestia e la virtù.
Nella città eterna ritroviamo un piatto tipico della vigilia, la minestra di broccoli e arzilla. Nel suo libro Nonna Minestra così la racconta Aldo Fabrizi. «È peggio de 'na droga sconosciuta che intossica er palato e nun dà tregue: tutti li venerdì 'na ricaduta». Figurarsi alla vigilia della nascita del Bambin Gesù. Arzilla altri non è che la razza chiodata, simile al rombo e diffusa sulle coste laziali. Di scarsa resa se cotta alla piastra o bollita, i pescatori spesso la ributtavano in acqua, salvo venderla a prezzi stracciati, offrendo anche al popolo minuto la possibilità di cibarsi di un pescato, seppur semplice. Tradizione voleva che si ripulissero le dispense degli avanzi di pasta, dai ditalini alle pennine da minestra. Praticamente dimenticata ha trovato la sua ambasciatrice in Agata Parisiella, una delle più brillanti missionarie delle cucine stellate, alla romana.
«Quello tra verdure e carni è un matrimonio che regge oramai da oltre tre secoli, mai sfiorato da timori di divorzio o di separazione». Così presenta la partenopea minestra maritata uno storico di razza quale Renato Di Falco. Più prosaicamente, due secoli prima, un disincantato Ippolito Cavalcanti l'aveva definita «un ideale acconciastomaco». Vediamo di mettere un po' d'ordine. Un equilibrio alchemico frutto dell'incrocio di sei verdure diverse, tra cui le scarurelle (piccole scarole), le torzelle (il cavolo napoletano). Un trittico di carne mentre del maiale si utilizzano sette «luoghi» (cioè tagli) diversi. Qualcuno l'ha definita «una preparazione molto ricca di ingredienti poveri».
Come sottolinea Luciano Pignataro, «l'arte della minestra maritata è nella proporzione delle verdure, laddove le caratteristiche di ognuna vanno a bilanciarsi». Sembra facile. Il risultato è una minestra forse un po' grassa, ma molto nutriente. Si può giocare di acceleratore, aggiungendo in pentola un piedino di maiale, o di freno leggero, limitando la carne al solo pollo. Per facilitare il tutto oramai i fruttivendoli vendono già le confezioni di verzure adeguatamente calibrate.
È tempo di cambiare passo e saltare al piatto principale. Arriviamo a «quel rimminchionito animale che per sua bontà si offre nella solennità di Natale in olocausto agli uomini» (Pellegrino Artusi dixit). Il cappone natalizio è una tradizione consolidata, ma forse pochi sanno come è nata.
Al tempo dei romani, nel 162 d.C., venne emanato un editto che vietava di allevare galline all'ingrasso per non sprecare le già scarse razioni di cereali. Scattò il piano B. Si scoprì che un gallo per cortile era più che sufficiente per il proseguimento della specie. Per di più, i galletti «ritoccati» ingrassavano meglio, con carni succulente e anche meno grasse. Nell'Italia della civiltà contadina erano una sorta di moneta sonante, omaggio ossequioso ai maggiorenti locali, ad esempio in occasione delle festività. Vi erano addirittura delle «specialiste» che giravano per le aie, sorta di chirurghe ruspanti, che provvedevano, con modi un po' da accapponare la pelle, a rendere capponi i malcapitati. Ora la scienza veterinaria ci permette di godere a tavola, con il dovuto rispetto, di tanto ben di dio, a seconda delle svariate ricette.
Tornando curiosamente famelici tra i rioni borbonici un doveroso omaggio al capitone. Nonostante la declinazione al maschile si tratta della femmina d'anguilla. Dalla testa più grande (da qui il nome), ma anche dalla taglia più robusta è un altro dei capisaldi del buon Natale alla partenopea. Una casella dedicata nella smorfia, al numero 32. Qui le regole sono chiare. I pescivendoli sono aperti tutta la notte il 22 e 23 dicembre per offrire un prodotto freschissimo. Va acquistata infatti viva, per essere sicuri che non venga spacciato come tale il più umile gorgo, dalle carni meno pregiate. Capitone generoso al gusto, tanto da portare a sazietà, senza grossa spesa, anche le famiglie che volevano celebrare la festa come i signori. Al piatto rigorosamente fritto ma, nel caso avanzasse qualcosa, riconvertito «a scapece» il giorno appresso, marinato in olio d'oliva, aceto, aglio e menta.
(1. Continua)