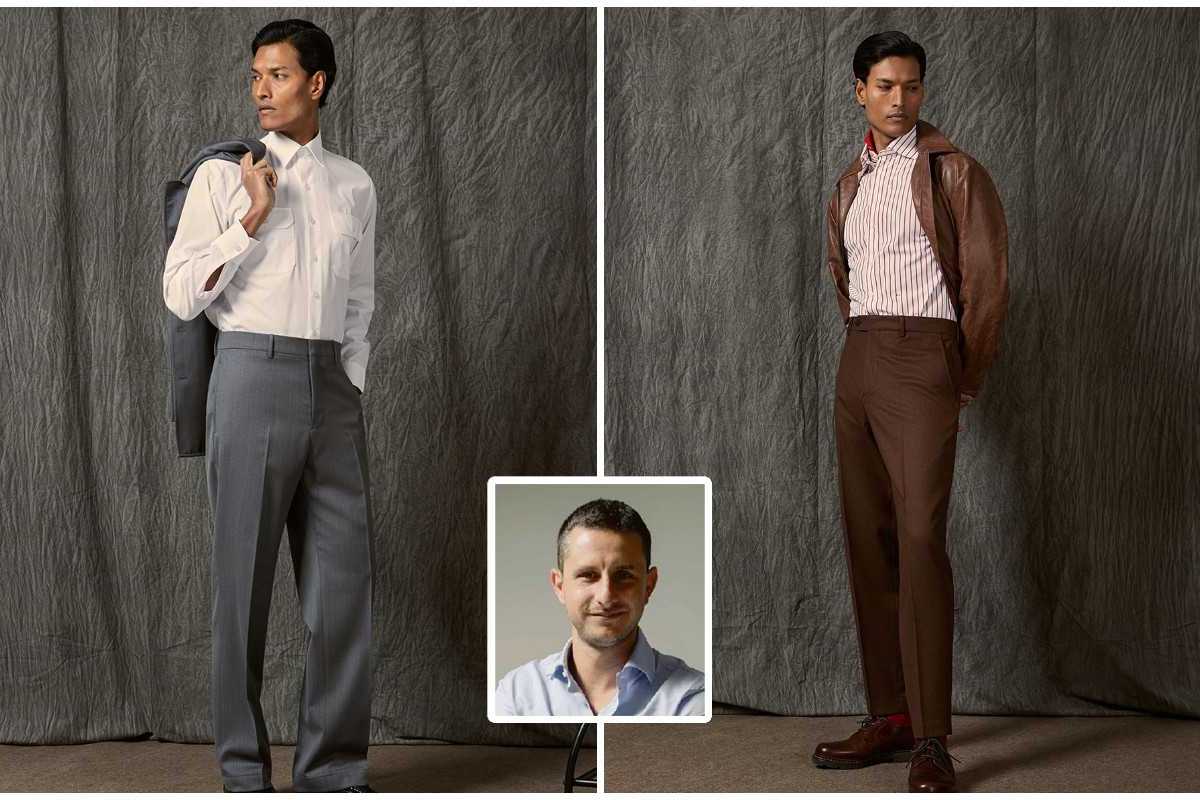Nei bimbi vaccinati reazioni avverse più critiche dei sintomi del Covid

A metà novembre, prima dell’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco al vaccino anti Covid nella fascia 5-11 anni, la Società italiana di pediatria tifava per questa decisione. La Sip «auspica che al più presto gli organi regolatori europei e nazionali possano permettere ai bambini italiani di beneficiare di tale intervento preventivo», scriveva in un documento ufficiale inviato a tutti i pediatri.
Tra una settimana sarà accontentata, ci saranno genitori pronti a far stendere il braccino ai loro figli, tra clown che si aggireranno negli hub offrendo biglietti per circhi rigorosamente senza animali, dolcetti e altri incentivi per i poveri piccoli. Sarà così ogni anno, stando alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, che pochi giorni fa ha previsto: «Da quello che abbiamo visto sinora in questa pandemia, è probabile che avremo bisogno di vaccinazioni annuali per mantenere un alto livello di protezione».
Covid trattato come un’influenza, dunque, allora perché correre a vaccinare i più piccoli non in una situazione di elevato rischio per la malattia, se quando contraggono l’infezione la prendono quasi sempre in forma lieve? I dati ufficiali ci dicono che da inizio epidemia ai primi di dicembre i positivi nella fascia 5-11 anni sono stati 284.110, i ricoveri ospedalieri 1.681 e 41 gli ingressi in terapia intensiva. La percentuale di casi sintomatici nei ventidue mesi è stata del 41,9% ma tra un anno come sarà, quando dovrebbe scattare il richiamo profetizzato da Bourla?
In base alla percentuale fornita dall’Istituto superiore di sanità, la stima dei casi sintomatici annuali diventa di 65.468 il che significa che l’incidenza annuale del Covid sintomatico è pari a 1,74%. Davvero c’è da essere allarmati per una probabilità così bassa di contrarre l’infezione, nei bimbi che si mandano a vaccinare con così poche certezze scientifiche sulle reazioni avverse del farmaco anti Covid? L’irragionevolezza, di una simile scelta, viene confermata dalle stime dei ricoveri annuali per la fascia 5-11 anni (0,02%), degli ingressi in terapia intensiva (0,0006%) e dei decessi (0,0002%).
Rischi praticamente nulli, stiamo parlando di due morti per milione l’anno e di sei ricoveri su un milione in terapia intensiva. Proviamo invece a proiettare nell’arco di dodici mesi le reazioni avverse da vaccino, riscontrate da Pfizer dopo aver somministrato la seconda dose ai bambini nei trial clinici 5-11 anni e forniti alla Fda per autorizzare negli Stati Uniti il farmaco anti Covid. Nella documentazione vengono elencati dolore nel sito di iniezione (71%), rossore (18,50%), gonfiore (15,30%), febbre superiore a 38 gradi (6,50%), affaticamento (39,40%), mal di testa (28%), brividi (9,80%), vomito (1,90%), diarrea (5,30%), dolori muscolari (11,70%), dolori articolari (5,20%). Percentuali riferite a tutti i bambini sottoposti alle sperimentazioni e che già fotografano una situazione affatto indolore del post vaccino.
Ma tra un anno, quando avremo numeri importanti di bimbi vaccinati, quanto incideranno gli effetti nocivi e non voluti conseguenti all’inoculazione? La Verità ha ipotizzato tre diversi scenari con tre differenti percentuali di vaccinazione (20%, 50% e 80%), ottenendo così la percentuale di bambini sulla popolazione totale che potrebbe sperimentare le reazioni avverse documentate. Quelle stime sono preoccupanti.
Come potete vedere nella tabella, non ci saranno grossi miglioramenti rispetto ai dati emersi dai trial e con l’80% di bimbi vaccinati peseranno notevolmente affaticamento (31,52%), mal di testa (22,40%), dolori muscolari (9,36%), gonfiore (12,24%), solo per citate alcune reazioni avverse severe con impatto sulla salute e che impediscono la normale attività quotidiana. Senza contare le nuove reazioni che si potranno registrare ampliando la platea di vaccinati, e di cui ancora ignoriamo frequenza e gravità.
Già nello studio pubblicato lo scorso agosto dal New England Journal of Medicine sui i risultati del trial randomizzato, controllato con placebo di fase 2-3 del vaccino mRNA-1273 prodotto da Moderna, per la fascia 12-17 anni si riferiva di «reazioni locali o sistemiche sollecitate persistite per una media di circa quattro giorni» ma anche di sette, che non è poca casa per giovani che studiano, fanno attività fisica, ricreativa o sportiva che sia. Reazioni avverse riportate da adolescenti e definite di gravità da lieve a moderata, in soggetti di età inferiore sono ancor meno sopportate.
Quando il vaccino era in fase di studio, un piccolo numero di bambini presentava gonfiore dei linfonodi e sono verificate anche reazioni cutanee locali. Ma poi con quale beneficio, farli stare male così, dal momento che l’infezione non è per loro preoccupante, la maggior parte sperimenta una malattia asintomatica o lieve e il rischio di contrarre il Covid tende a decrescere, sia per una minore circolazione del virus tra gli adulti vaccinati, sia perché sempre più persone si contagiano e dunque la platea dei suscettibili all’infezione diminuisce.