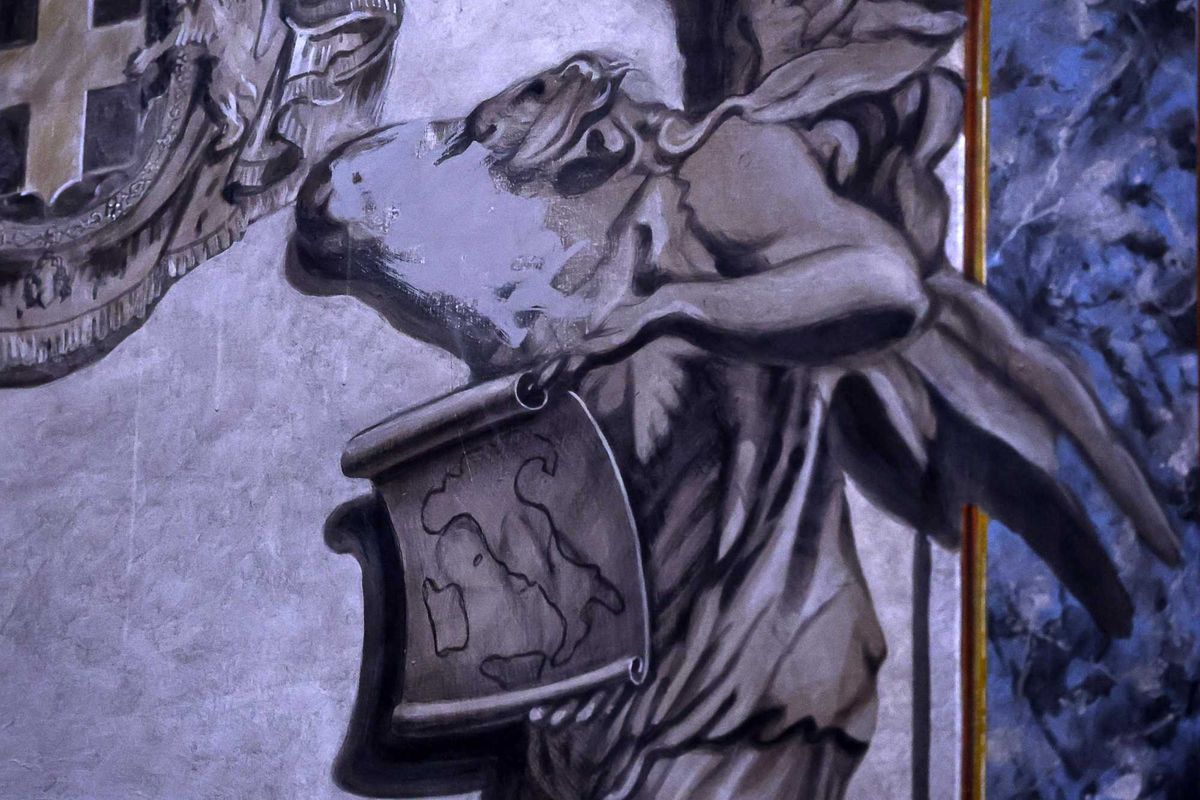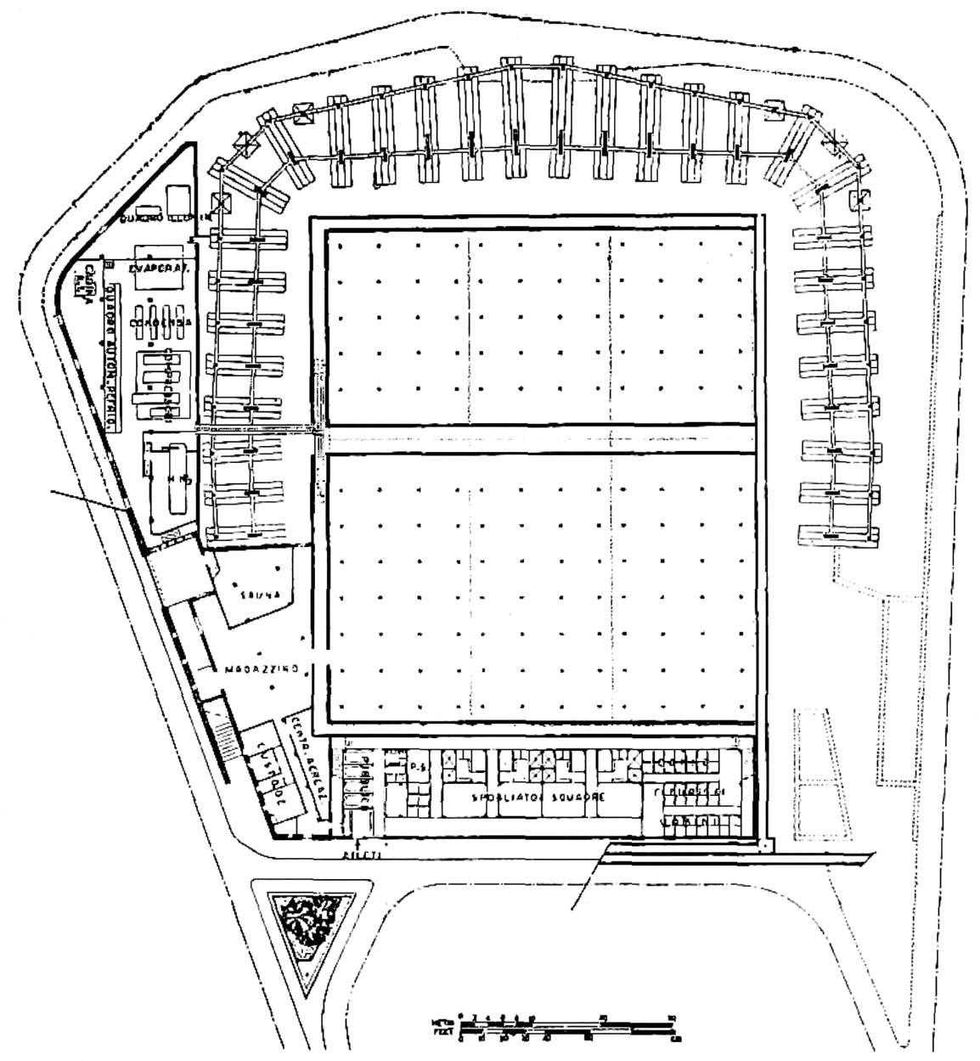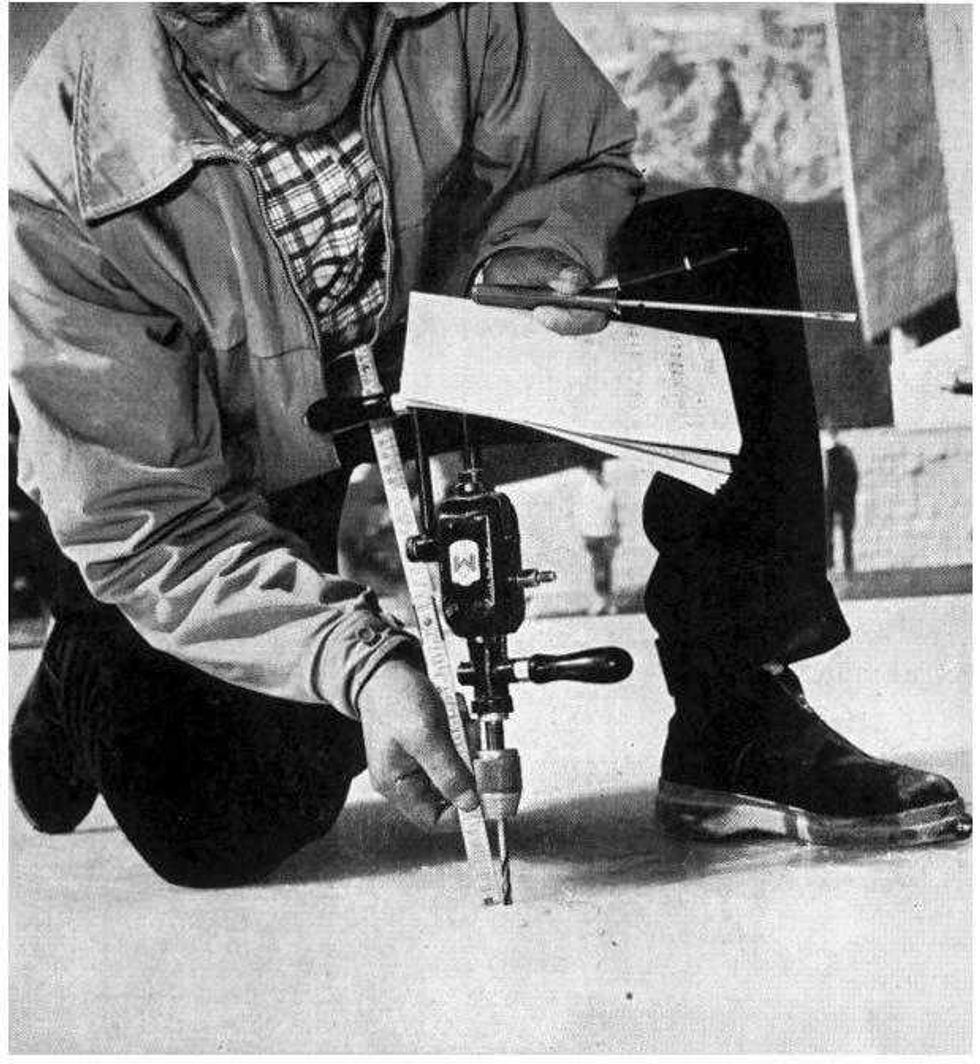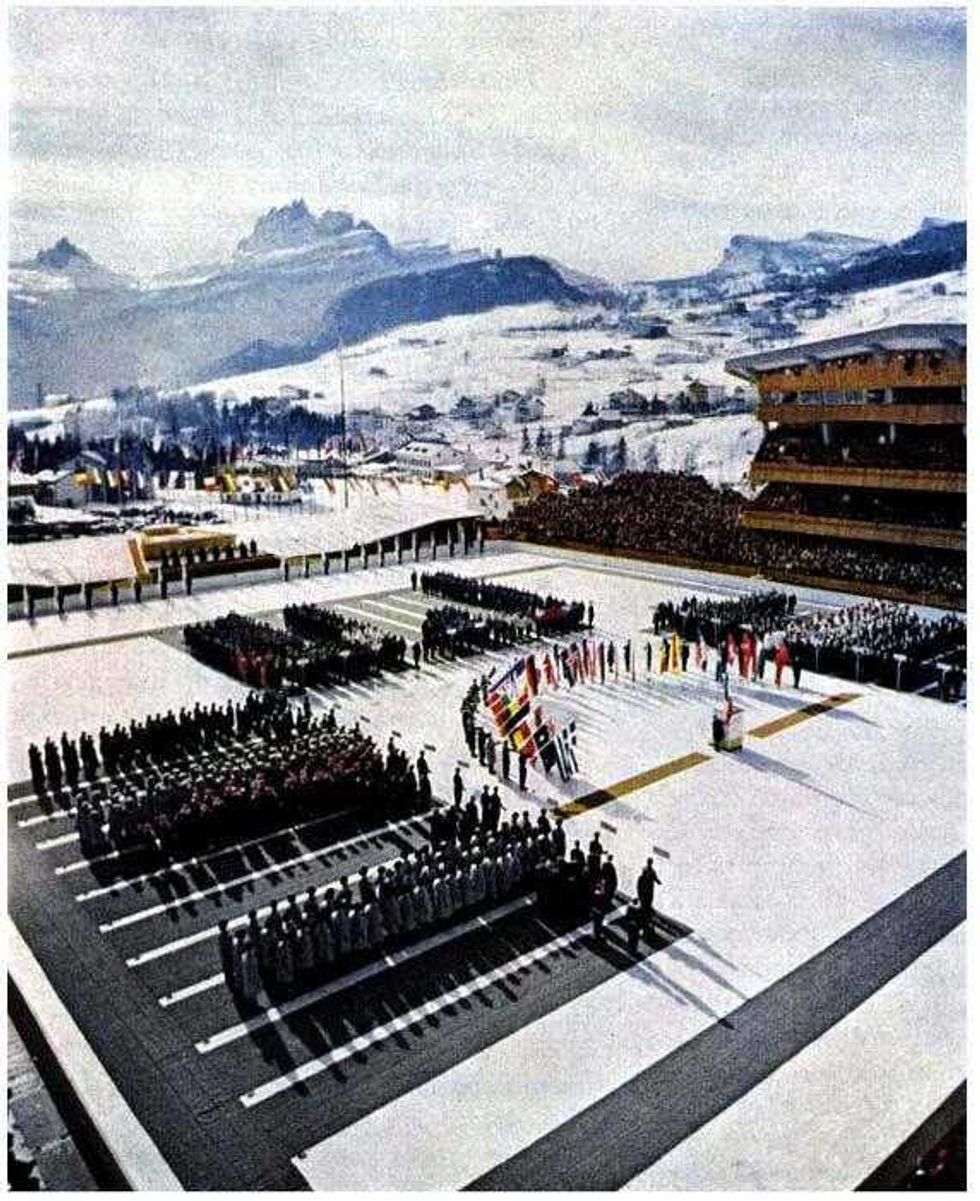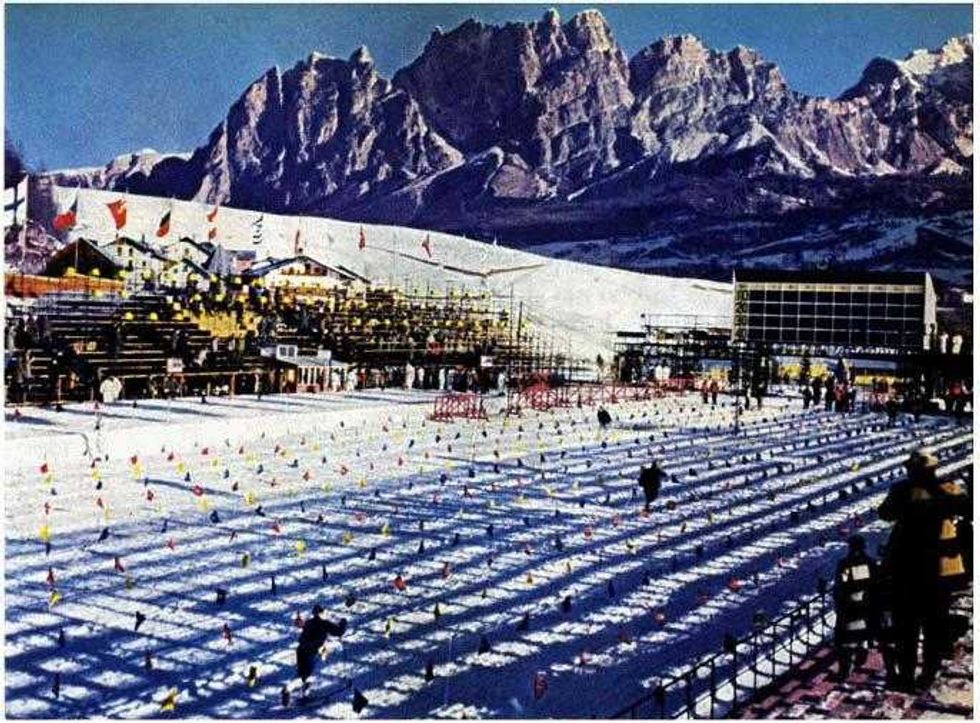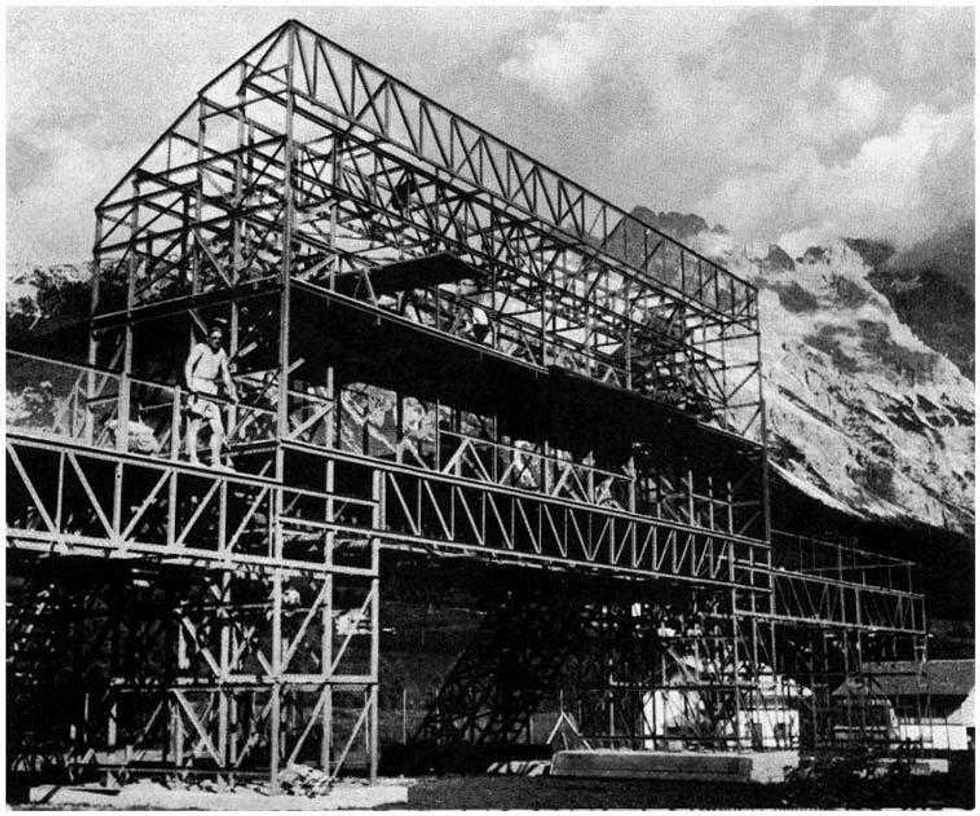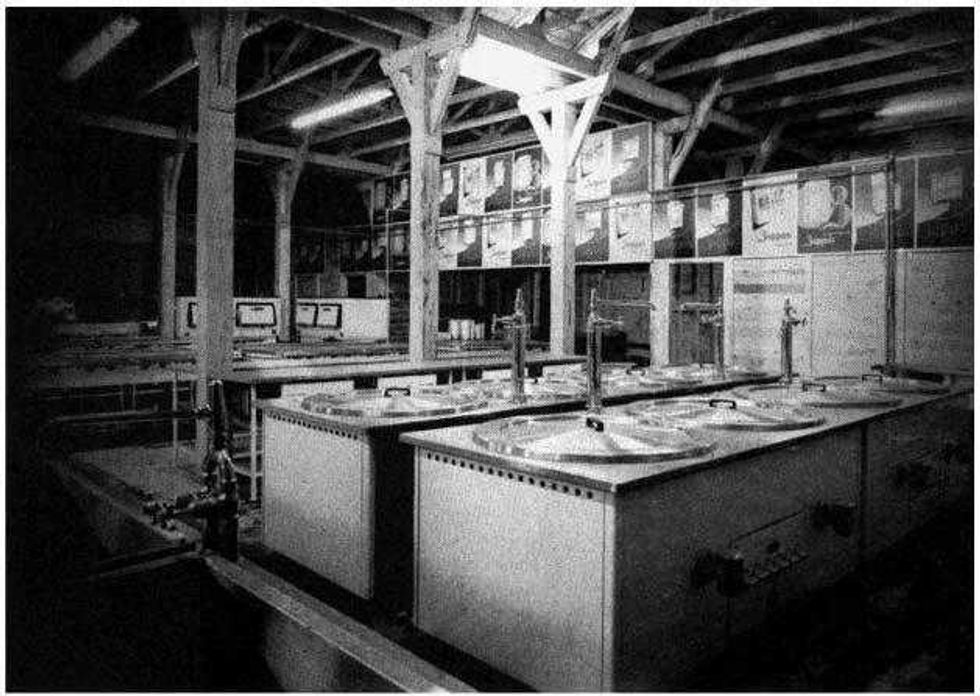Così parlò Bellavista vedeva la luce in un anno cruciale della storia d'Italia, il 1977. Anno di P38 e di sconvolgimenti sociali. Anche per Napoli quella stagione calda rappresentò una fase di passaggio, verso tempi più moderni e anche più pericolosi. La camorra, che molti ancora descrivevano con l'oleografia del guappo di quartiere, si «industrializzava» con il commercio internazionale delle droghe e cominciava a puntare in alto. Di lì a poco, con il terremoto del 1980, si sarebbe posta con tutta la potenza di un ant Stato che addirittura piegava le Br e otteneva la scarcerazione di un capo regionale della Dc.
In questo marasma sociale, l'ingegner Luciano De Crescenzo, morto ieri a 90 anni, si affacciava alle luci della ribalta con un garbatissimo mix di modernità e tradizione. Era stato dirigente dell'Ibm a Milano, ma coltivava la poesia della napoletanità gentile, con la vena di Vittorio De Sica e del principe nato povero De Curtis. Metteva su carta ritratti un po' retrò ma nello stesso tempo utilizzava la potenza del nuovo mezzo delle televisioni private per diffondere il verbo del napoletano «popolo d'amore».
Su questa storia dei «popoli d'amore» - contrapposti ai «popoli di libertà» - bisogna però riflettere con un pizzico di serietà. De Crescenzo coglieva un tratto identitario di Napoli e per estensione dell'Italia. Intuiva il valore di una nazione che fondava la propria formula esistenziale sui rapporti personali (l'amicizia, la famiglia, l'amore tra uomo e donna in senso stretto), più che su regole astratte. Per il «professor Bellavista» sarebbe stata una inutile tortura piegare un popolo con tale fisionomia alle regole astratte e rigide dei cosiddetti «popoli di libertà», quelli che per intenderci hanno imposto la loro egemonia all'interno dell'Unione europea.
De Crescenzo che si definiva «un uomo di destra che vota a sinistra» ovviamente si è sempre guardato dal dare una connotazione politica più stringente a quella sua dicotomia fondamentale, ma sta di fatto che dalle sue pagine si potrebbe trarre più di uno spunto per capire la forza attrattiva della sirena «populista» in una società come quella italiana o anche per capire perché in queste ore l'Italia profonda è attraversata da un senso di angoscia e riprovazione per ciò che è accaduto dalle parti di Bibbiano. Negli anni della prima repubblica De Crescenzo spiegava che in Italia appunto vincevano i partiti «d'amore», quelli caratterizzati da una ideologia carnale e popolaresca riferibile al trinomio - da lui lievemente modificato - di «Dio, patria, giustizia». Dio, ovvero il partito confessionale-soft della Democrazia cristiana. Patria, quindi i missini, che proprio negli anni del primo successo dei libri di De Crescenzo facevano il boom con Almirante capogruppo in consiglio comunale a Napoli. Giustizia sociale, quella a cui facevano, a loro modo, riferimento i comunisti.
Importante dire che nelle pagine dei libri di De Crescenzo non vi era posto per l'odio ideologico. In questo senso De Crescenzo fu un Guareschi del sud. In Così parlò Bellavista il vecchio «monarchico-fascista» discuteva col «comunista» a colpi di battute e di saggezza spicciola più che di chiavi inglesi e P38 come accadeva nel crepuscolo degli anni di piombo.
Nella trasposizione filmica del romanzo, con una discreta prova d'attore dello stesso De Crescenzo, il tema cardine era la rivalità ricomposta tra il professore di filosofia del Sud e il dirigente milanese dell'Alfa Romeo, che a sua volta svelava il suo indole di «meridionale» nei confronti della rigida moglie tedesca che pure si era portata in casa. Situazioni simboliche di quello che poi sarà la tensione di fondo - si spera ricomponibile - del nostro continente.
Chi volesse trarre qualche riflessione seriosa dalla letteratura spicciola di De Crescenzo potrebbe trovare nelle sue tante opere uno spaccato di quella antropologia napoletana, che è riuscita a traghettare nel XXI secolo forme e gesti di una umanità antica o addirittura arcaica. L'avvertimento della jella (ciò che porta male, il nefas dei latini), il tentativo di far propria la Fortuna con piccoli riti quotidiani sono frammenti morenici di una città che brulicava di vita quando l'impero di Roma era ancora in formazione.
De Crescenzo si definiva un «ateo cristiano», ateo per formazione ingegneristica o forse ancor più per il riflesso delle ideologie secolarizzate del Novecento, ma cristiano per sentimento «materno». Quando Giovanni Paolo II venne a Napoli rilasciò al Mattino una dichiarazione che vale come un aforisma di un presocratico: «Santo Padre, lei a Napoli non troverà ateismo, semmai politeismo». Il politeismo di San Gennaro che se la giocava con la Madonna e la Trinità in quanto a potenza riconosciuta dai fedeli e anche il politeismo del fragile semidio Diego Armando, erculeo nelle sue fatiche sul campo di calcio, ma indifeso come un bambino di fronte al mostro postmoderno della droga.
Era consapevole, De Crescenzo, della estrema fragilità dell'edificio sociale della napoletanità. La battuta pronta serviva proprio ad esorcizzare il demone della irriformabilità. Ora che lui se ne è andato, c'è ancora bisogno di un De Crescenzo a Napoli, e per estensione in Italia, per dissolvere con una battuta garbata quei figuri che fanno ridere, ma non sono comici, come il tribuno che annuncia il varo della «flotta partenopea»; oppure quelli che fanno piangere senza essere melodici, come l'assistente sociale che strappa i bambini ai genitori, violentando nell'intimo quel popolo che, magari non solo per retorica, un poco ancora si identifica nel decrescenziano «popolo d'amore».