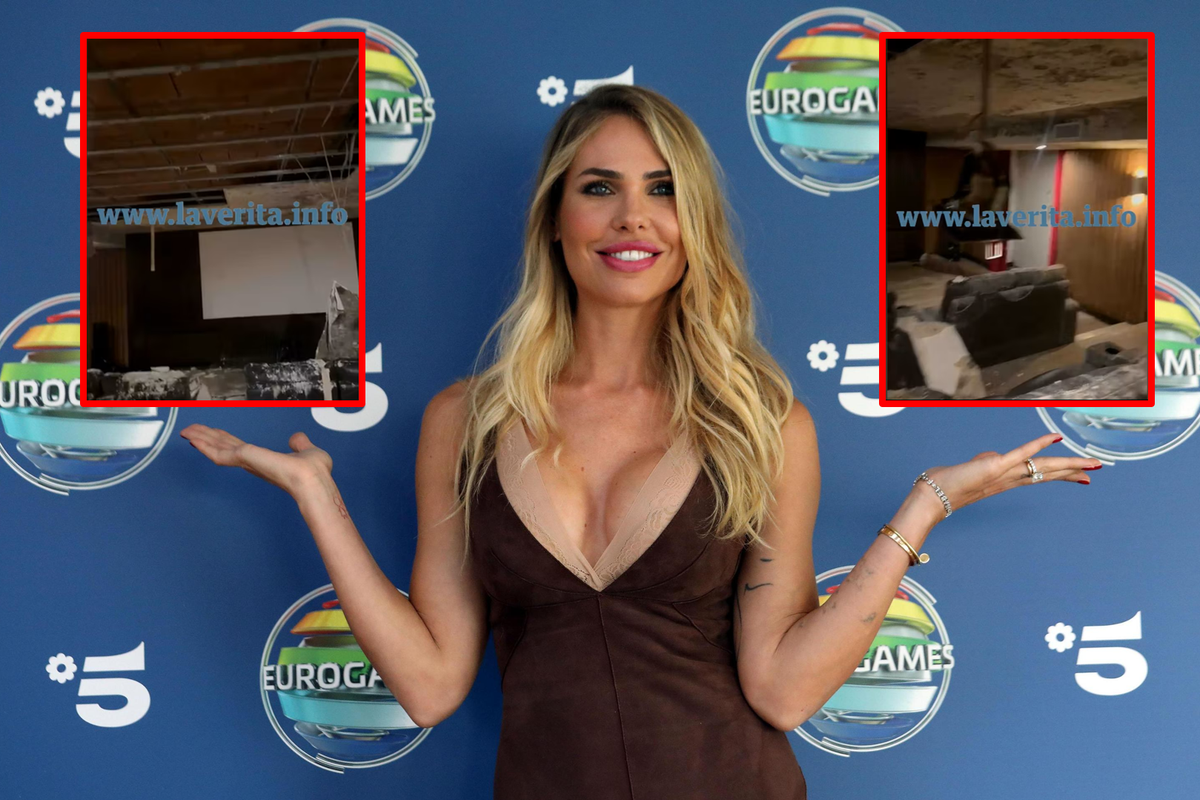Milano: ottant'anni fa i grandi bombardamenti di agosto

- Tra l'8 e il 16 agosto 1943 la città lombarda subì violentissime incursioni notturne da parte della Raf. Bombardamenti a tappeto, con l'intento di terrorizzare la popolazione e spingere l'Italia alla resa.
- I danni furono gravissimi ma Milano fu resiliente. Colpiti migliaia di edifici pubblici e privati, alcuni dei quali furono persi per sempre.
Lo speciale contiene due articoli.
Usciti dal rifugio, dopo il bombardamento, si correva a casa per vedere che cosa fosse successo. Recuperato mio padre di 4 anni dai nonni, tutti sopravvissuti, già prima di voltare l'angolo tra corso San Gottardo e via Giuseppe Lagrange, zona di porta Ticinese, mia nonna Alba Chierico, impiegata, aveva capito che la casa non esisteva più. Neppure qualche ora dopo erano tutti sfollati a Monte Olimpino, Como, a poche decine di metri dal confine svizzero, presso una caserma dei Carabinieri che accolse provvisoriamente lei altre famiglie. Sono certo che tra i lettori milanesi non mancheranno racconti simili, perché i bombardamenti su Milano dell'agosto 1943 suonarono come un accanimento, una punizione che andava oltre la ricerca degli obiettivi di guerra. Il premio Nobel per la letteratura 1959 Salvatore Quasimodo, scosso dalla ferocia degli avvenimenti scrive Milano, agosto 1943 “Invano cerchi tra la polvere, povera mano, la città è morta. È morta: s’è udito l’ultimo rombo sul cuore del Naviglio. E l’usignolo è caduto dall’antenna, alta sul convento, dove cantava prima del tramonto. Non scavate pozzi nei cortili: i vivi non hanno più sete. Non toccate i morti, così rossi, così gonfi, lasciateli nella terra delle loro case, la città è morta, è morta”. Pubblicata nella raccolta Mondadori “Giorno dopo giorno – i poeti allo specchio” del febbraio 1947, è un breve poema nel quale Quasimodo non allude a una perdita in particolare, ma descrive in modo grezzo quanto efficace il fatto che non ci fosse più acqua potabile, fatto che costringeva a correre ai pozzi, rendendo il grande senso di impotenza innanzi a ciò che dei cadaveri emergeva dalle rovine degli edifici.
Dal 1940 in poi Milano fu obiettivo dell'aviazione inglese. Bersagli come l'Alfa Romeo, le Officine Galileo, Magneti Marelli, Borletti, la Tecnomasio Italiana Brown Boveri, Isotta Fraschini, Falck, Pirelli, Ansaldo, Breda, Caproni, erano ritenuti fondamentali così come gli scali ferroviari a est della città da via Farini a Lambrate e fino a Novegro. E poi c'era l'urbanistica a rendere ancora più letali i bombardamenti: lo schema monocentrico con vie molto strette, che determinavano crolli a catena quando veniva centrato un palazzo. Venti minuti, mezzora prima che i bombardieri arrivassero sulla città le sirene annunciavano l'imminente attacco e c'era soltanto quel tempo per raggiungere i rifugi. Ma in quell'agosto di 80 anni fa anche i bombardieri erano diversi: gli Armstrong Witworth Whitley, che dovendo imbarcare molto carburante per tornare in Inghilterra, non potevano trasportare più di 1.800 kg di bombe incendiarie, avevano lasciato il posto ai più grandi quadrimotori Halifax, Wellington e Stirling, con carichi bellici che andavano da 5.800 a 6.500 kg, nonché in seguito velivoli della Mediterranean allied air force, i B-17 Fortezza volante e B-24 Liberator che partivano dal sud Italia liberato. E mentre all'inizio del conflitto le incursioni erano prevalentemente notturne, in seguito gli attacchi si verificarono a tutte le ore, con i bombardieri che decollavano dalla Puglia e risalivano lo Stivale dall'Adriatico.
Già nel febbraio del 1943 mezza Milano fu fortemente danneggiata, compresa la Centrale del Latte, il deposito tramviario di via Messina e praticamente tutte le fabbriche. Oltre duecento le case distrutte e altrettante quelle danneggiate, con incendi che durarono giorni per i quali fu necessario richiamare vigili del Fuoco da Bologna. L'ufficio comunale registrò oltre 10.000 senzatetto. Dopo l'arresto di Mussolini, 25 luglio, nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1943 su Milano si scatenò l'inferno: attorno all'una i Lancaster inglesi colpirono porta Venezia e Garibaldi, corso Sempione, Magenta e Ticinese. Fu centrato l'ospedale Fatebenefratelli, distrutto il teatro Filodrammatici, la sede del Corriere della Sera, il Castello, palazzo Sormani e la Villa Reale. Seicento edifici rasi al suolo, circa duecento le vittime, in un inferno che si ripeterà la notte del 12, con un numero enorme di velivoli, oltre 500, arrivati con lo scopo di annientare la città come stava accadendo in Germania, con la tattica del “vortice di fuoco”. Mezzanotte e trenta, suonano le sirene, le bombe colpiscono il centro della città, viene centrato Palazzo Marino, la Questura, bruciano le chiese di San Fedele e Santa Maria delle Grazie, il Duomo. La Raf rade al suolo metà dei quartieri Ticinese, Sempione, Garibaldi. Sembra una striscia dall'alto, una cicatrice che rimarrà visibile fino a metà anni Cinquanta. La mattina dopo a rendere peggiori le cose è il vento, che alimenta e propaga le fiamme, tanto che dalle alture di Como, verso sera, la scena è quella che in mezzo alla pianura l'inferno dantesco sia divenuto realtà. Nessuno tra coloro che l'ha visto lo dimentica, tramandando storie di famiglie intere in fuga accolte nei paesi fino sui laghi di Como e sul Maggiore.
Nell'aria irrespirabile i milanesi organizzano trasporti per sfollare i sopravvissuti, lasceranno la città 245.000 persone che faranno ritorno soltanto anni dopo. Ferragosto: a mezzanotte e mezza una formazione di 138 bombardieri sfrutta il bagliore degli incendi ancora attivi per prendere la mira, e vengono colpiti ancora il Castello e le zone dei teatri Dal Verme e Verdi ed anche il Palazzo Reale. Manca l'acqua, che servirebbe per limitare gli incendi ed eliminare almeno i focolai, perché le tubazioni dell'acquedotto di via Crema sono saltate in aria. La notte successiva, più o meno alla stessa ora, le bombe cadono sul Duomo, sul teatro alla Scala, sulla Rinascente che viene del tutto distrutta, sulle stamperie dei principali giornali. Il censimento comunale del 30 agosto riporta che la metà delle case di Milano non sono abitabili, gli sfollati oltre 300.000, l'ospedale Cà Granda è stato centrato da diverse bombe, la cupola di Santa Maria delle Grazie è danneggiata ma il Cenacolo si salva, impacchettato da un muro si sabbia messo apposta per proteggerlo. Nell'inverno successivo furono abbattuti migliaia di alberi appartenenti al piano urbanistico Beruto per alimentare le stufe, riducendone il numero da circa 80.000 a meno di 30.000. Nulla rispetto a quanto stiamo facendo oggi per un temporale. Il 1944 non fu migliore per Milano, ma la grande quantità di sfollati limitò relativamente le perdite umane. Gli ultimi attacchi che si ricordino avvennero il 12 e 13 aprile 1945, a opera di caccia alleati che mitragliarono a bassa quota la via Manzoni e Lambrate. Al termine del conflitto la città aveva subito 61 attacchi aerei e dalla grande quantità di macerie rimosse dalle zone colpite nasce la Montagnetta di San Siro.
Milano, agosto 1943. Quelle macerie che cambiarono il volto alla città
Milano: una settimana all’Inferno. Così si potrebbe definire l’incubo vissuto dal capoluogo lombardo per gli effetti della morte venuta dal cielo tra l’8 e il 16 agosto 1943. Quei giorni di una calda estate di ottant’anni fa videro le incursioni più violente di tutti gli anni di guerra, vissuti tra l’illusione della fine imminente del conflitto e la successiva occupazione tedesca dell’Italia settentrionale.
Centinaia di quadrimotori della Royal Air Force furono inviati dalle basi inglesi per annichilire la capitale economica e industriale d’Italia. Ma non solo: l’obiettivo del Bomber Command britannico era il centro urbano tout court, al fine di terrorizzare la popolazione affinché si affrettasse il percorso di resa del Paese. Una strategia, dunque, a tutti gli effetti terroristica, chiamata in inglese «area bombing» che in italiano si può tradurre come bombardamento «a tappeto». Per distruggere Milano e stringerla in una tempesta di fuoco i comandi della Raf non risparmiarono neppure un bombardiere, concentrando in quelle notti limpide quasi tutta la forza disponibile. La devastazione fu indubbiamente impressionante ma, come si vedrà dopo l’esito dei bombardamenti di agosto 1943, Milano fu in grado di resistere seppur gravemente ferita. Costruita con ampio uso di cemento e pietra non fece la fine delle città tedesche, le cui abitazioni in legno alimentarono le fiamme creando quello che gli Alleati cercavano: la «feuersturm», un turbine mortale di vento e fuoco che carbonizzò case e centinaia di migliaia di civili. Milano invece protesse per quanto possibile i suoi abitanti e il bilancio delle vittime fu relativamente leggero. Come l’Araba fenice, la città all’ombra del Duomo (danneggiato anch’esso dagli ordigni), rinacque dalle macerie resistendo per gli ultimi lunghissimi mesi prima della fine della guerra.
Tutti i bombardamenti di agosto avvennero nelle ore notturne date le caratteristiche dei bombardieri inglesi, che saranno poi sostituiti dagli Americani per gli anni 1944 e parte del 1945 e non lasciarono tregua a Milano, pur attaccando la città nelle ore diurne e con strategie più «chirurgiche» e concentrate su obiettivi logistici e militari.
La prima notte in cui urlarono le sirene fu quella tra il 7 e l’8 agosto 1943 e l’incursione durò dalle 00:52 alle 02:23. A terra erano stati colpiti oltre 600 edifici, anche se l’uso prevalente di bombe incendiarie piuttosto che dirompenti limitò i danni. Tra le fabbriche (Pirelli, Innocenti, Bianchi e altre) e gli edifici pubblici (la Stazione Centrale e lo Scalo Farini) il danno più rilevante per il patrimonio architettonico cittadino fu la distruzione completa dell’antico Teatro Filodrammatici realizzato su disegno dell’architetto neoclassico Luigi Canonica, di cui si salverà solo la facciata liberty rifatta nel 1904. Anche il teatro Dal Verme fu raso al suolo, venendo poi ricostruito nel dopoguerra non più come palco d’opera ma come cinema.
I Vigili del fuoco e gli addetti dell’Unpa (ente nazionale della protezione antiaerea) avevano da poco domato gli incendi e ripristinato gas e luce che la notte tra il 12 e il 13 agosto suonò nuovamente l’allarme. Si trattava dell’incursione aerea più massiccia di tutte quelle subite da Milano durante la guerra: ben 504 bombardieri imperversarono sulla città già ferita dalle 00:35 alle 02:47. Furono lanciate 2.000 tonnellate di bombe e 380.000 spezzoni incendiari che non lasciarono scampo a migliaia di edifici. Fu la notte della distruzione di Palazzo Marino, dei gravi danneggiamenti al Castello Sforzesco, alla Questura, alla chiesa di San Fedele e a quella di Santa Maria delle Grazie, dove si salvò per miracolo il Cenacolo vinciano. Di nuovo, la notte successiva, gli Inglesi tornarono per terminare il lavoro di distruzione e colpirono Palazzo Reale, la basilica di Sant’Ambrogio e di striscio anche il Duomo. Mentre la popolazione sfinita e terrorizzata cercava rifugio temporaneo nelle campagne circostanti, Milano fu colpita ancora nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Quello che fu l’ultimo dei grandi bombardamenti notturni su Milano si portò via il simbolo dell’Opera mondiale, il Teatro alla Scala, centrato in pieno da ordigni dirompenti che ne distrussero la copertura e fecero crollare i palchi settecenteschi. Anche il Duomo fu nuovamente colpito, questa volta più seriamente. Centrati anche il Conservatorio e l’Archivio di Stato di via Senato. Quando l’ultimo bombardiere lasciò il cielo della città alle 02:22 oltre il 50% degli edifici cittadini era stato distrutto o danneggiato. Oltre ai più noti monumenti civili e religiosi devastati dalle bombe un gran numero di palazzi storici erano ridotti ad un cumulo di macerie, con le facciate pericolanti e le finestre come tanti occhi vuoti. Diversi fra questi scomparvero per sempre sostituiti da nuove costruzioni nel dopoguerra, che cambiarono il volto a molte vie del centro storico. E’il caso del Palazzo Caccia Dominioni di piazza Sant’Ambrogio, colpito la notte di Ferragosto da bombe dirompenti. Il palazzo neoclassico sarà demolito e sostituito su progetto dello stesso proprietario, l’architetto Luigi Caccia Dominioni, con un palazzo dalle linee moderne e più alto di un piano. Stessa tragica sorte per il meraviglioso Palazzo Perego di Cremnago con annesso parco sulla via Borgonuovo. Costruito nel Cinquecento, fu ampiamente rivisto ed abbellito facendone una delle dimore più lussuose di Milano. Le bombe lo colpirono due volte, nelle incursioni del 14 e 15 agosto. Ulteriormente violato da numerosi atti di sciacallaggio, fu demolito nel 1948 e sostituito da una struttura moderna per opera dell’architetto Antonio Cassi Ramelli. Un edificio che portava un nome estremamente evocativo e che scomparve dalle mappe cittadine la notte del 16 agosto 1943 era il Palazzo Arconati Dalmati Radetzky. Sorto in via Brisa alla metà del Settecento, fu la residenza del Generale austroungarico Josef Radetzky che ricevette nei suoi saloni la visita dell’Imperatore. Le glorie del passato, cancellate dalle bombe inglesi, scomparvero sostituite da un alquanto anonimo palazzo terminato nel 1952. Del Palazzo Visconti di Modrone in via Cerva si salvò solo una parte della balaustra ad arcate in continuum con il magnifico giardino, oggi inglobata assieme a altri elementi superstiti in un edificio realizzato nel 1950. Stessa sorte per il palazzo Piantanida di via Olmetto, di cui si conservano tre arcate del porticato nel cortile di un nuovo e più grande palazzo anni Cinquanta. Durante i bombardamenti dell’agosto 1943 Milano perse anche uno storico albergo, il Gran Bretagna. Progettato da Luigi Canonica, fu costruito nel 1822 e finì la sua vita durante l’incursione del 14-15 agosto e fu sostituito da un palazzo che oggi ospita una catena di abbigliamento.
Le incursioni di agosto 1943 segnarono anche la fine di un intero quartiere del centro di Milano. A sud del Duomo, nella zona dell’attuale piazza Diaz, sorgeva l’antico borgo del Bottonuto, già nodo idraulico per le acque del fiume Seveso dove sorgeva una piccola darsena per i barconi della Fabbrica del Duomo. Nonostante la posizione centrale, il quartiere godeva di cattiva fama. Nelle sue vecchie e fatiscenti case avevano trovato terreno fertile le case di tolleranza e le attività della piccola malavita milanese. Già nel mirino dei piani regolatori degli anni Trenta, quando cominciarono le prime demolizioni, fu pesantemente colpito dalle incursioni aeree dell’agosto 1943 e nel dopoguerra sparì totalmente con la sistemazione dell’area di via Larga, che diede spazio a nuovi edifici ad uso commerciale.
La Milano segnata da quelle notti di terrore non cadde in ginocchio. Gli Alleati capirono, con le ricognizioni aeree dei giorni successivi, che la città era resiliente anche grazie alla fattura delle sue case e dei viali ampi che impedivano il propagarsi degli incendi. Con le prime voci dell’imminente armistizio smisero i bombardamenti a tappeto nelle ore notturne, ma il capoluogo lombardo fu destinato a subirne molte altre per opera dell’Usaf, che prese in mano le redini dei bombardamenti sull’Italia tra il 1944 e il 1945. Nonostante l’abbandono della strategia dell’aviazione britannica, il bombardamento terroristico, molte saranno le abitazioni civili colpite dagli Americani. Pur attuando il bombardamento strategico su obiettivi logistici e militari, l’imprecisione del puntamento porterà alla distruzione di molti edifici ad uso civile. Sopra tutti, l’episodio del 20 ottobre 1944 quando a causa di un errore di rotta un ordigno colpì la scuola elementare «Francesco Crispi» nel popolare quartiere di Gorla, causando la morte di 184 bambini e delle loro maestre.