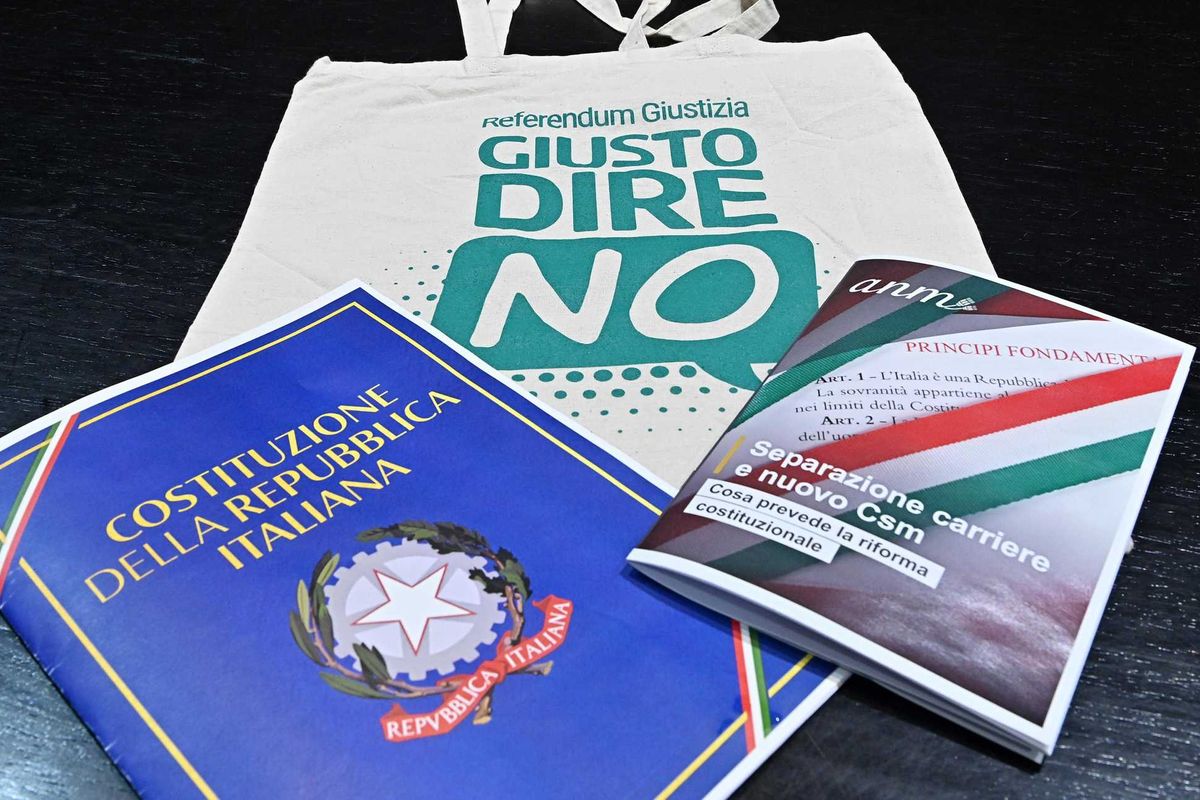True
2025-04-20
Le microcar italiane. Piccolissime e geniali
True
La «Urbanina» al Salone di Torino del 1965 (Getty Images)
Negli anni Sessanta, quelli del «boom» e della motorizzazione di massa, per la prima volta si discusse di problemi legati al traffico urbano e agli ingorghi. La diffusione sempre più ampia delle quattro ruote fece riflettere alcuni pionieri italiani delle city car in cerca di soluzioni originali e innovative che avrebbero potuto, se non sostituire, almeno affiancare le automobili tradizionali con soluzioni che in alcuni casi si sarebbero rivelate anticipatrici di quelle che oggi si vedono sulle strade. La storia delle microcar italiane, che rappresenta certamente una nicchia nel panorama della produzione automobilistica italiana del periodo, è in ogni caso interessante per ricordare quanto il genio industriale italiano sia stato in grado di anticipare i tempi. Il piccolo mondo delle mini vetture nate in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta nacque infatti da esponenti di vari settori dell’industria nazionale non sempre legati al mondo delle quattro ruote, ma interessati a contribuire all’evoluzione e all’innovazione non senza un pizzico di spirito sognatore. Il primo caso è emblematico di quanto affermato, e la sua storia si è svolta tra le colline toscane nei primi anni Sessanta.
Un marchese infastidito dal rumore e dal traffico. La «Urbanina» di Pier Girolamo Bargagli Bardi Bandini
A Poggio Adorno, nell’entroterra pisano, c’è la splendida villa della famiglia Bargagli. Qui il marchese Pier Girolamo Bargagli Bardi Bandini era solito trascorrere parte dell’anno immerso nella quiete della campagna toscana, tra lussureggianti giardini e vigneti. La restante parte la trascorreva nel centro di Roma. La Capitale del «boom» era già nei primi anni Sessanta intasata dalle automobili, un ambiente tanto diverso da quello della «sua» campagna, quasi immota e totalmente avvolta dal silenzio. In un giorno particolarmente trafficato, il marchese Bargagli ebbe un’illuminazione, quasi un sogno ad occhi aperti. Immaginò per un attimo che quel groviglio di auto che affollavano la rotonda di piazza Augusto Imperatore si potesse trasformare in un carosello di mini automobili ordinate e variopinte. Pensò che per realizzare quel sogno ad occhi aperti, sarebbe stato necessario eliminare il «davanti e il dietro» di quelle auto tanto ingombranti. Nacque così l’idea della «Urbanina», una capostipite dalla quale avrebbero tratto ispirazione altre microcar che la seguirono. Per la progettazione della piccola quattro ruote pensò di coinvolgere un «vicino di casa» in Toscana, Narciso Cristiani. Quest’ultimo era un appassionato di meccanica che, dopo aver lavorato alla vicina Piaggio di Pontedera con l’ingegner Corradino d’Ascanio, si era messo in proprio. Cristiani si mise al lavoro e progettò una microcar proiettata nel futuro, forse nata troppo in anticipo sui tempi. La «Urbanina» era un micro-concentrato di innovazione, per meno di due metri di lunghezza. Il telaio era una «X», ai cui estremi erano fissate le ruote dotate di sistema di sospensioni a ruote indipendenti (una soluzione che sarà adottata anni dopo dalle grandi case automobilistiche). Ma il capolavoro di Cristiani era la carrozzeria, che fissata ad un grande disco che faceva da base, poteva ruotare di 360° permettendo la discesa di guidatore e passeggero in ogni posizione, anteriore laterale o posteriore. L’abitacolo tondeggiante, che faceva assomigliare la piccola vettura a una tinozza, era modulabile e disponibile in tre diverse configurazioni: chiusa con una carrozzeria in vetroresina, in versione «primavera» con carrozzeria aperta in vimini e estiva, corredata del solo parabrezza. Inizialmente fu dotata del motore a due tempi da 175cc (portati poi a 198cc) della Lambretta, che facevano raggiungere alla piccola toscana la considerevole velocità di circa 70 Km/h. Ma la «Urbanina», con il motore a scoppio a miscela faceva troppo rumore e il marchese Bargagli era molto sensibile a quell’aspetto. L’idea di montare un motore elettrico fu dunque dettata più dal desiderio di silenzio che da una coscienza «green», a quei tempi inesistente. Così come la tecnologia applicata alle batterie per autotrazione era in una fase primordiale. Ancora una volta furono il genio e la capacità di adattare i materiali a disposizione a suggellare un successo e ad anticipare il futuro. In mancanza di componentistica adeguata, Cristiani usò quello che era rimasto dalla guerra, montando sulla sua piccola vettura il motore elettrico da 1Kw usato sulle torrette dei cannoni delle navi tedesche di produzione Bosch. Anche se le prestazioni e l’autonomia rimasero modeste, la macchinetta era silenziosa. Non essendoci ancora la possibilità di montare un cambio automatico adatto ai motori elettrici come il moderno cvt, anche in questo caso il padre della «Urbanina» si inventò un cambio a tre velocità che agiva sulle batterie e sul voltaggio, anche se risultò inizialmente brusco. Le batterie furono migliorate con l’aiuto della azienda leader Tudor, che fornì un particolare modello in grado di essere sistemato sotto al telaio e di essere interscambiabile con le batterie già cariche, una soluzione oggi utilizzata da Tesla. La piccola di Poggio Adorno fu presentata al Salone dell’automobile di Torino nel 1965, e passò attraverso tre serie fino al 1971. Nella seconda serie la piccola elettrica perse la carrozzeria originale in quanto Cristiani riuscì a ottenere come ex dipendente una fornitura di cabine del motocarro Piaggio «Ape», mentre l’ultima serie vide l’adozione di una carrozzeria tradizionale e non pivotante come la precedente.
Dalla Toscana a Milano. Zagato e le microcar «Milanina» e «Zele»
La minicar del marchese Bargagli non arrivò a conquistare le strade di Roma e delle altre grandi città italiane, come il nobiluomo toscano aveva sognato. L’idea di una microvettura negli italiani che avevano appena conquistato le quattro ruote non fece breccia, ricordando troppo l’essenza di uno scooter, oltre a presentare problemi di ricarica e di prestazioni. A recuperare il capolavoro di creatività di Cristiani pensò il grande designer Elio Zagato, che aveva appena ricevuto una commessa dalla Fiera di Milano per la realizzazione ad uso interno di mini vetture a trazione elettrica. Zagato aveva visto la «Urbanina» presentata a Torino e non ebbe dubbi. Si presentò a Poggio Adorno e acquisì il brevetto. Nacque così la «Milanina», come fu ribattezzata con un’assonanza voluta in omaggio alla città che ospitava la grande Fiera Campionaria. La carrozzeria in materiale antiurto portava evidentemente la firma e lo stile del designer, con una linea questa volta accattivante. Fu adottata per la prima volta all’interno dell’edizione fieristica del 1972, dove le piccole elettriche con la livrea giallo limone si muovevano da un padiglione all’altro in assoluto silenzio. Neppure la «Milanina» ebbe un seguito commerciale e una produzione in serie. Tuttavia Zagato non abbandonò l’idea che fu del marchese Bargagli. A venirgli incontro furono la crisi petrolifera mondiale del 1973, quella che in Italia portò le domeniche a piedi e la conseguente contrazione del settore automobilistico. Il designer pensò che un’evoluzione della microcar avrebbe potuto trovare nuovi spazi nel contesto urbano. Così nacque la Zagato «Zele», acronimo per «Zagato ELEttrica». L’evoluzione della «Urbanina» vide un restyling in linea con i gusti dei primi anni Settanta, con linee squadrate e colori sgargianti. Da un punto di vista tecnico la nuova microcar avanzò in termini di prestazioni e autonomia e fu proposta in tre versioni, il cui nome corrispondeva alla potenza in watt dei motori (1000, 1500, 2000). L’autonomia arrivò a coprire dai 70 ai 100 km. Niente male per una elettrica in quegli anni. La mini Zele fu costruita in circa 200 esemplari, che oggi sono molto ricercati dai collezionisti, mentre nel 1989 la «Milanina» ricomparve per una stagione alla Fiera di Milano con una veste più moderna (che ricorda molto quella degli attuali quadricicli elettrici), ancora una volta firmata dalla matita del designer milanese. La Zele fu assemblata in numero limitato anche per il mercato degli Stati Uniti e ribattezzata ElCar (Electric Car).
Due minuscole fuoristrada made in Italy: Ferves «Ranger» e Lawil «Varzina»
Altre due storie che riguardano le microcar italiane nascono dall’estro di personaggi legati al mondo industriale degli anni Sessanta. La Ferves «Ranger» fu un vero e proprio fuoristrada in miniatura. Presentata nel 1966 fu progettata e costruita dall’ingegnere torinese Carlo Ferrari, titolare della «Ferves-Ferrari Veicoli Speciali» in un piccolo stabilimento in via Mombasiglio, nel cuore del capoluogo piemontese. La vicinanza con la Fiat portò naturalmente alla scelta della meccanica derivata dal modello protagonista della motorizzazione italiana, la «500». La «Ranger» era però un esercizio di stile, pensata per l’uso in fuoristrada così come in città, date le dimensioni ridotte. Il design della carrozzeria stava a metà tra un mezzo militare e un «lunar rover» di fantasia, negli anni d’oro della corsa allo spazio. Dalle forme tondeggianti, la Ranger nascondeva sotto la carrozzeria di tipo cabriolet con parabrezza totalmente abbattibile la trazione integrale (nel modello di punta). Il piccolo propulsore bicilindrico della Fiat «500» muoveva una meccanica composta da diversi componenti del gruppo torinese (ad esempio i semiassi dell’Autobianchi «Primula») e spingeva la piccola jeep alla modesta velocità di circa 75 km/h. Dotata di marce ridotte, la Ferves dichiarava la possibilità di superamento di pendenze fino al 100% (45°) e veniva venduta e assistita dalla rete ufficiale Fiat. Fu presentato, sulla stessa meccanica, anche un mini furgoncino. Tra il debutto del 1966 e la fine della produzione nel 1969 furono costruiti circa 600 esemplari nelle diverse configurazioni. Oggi la «Ranger» risulta essere un pezzo molto ambito dai collezionisti di auto d’epoca, tanto che un esemplare è stato recentemente battuto da una casa d’aste mondiale per la cifra astronomica di 196.000 dollari.
La cittadina di Varzi, immersa nelle colline dell’Oltrepò Pavese, è la cornice della storia di una microcar italiana e del suo creatore, Carlo Lavezzari, la cui vita meriterebbe una trattazione dedicata. Nativo di un piccolo paese a breve distanza da Varzi e di origini umili, fu l’unico a scampare alla strage della sua famiglia avvenuta il 26 febbraio 1945 per mano partigiana, a causa di motivi personali mai chiariti. Il giovane Carlo, che si arrangiò come poteva, iniziò la carriera da camionista e poi da commerciante di residuati bellici e rottami ferrosi. Dai proventi di questa prima attività, il self made man (laureatosi nel frattempo in ingegneria) fondò un impero della siderurgia e delle lavorazioni metalliche che lo porterà ad essere a capo di 16 aziende e a occupare il posto di presidente Iritecna, oltre che di senatore della Dc con un rapporto privilegiato con Giulio Andreotti. L’avventura nel mondo delle mini vetture fu quasi un omaggio ai luoghi delle sue origini. Dove sorgeva il fiore all’occhiello delle industrie di Lavezzari, la Zincor, iniziò la produzione di una micro vettura disegnata dal carrozziere Scattolini, che ricordava, in soli 1,78 metri di lunghezza, una microscopica Jeep «Willys». Presentata nel 1966, la «Varzina» era inizialmente spinta dal motore due tempi da 125cc della Lambretta, rendendo la mini vettura più simile a un quadriciclo che a una vera automobile in miniatura. Dopo l’accordo con l’ingegnere francese Henri Willame (il Nome Lawil nasceva infatti dall’unione delle iniziali dei cognomi di Lavezzari e Willame) che decise di importarla oltralpe dove la piccola lombarda era guidabile senza patente, la produzione in serie della «Varzina» entrò a regime e sarebbe durata dal 1966 al 1982. Negli anni la microcar ebbe importanti evoluzioni tecniche. Il motore della Lambretta, insufficiente per considerare la «Varzina» una vera e propria auto, fu affiancato da un propulsore sempre a miscela di 250cc fornito dalla bolognese BCB. Più performante, il nuovo motore riusciva a spingere la mini fuoristrada a circa 80 km/h. La piccola di Varzi, che ebbe successo in particolar modo in Francia dove fu usata anche dai servizi postali nazionali, fu costruita anche in Indonesia come risciò motorizzato denominato «Super Helicak» prodotto dalla Italindo partecipata da Lavezzari. La Varzina è stata prodotta in circa 20mila esemplari nelle varie configurazioni, tra le quali anche una versione furgonata.
Continua a leggereRiduci
Tra gli anni '60 e '70 fiorì una piccola produzione di mini auto che anticiparono di mezzo secolo alcune soluzioni attuali. Erano nate dall'estro di imprenditori figli del dopoguerra e cresciuti con il «boom» economico.Negli anni Sessanta, quelli del «boom» e della motorizzazione di massa, per la prima volta si discusse di problemi legati al traffico urbano e agli ingorghi. La diffusione sempre più ampia delle quattro ruote fece riflettere alcuni pionieri italiani delle city car in cerca di soluzioni originali e innovative che avrebbero potuto, se non sostituire, almeno affiancare le automobili tradizionali con soluzioni che in alcuni casi si sarebbero rivelate anticipatrici di quelle che oggi si vedono sulle strade. La storia delle microcar italiane, che rappresenta certamente una nicchia nel panorama della produzione automobilistica italiana del periodo, è in ogni caso interessante per ricordare quanto il genio industriale italiano sia stato in grado di anticipare i tempi. Il piccolo mondo delle mini vetture nate in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta nacque infatti da esponenti di vari settori dell’industria nazionale non sempre legati al mondo delle quattro ruote, ma interessati a contribuire all’evoluzione e all’innovazione non senza un pizzico di spirito sognatore. Il primo caso è emblematico di quanto affermato, e la sua storia si è svolta tra le colline toscane nei primi anni Sessanta.Un marchese infastidito dal rumore e dal traffico. La «Urbanina» di Pier Girolamo Bargagli Bardi BandiniA Poggio Adorno, nell’entroterra pisano, c’è la splendida villa della famiglia Bargagli. Qui il marchese Pier Girolamo Bargagli Bardi Bandini era solito trascorrere parte dell’anno immerso nella quiete della campagna toscana, tra lussureggianti giardini e vigneti. La restante parte la trascorreva nel centro di Roma. La Capitale del «boom» era già nei primi anni Sessanta intasata dalle automobili, un ambiente tanto diverso da quello della «sua» campagna, quasi immota e totalmente avvolta dal silenzio. In un giorno particolarmente trafficato, il marchese Bargagli ebbe un’illuminazione, quasi un sogno ad occhi aperti. Immaginò per un attimo che quel groviglio di auto che affollavano la rotonda di piazza Augusto Imperatore si potesse trasformare in un carosello di mini automobili ordinate e variopinte. Pensò che per realizzare quel sogno ad occhi aperti, sarebbe stato necessario eliminare il «davanti e il dietro» di quelle auto tanto ingombranti. Nacque così l’idea della «Urbanina», una capostipite dalla quale avrebbero tratto ispirazione altre microcar che la seguirono. Per la progettazione della piccola quattro ruote pensò di coinvolgere un «vicino di casa» in Toscana, Narciso Cristiani. Quest’ultimo era un appassionato di meccanica che, dopo aver lavorato alla vicina Piaggio di Pontedera con l’ingegner Corradino d’Ascanio, si era messo in proprio. Cristiani si mise al lavoro e progettò una microcar proiettata nel futuro, forse nata troppo in anticipo sui tempi. La «Urbanina» era un micro-concentrato di innovazione, per meno di due metri di lunghezza. Il telaio era una «X», ai cui estremi erano fissate le ruote dotate di sistema di sospensioni a ruote indipendenti (una soluzione che sarà adottata anni dopo dalle grandi case automobilistiche). Ma il capolavoro di Cristiani era la carrozzeria, che fissata ad un grande disco che faceva da base, poteva ruotare di 360° permettendo la discesa di guidatore e passeggero in ogni posizione, anteriore laterale o posteriore. L’abitacolo tondeggiante, che faceva assomigliare la piccola vettura a una tinozza, era modulabile e disponibile in tre diverse configurazioni: chiusa con una carrozzeria in vetroresina, in versione «primavera» con carrozzeria aperta in vimini e estiva, corredata del solo parabrezza. Inizialmente fu dotata del motore a due tempi da 175cc (portati poi a 198cc) della Lambretta, che facevano raggiungere alla piccola toscana la considerevole velocità di circa 70 Km/h. Ma la «Urbanina», con il motore a scoppio a miscela faceva troppo rumore e il marchese Bargagli era molto sensibile a quell’aspetto. L’idea di montare un motore elettrico fu dunque dettata più dal desiderio di silenzio che da una coscienza «green», a quei tempi inesistente. Così come la tecnologia applicata alle batterie per autotrazione era in una fase primordiale. Ancora una volta furono il genio e la capacità di adattare i materiali a disposizione a suggellare un successo e ad anticipare il futuro. In mancanza di componentistica adeguata, Cristiani usò quello che era rimasto dalla guerra, montando sulla sua piccola vettura il motore elettrico da 1Kw usato sulle torrette dei cannoni delle navi tedesche di produzione Bosch. Anche se le prestazioni e l’autonomia rimasero modeste, la macchinetta era silenziosa. Non essendoci ancora la possibilità di montare un cambio automatico adatto ai motori elettrici come il moderno cvt, anche in questo caso il padre della «Urbanina» si inventò un cambio a tre velocità che agiva sulle batterie e sul voltaggio, anche se risultò inizialmente brusco. Le batterie furono migliorate con l’aiuto della azienda leader Tudor, che fornì un particolare modello in grado di essere sistemato sotto al telaio e di essere interscambiabile con le batterie già cariche, una soluzione oggi utilizzata da Tesla. La piccola di Poggio Adorno fu presentata al Salone dell’automobile di Torino nel 1965, e passò attraverso tre serie fino al 1971. Nella seconda serie la piccola elettrica perse la carrozzeria originale in quanto Cristiani riuscì a ottenere come ex dipendente una fornitura di cabine del motocarro Piaggio «Ape», mentre l’ultima serie vide l’adozione di una carrozzeria tradizionale e non pivotante come la precedente.Dalla Toscana a Milano. Zagato e le microcar «Milanina» e «Zele»La minicar del marchese Bargagli non arrivò a conquistare le strade di Roma e delle altre grandi città italiane, come il nobiluomo toscano aveva sognato. L’idea di una microvettura negli italiani che avevano appena conquistato le quattro ruote non fece breccia, ricordando troppo l’essenza di uno scooter, oltre a presentare problemi di ricarica e di prestazioni. A recuperare il capolavoro di creatività di Cristiani pensò il grande designer Elio Zagato, che aveva appena ricevuto una commessa dalla Fiera di Milano per la realizzazione ad uso interno di mini vetture a trazione elettrica. Zagato aveva visto la «Urbanina» presentata a Torino e non ebbe dubbi. Si presentò a Poggio Adorno e acquisì il brevetto. Nacque così la «Milanina», come fu ribattezzata con un’assonanza voluta in omaggio alla città che ospitava la grande Fiera Campionaria. La carrozzeria in materiale antiurto portava evidentemente la firma e lo stile del designer, con una linea questa volta accattivante. Fu adottata per la prima volta all’interno dell’edizione fieristica del 1972, dove le piccole elettriche con la livrea giallo limone si muovevano da un padiglione all’altro in assoluto silenzio. Neppure la «Milanina» ebbe un seguito commerciale e una produzione in serie. Tuttavia Zagato non abbandonò l’idea che fu del marchese Bargagli. A venirgli incontro furono la crisi petrolifera mondiale del 1973, quella che in Italia portò le domeniche a piedi e la conseguente contrazione del settore automobilistico. Il designer pensò che un’evoluzione della microcar avrebbe potuto trovare nuovi spazi nel contesto urbano. Così nacque la Zagato «Zele», acronimo per «Zagato ELEttrica». L’evoluzione della «Urbanina» vide un restyling in linea con i gusti dei primi anni Settanta, con linee squadrate e colori sgargianti. Da un punto di vista tecnico la nuova microcar avanzò in termini di prestazioni e autonomia e fu proposta in tre versioni, il cui nome corrispondeva alla potenza in watt dei motori (1000, 1500, 2000). L’autonomia arrivò a coprire dai 70 ai 100 km. Niente male per una elettrica in quegli anni. La mini Zele fu costruita in circa 200 esemplari, che oggi sono molto ricercati dai collezionisti, mentre nel 1989 la «Milanina» ricomparve per una stagione alla Fiera di Milano con una veste più moderna (che ricorda molto quella degli attuali quadricicli elettrici), ancora una volta firmata dalla matita del designer milanese. La Zele fu assemblata in numero limitato anche per il mercato degli Stati Uniti e ribattezzata ElCar (Electric Car). Due minuscole fuoristrada made in Italy: Ferves «Ranger» e Lawil «Varzina»Altre due storie che riguardano le microcar italiane nascono dall’estro di personaggi legati al mondo industriale degli anni Sessanta. La Ferves «Ranger» fu un vero e proprio fuoristrada in miniatura. Presentata nel 1966 fu progettata e costruita dall’ingegnere torinese Carlo Ferrari, titolare della «Ferves-Ferrari Veicoli Speciali» in un piccolo stabilimento in via Mombasiglio, nel cuore del capoluogo piemontese. La vicinanza con la Fiat portò naturalmente alla scelta della meccanica derivata dal modello protagonista della motorizzazione italiana, la «500». La «Ranger» era però un esercizio di stile, pensata per l’uso in fuoristrada così come in città, date le dimensioni ridotte. Il design della carrozzeria stava a metà tra un mezzo militare e un «lunar rover» di fantasia, negli anni d’oro della corsa allo spazio. Dalle forme tondeggianti, la Ranger nascondeva sotto la carrozzeria di tipo cabriolet con parabrezza totalmente abbattibile la trazione integrale (nel modello di punta). Il piccolo propulsore bicilindrico della Fiat «500» muoveva una meccanica composta da diversi componenti del gruppo torinese (ad esempio i semiassi dell’Autobianchi «Primula») e spingeva la piccola jeep alla modesta velocità di circa 75 km/h. Dotata di marce ridotte, la Ferves dichiarava la possibilità di superamento di pendenze fino al 100% (45°) e veniva venduta e assistita dalla rete ufficiale Fiat. Fu presentato, sulla stessa meccanica, anche un mini furgoncino. Tra il debutto del 1966 e la fine della produzione nel 1969 furono costruiti circa 600 esemplari nelle diverse configurazioni. Oggi la «Ranger» risulta essere un pezzo molto ambito dai collezionisti di auto d’epoca, tanto che un esemplare è stato recentemente battuto da una casa d’aste mondiale per la cifra astronomica di 196.000 dollari.La cittadina di Varzi, immersa nelle colline dell’Oltrepò Pavese, è la cornice della storia di una microcar italiana e del suo creatore, Carlo Lavezzari, la cui vita meriterebbe una trattazione dedicata. Nativo di un piccolo paese a breve distanza da Varzi e di origini umili, fu l’unico a scampare alla strage della sua famiglia avvenuta il 26 febbraio 1945 per mano partigiana, a causa di motivi personali mai chiariti. Il giovane Carlo, che si arrangiò come poteva, iniziò la carriera da camionista e poi da commerciante di residuati bellici e rottami ferrosi. Dai proventi di questa prima attività, il self made man (laureatosi nel frattempo in ingegneria) fondò un impero della siderurgia e delle lavorazioni metalliche che lo porterà ad essere a capo di 16 aziende e a occupare il posto di presidente Iritecna, oltre che di senatore della Dc con un rapporto privilegiato con Giulio Andreotti. L’avventura nel mondo delle mini vetture fu quasi un omaggio ai luoghi delle sue origini. Dove sorgeva il fiore all’occhiello delle industrie di Lavezzari, la Zincor, iniziò la produzione di una micro vettura disegnata dal carrozziere Scattolini, che ricordava, in soli 1,78 metri di lunghezza, una microscopica Jeep «Willys». Presentata nel 1966, la «Varzina» era inizialmente spinta dal motore due tempi da 125cc della Lambretta, rendendo la mini vettura più simile a un quadriciclo che a una vera automobile in miniatura. Dopo l’accordo con l’ingegnere francese Henri Willame (il Nome Lawil nasceva infatti dall’unione delle iniziali dei cognomi di Lavezzari e Willame) che decise di importarla oltralpe dove la piccola lombarda era guidabile senza patente, la produzione in serie della «Varzina» entrò a regime e sarebbe durata dal 1966 al 1982. Negli anni la microcar ebbe importanti evoluzioni tecniche. Il motore della Lambretta, insufficiente per considerare la «Varzina» una vera e propria auto, fu affiancato da un propulsore sempre a miscela di 250cc fornito dalla bolognese BCB. Più performante, il nuovo motore riusciva a spingere la mini fuoristrada a circa 80 km/h. La piccola di Varzi, che ebbe successo in particolar modo in Francia dove fu usata anche dai servizi postali nazionali, fu costruita anche in Indonesia come risciò motorizzato denominato «Super Helicak» prodotto dalla Italindo partecipata da Lavezzari. La Varzina è stata prodotta in circa 20mila esemplari nelle varie configurazioni, tra le quali anche una versione furgonata.
(Ansa)
La riforma consta di otto articoli, sull’ultimo dei quali - «Disposizioni transitorie» - tornerò alla fine. Gli altri sette modificano gli articoli 87, 102, 104-107 e 110 della Costituzione. Sembrerebbe la modifica di sette articoli e infatti le lamentele del Comitato per il No esordiscono proprio così: «Questa legge modifica sette articoli della Costituzione». Il che, pur apparentemente vero, è sostanzialmente sonoramente falso e fuorviante. Il Comitato per il No esordisce manipolandovi col trasmettere il messaggio angoscioso che la riforma governativa stravolgerebbe la Costituzione. Una comunicazione levantina che da sola basterebbe a togliere ogni fiducia a chi invita a votare No.
La verità sostanziale è che si modificano solo due articoli, mentre gli altri sono solo adeguati per coerenza. Per esempio, visto che nei due veri articoli modificati si istituiscono due magistrature governate, ciascuna, dal proprio Consiglio superiore, l’articolo 87 - che attualmente recita: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm» - diventa: «Il presidente della Repubblica presiede il Csm giudicante e il Csm requirente». Simili considerazioni valgono per gli articoli 102, 105, 106 e 110. Gli articoli veramente modificati sono il 104 e il 105. La riforma disciplina tre cose.
L’esordio dell’articolo 104 - «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» - diventa: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». È finalmente introdotta la separazione delle carriere: così come l’avvocato che vi difende non è collega del giudice che deve emettere sentenza, anche la pubblica accusa non lo sarà più. Ove l’articolo vecchio continua assegnando la presidenza dell’unico Csm al capo dello Stato, quello nuovo si adegua, istituisce due Csm e mantiene il capo dello Stato a presiederli entrambi. Ecco attuato il principio del giusto processo, in ottemperanza all’articolo 111 della Costituzione.
Secondo il vecchio articolo, gli altri componenti (attualmente 24) sono «eletti» per 2/3 dai magistrati e per 1/3 da una lista che il Parlamento compone tra professionisti di lungo corso del diritto. Nell’articolo modificato dalla riforma, la parola «eletti» è sostituita con le parole «estratti a sorte».
L’articolo 105 attuale recita: «Spettano al Csm le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati». Il nuovo articolo 105 è molto più lungo, col primo comma quasi coincidente con l’intero articolo vecchio: «Spettano a ciascuno dei due Csm le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati». Come si nota, le parole «le promozioni» sono sostituite con le parole «le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni»; e sono state soppresse le parole «provvedimenti disciplinari» del vecchio articolo. Cosa significa? Significa, intanto, che ove la vecchia legge parla solo di «promozioni», la nuova parla di «valutazioni di professionalità». Ora, non voglio qui rivangare la brillante carriera dei giudici che hanno distrutto la vita di Enzo Tortora, solo perché non voglio dare l’impressione che quella del caso Tortora sia l’eccezione che conferma una regola: temo che sia invece la regola. Ancora: a leggere l’attuale articolo 105, suona quanto mai bizzarro che eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di un magistrato siano affidati a coloro che quel medesimo magistrato ha eletto. E, infatti, come osservavo a mo’ di esempio, quelli coinvolti nel caso Tortora, lungi dal subire provvedimenti disciplinari, fecero invece brillante carriera. Nel resto del nuovo art. 105, la riforma istituisce allora un’Alta Corte disciplinare, composta da 15 giudici professionalmente qualificati: «Tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica» e gli altri 12 sono, di nuovo, tutti estratti a sorte: sei sono della magistratura giudicante, tre della magistratura inquirente e tre da un elenco di professionisti di lungo corso del diritto nominati dal Parlamento. I membri dell’Alta Corte non possono essere membri di nessun Parlamento (regionale, nazionale o europeo) né possono esercitare professione di avvocato. Infine, chi è soggetto a provvedimenti dell’Alta Corte può impugnarli solo dinanzi alla medesima Corte e, in questo caso, essa giudica in assenza dei componenti che hanno concorso alla decisione impugnata.
La prima lamentela del Comitato per il No è che la riforma assoggetterebbe il Csm al governo e/o al Parlamento. Ora, ditemi voi, come possa mai accadere che, passando da un meccanismo elettivo a una estrazione a sorte, chicchessia possa meglio influenzare sull’esito finale. Anzi, l’estrazione a sorte tra i titolati a far parte dei due Csm o dell’Alta Corte è l’unica cosa che garantisce che la scelta dei componenti sia avvenuta senza alcuna influenza esterna. Allora, chi vi dice che la riforma introduce, rispetto alla vecchia legge, maggiore controllo del potere politico, vi sta manipolando, vi sta mentendo, e vi sta togliendo il potere di scegliere. Né è vero che gli scelti per votazione sono i più «bravi»: sono solo quelli che hanno avuto più voti.
Le «Disposizioni transitorie», poi, prevedono che le leggi sul Csm, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate entro un anno alla nuova norma costituzionale. Allora, non solo con la nuova legge l’ingerenza della politica sulla magistratura è ridotta, ma codesta presunta ingerenza non è di alcun beneficio all’attuale esecutivo, che sarà a scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della riforma.
Continua a leggereRiduci
Una seduta del Csm (Imagoeconomica)
Battute a parte, resta la notizia e cioè che ieri il Tar del Lazio ha dato torto ai criticoni: il referendum si terrà nella data fissata dal governo, quindi domenica 22 e lunedì 23 marzo. Per i giudici amministrativi le preoccupazioni del No non avevano senso, non c’era alcuna prevaricazione e soprattutto il tempo per informare i cittadini è assolutamente congruo. Del resto, lo stesso capo dello Stato Sergio Mattarella non aveva avuto problemi a firmare la delibera che fissava la data, alla quale si era giunti dopo una mediazione di equilibrio.
Pertanto non ci saranno sorprese: si va dritti sul 22 e il 23 marzo, nel senso che la decisione del governo, secondo il Tar, non è un atto «lesivo e illegittimo» e non «rappresenta di fatto l’espropriazione del diritto dei cittadini di raccogliere le firme». La decisione dei giudici amministrativi è tanto più importante se si pensa che è avvenuta con sentenza e non con ordinanza, il che - per dirla in soldoni - rafforza la stessa, poiché non si ferma al solo congelamento del ricorso (cioè la richiesta di sospensione cautelare) ma entra anche nel merito delle questioni sollevate dai 15 giuristi che avevano promosso l’iniziativa. Insomma il governo e il fronte del Sì vincono abbondantemente su tutta la linea.
Questo ci permette allora di riprendere quanto nei giorni scorsi Alessandro Sallusti aveva già scritto, illuminando un aspetto fondamentale. Perché - si domandava - così tanto affanno da parte dei promotori nel chiedere la sospensione cautelare rispetto alla data fissata dal governo? Perché chiedere il posticipo, denunciando lesioni di diritti a danno dei cittadini? Ecco, Sallusti ci indicava una ragione che alla luce della sentenza del Tar del Lazio si fa ancor più condivisibile. Al fronte del No, quello che sta raccontando di pm che verrebbero assoggettati al potere politico (da qui la campagna pubblicitaria nelle stazioni e non solo…), interesserebbe arrivare al rinnovo del Csm con le vecchie regole; perciò spingeva a posticipare il referendum: buttare la palla in tribuna e guadagnare tempo.
In effetti, quand’anche il referendum convalidasse la riforma del governo - come sembra dai recenti sondaggi - poi ci sarà bisogno dei decreti attuativi, cioè di quelle leggi che «fanno camminare» le buone intenzioni legislative. Una vittoria del Sì il 22 e il 23 marzo velocizzerebbe tali norme blindandole in un calendario favorevole al rinnovo del Csm secondo le nuove regole. Un posticipo del referendum avrebbe invece ritardato tali tabella di marcia. Ci sono dieci mesi circa per impostare il rinnovo del Csm che va a scadenza tra un anno: se tutto filerà liscio a quel punto avremo un Csm per i giudici e uno per i pm, con l’azzeramento dei giochi tra le correnti perché gli organi di autogoverno sarebbero compilati secondo il sorteggio.
Ritardare il referendum avrebbe vanificato questa operazione anche in caso di vittoria dei Sì perché le procedure di rinnovo sarebbero state fatte con le vecchie regole e quindi… Buonanotte ai suonatori. La decisone del Tar del Lazio - che ripeto è entrato nel merito delle questioni sollevate dai 15 giuristi promotori spazzandole via - dà indirettamente ulteriore smalto ai promotori del Sì e ci consentirà di entrare nel vivo della campagna al netto degli allarmismi creati ad arte. Questa riforma è un passo avanti in una ridefinizione della giustizia rimettendola su binari più consoni, facendo invece deragliare (con la procedura del sorteggio) il treno del correntismo togato. La riforma del Csm è il cuore della legge costituzionale su cui ci esprimeremo e - ora più che mai - siamo convinti che proprio per questo le anime più politicizzate stanno dicendo e facendo cose bizzarre, dai post del segretario alla richiesta di rinvio del referendum.
Continua a leggereRiduci
Ecco #DimmiLaVerità del 29 gennaio 2026. Il grande esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela un dettaglio inedito della escalation Usa-Iran.
Danni causati dal ciclone Harry sul lungomare di Catania (Ansa)
Può sembrare strano, considerata l’estensione delle nostre coste e che fenomeni del genere, quindi, andrebbero annoverati tra le calamità. Eppure, nella normativa c’è questo vuoto che espone le aziende al rischio di non aver nessun rimborso dalle assicurazioni, anche dopo essersi impegnate economicamente per tutelarsi da possibili disastri. È prevista la copertura contro le inondazioni ma non contro le mareggiate», spiega il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
Una dimenticanza nella preparazione della norma prevista dalla legge di Bilancio 2024? Eppure, il governo ha puntato sul meccanismo delle polizze catastrofali come strumento per evitare che il costo dei danni ricada prevalentemente sul bilancio pubblico, considerata la frequenza dei fenomeni naturali estremi nel nostro Paese. La norma, lo ricordiamo, prevede l’obbligo, per le imprese, di stipulare una polizza per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Le aziende che non si assicurano contro eventi catastrofali perdono l’accesso a contributi pubblici, agevolazioni e incentivi fiscali. Quindi è una misura strategica che, però, «arrivata al primo banco di prova, rischia di fallire», afferma Gronchi.
Le scadenze per dotarsi di una polizza sono state scaglionate: 31 marzo 2025 per le imprese grandi con oltre 250 dipendenti, 30 settembre 2025 per le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti), mentre per tutte le micro e piccole imprese l’obbligo era stato posticipato al 31 dicembre 2025. Il Milleproroghe ha poi spostato l’obbligo a fine marzo prossimo per alcune categorie come la ricezione e il turismo, cioè alberghi, bar e ristoranti. «Si può quindi creare la situazione paradossale che in un immobile danneggiato ci siano differenti trattamenti; magari c’è un negozio che è stato obbligato a sottoscrivere una polizza mentre un bar aveva il tempo per farlo fino a fine marzo. È una norma che ha svariate incertezze», afferma Gronchi, sottolineando che «molte imprese hanno difficoltà ad avere i preventivi dalle assicurazioni. Abbiamo un pezzo di imprese senza copertura assicurativa perché la scadenza della sottoscrizione è stata spostata in avanti, mentre altre che non riescono a capire se, pur avendo una polizza, saranno o meno coperte, dal momento che i danni sono da mareggiate e non da inondazioni».
Le problematiche non finiscono qui. Il presidente di Confesercenti evidenzia il rischio che «chi non ha polizza non possa avere accesso a eventuali aiuti pubblici. La normativa dice che, in caso di catastrofe ambientale, l’impresa non assicurata non potrà richiedere ristori o contributi per la ricostruzione. In pratica l’imprenditore dovrà ripagare i danni mettendo mano al proprio portafoglio. Non solo. Senza polizza, l’azienda è considerata fragile e questo può portare al rifiuto di prestiti da parte delle banche o a tassi d’interesse più alti».
Confesercenti si è mossa per dare un aiuto alle aziende in difficoltà. «Abbiamo attivato un plafond complessivo di 2,5 milioni per prestiti agevolati destinati alle imprese siciliane, calabresi e sarde per gestire l’emergenza». L’intervento più strategico è nella lettera che Gronchi ha inviato al premier Giorgia Meloni, nella quale chiede di spostare al 30 giugno la scadenza dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza. «Servirebbe a superare le incertezze. Abbiamo bisogno di tempo per far in modo che il meccanismo funzioni. L’Italia è territorio fragile e senza lo strumento delle polizze catastrofali, che affianchino l’intervento dello Stato, non si va da nessuna parte. In Sicilia ci sono oltre 1.000 imprese concentrate tra Messina e Catania colpite dal ciclone Harry, con danni per 750-800 milioni. Senza contare i danni al patrimonio pubblico».
Poi c’è il capitolo delicato degli stabilimenti balneari, le strutture più danneggiate. «Avendo le concessioni scadute e con l’incertezza dell’esito della direttiva Ue Bolkestein, sono penalizzate dalle banche perché il loro futuro è incerto e potrebbero avere difficoltà nell’accesso al credito».
In questo caos c’è anche il fronte delle assicurazioni. Al pressing del governo per spingerle a rimborsare le imprese danneggiate, l’Ania, richiamando la legge, sottolinea proprio quanto evidenziato dalla Confesercenti, ovvero che le mareggiate e i danni provocati dal vento restano fuori dalla lista degli eventi coperti dalle polizze. A meno che le imprese non abbiano sottoscritto polizze più ampie di quelle obbligatorie, includendo anche le mareggiate, non c’è possibilità di ricevere i rimborsi.
Continua a leggereRiduci