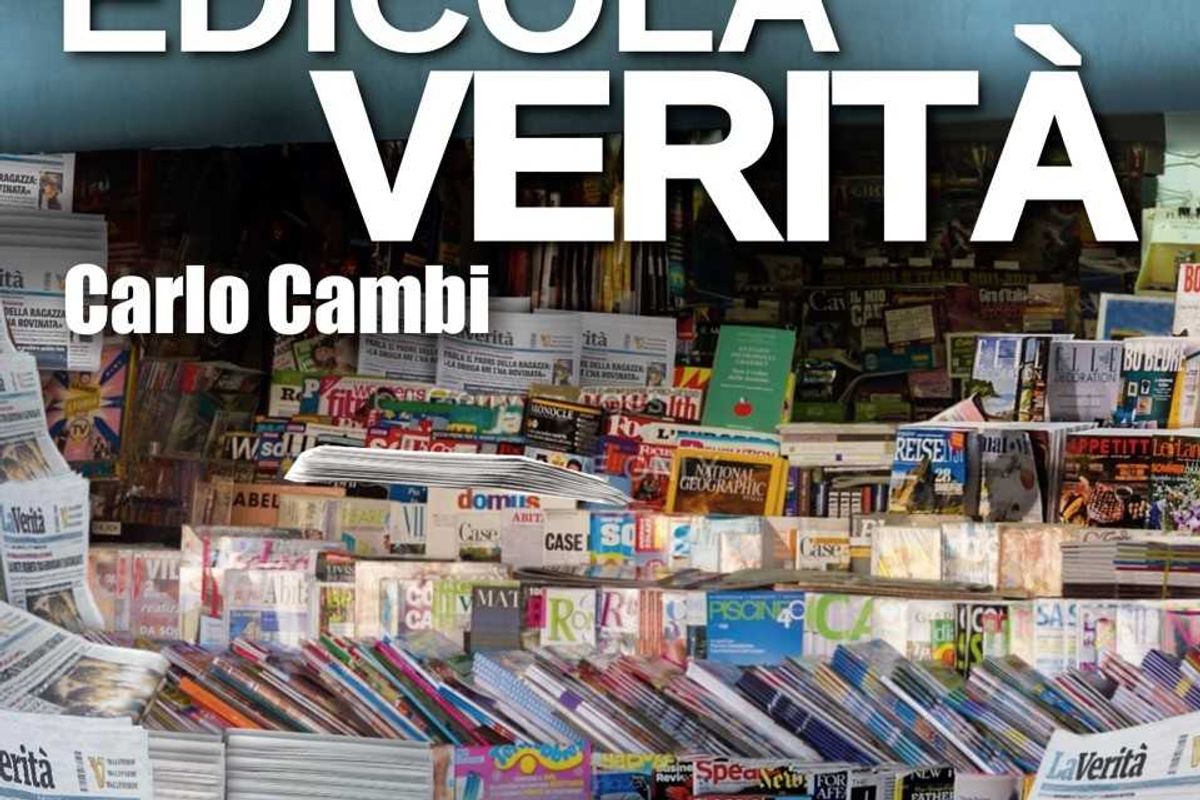I cinguettii, le strane veline, la conferenza stampa: l’era di Giuliano Amato presidente della Corte costituzionale si è aperta con una sequenza di circostanze anomale. Gli ultimi eventi avrebbero disorientato persino il collegio dei giudici. Colti alla sprovvista già quando il Dottor Sottile, a dispetto dello storico soprannome, aveva lasciato che partisse un primo tweet, in cui si riportava l’indicazione da lui trasmessa agli assistenti dei colleghi in toga: l’ordine di «non cercare il pelo nell’uovo», pur di bocciare i referendum.
Atteso che il compito della Consulta dovrebbe essere proprio quello - se non servissero pignolerie tecniche, potremmo fare a meno di tale organo - restano agli atti le interpretazioni oblique che, della mossa del presidente, avevano dato gli osservatori: Amato diffonde il «trailer» della sentenza? Oppure rabbonisce in via preventiva, prevedendo respingimenti scomodi? Ad avvalorare questa seconda ipotesi, c’è l’indiscrezione circolata dopo la bocciatura del referendum sull’omicidio del consenziente: il presidente ha votato per ammetterlo, si era letto su Dagospia, però l’ha spuntata la maggioranza cattolica.
Inaudita, in particolare, la scelta del giurista di presentarsi davanti ai giornalisti, prendendo di petto le critiche dei promotori radicali e gettandosi in una querelle a tutti gli effetti politica. Fa tenerezza, comunque, constatare che solo adesso gli editorialisti progressisti, nel deplorare l’«Amato show» (Il Fatto), la «Corte interventista» (Repubblica), lo scippo della democrazia diretta (Piergiorgio Odifreddi), scoprono quel che era palese da anni: alla Consulta, prima che le preoccupazioni per l’integrità della Carta fondamentale, contano le prese di posizione ideologiche.
Cosa c’era di più politico della saga Cappato? Cosa c’era di più politico di un ultimatum al Parlamento, invitato quasi esplicitamente a stilare una norma favorevole al suicidio assistito? E cosa c’è stato di più politico di una legge scritta dalla Corte? La decisione arrivò nell’autunno 2019, allorché, sul suo scranno più alto, sedeva Giorgio Lattanzi. Costui, sotto la guisa della «leale collaborazione» tra istituzioni, già propugnava la deriva verso il giudice legislatore. Un processo culminato con Marta Cartabia, perennemente in bilico tra la schiatta dei «competenti» puri e la cerchia delle «riserve della Repubblica». La sua elezione, anticipata dalla sapiente costruzione di un personaggio, il volto umano della tecnocrazia, una toga per amica, fu trasformata in una specie di festival femminista: il discorso sul «soffitto di cristallo», il brodo di giuggiole in cui affogarono i giornali trombettieri... Entro breve, sarebbe stata completata la popolarizzazione - e, di conseguenza, la politicizzazione - della Consulta. Memorabili le tappe involutive: a gennaio 2020, lo sbarco su Twitter e l’introduzione degli amici curiae (i portatori d’interessi, autorizzati a spedire pareri scritti); pochi mesi dopo, la «libreria dei podcast», i giudici divulgatori della «cultura costituzionale».
È parecchio tempo, insomma, che alla Corte hanno smesso di parlare per sentenze e si sono abbandonati a una verbosità agonistica: le interviste dei Lattanzi e delle Cartabia non erano che il prodromo della conferenza stampa post sentenza di Amato. Con l’aggravante che certe sortite pubbliche, a volte, non costituivano nemmeno il passaggio illustrativo di un orientamento giuridico concordato: la mente corre alla tirata d’orecchi che, nella primavera del 2020, l’allora presidente della Corte riservò ai dpcm di Giuseppe Conte. Pareva l’annuncio di una dottrina in via di consolidamento; invece, nell’unica occasione in cui i decreti giallorossi sono arrivati alla Consulta, lo scorso ottobre, sono stati promossi.
Colpì, all’epoca della dichiarazione della Cartabia sui dpcm, la velata minaccia che, stando ai retroscena, le avrebbero indirizzato i grillini stizziti: «Si scordi il Quirinale». Un segno tangibile della permeabilità tra i vertici un’istituzione di garanzia e, addirittura, le alchimie di Palazzo. Va a finire così, quando ti metti a teorizzare che l’obiettivo delle corti costituzionali non è di preservare le costituzioni, bensì di «dinamizzare l’ordinamento». Ed è qui che affiora il principale vulnus dei rapporti tra giustizia e politica in Italia.
La riforma Cartabia, licenziata una settimana fa dal Cdm, intende sopprimere le cosiddette porte girevoli: magistrati che si candidano con un partito, ricoprono incarichi e dopo, magari, pretendono di tornare a giudicare i loro concittadini. Ma siamo sicuri che l’insidia peggiore, per la democrazia e lo Stato di diritto, siano i Catello Maresca? E che la priorità fosse immunizzarsi da certi discutibili transiti? Attenzione: nessuno nega che essi siano sgradevoli, inopportuni. Le leve del potere, tuttavia, vengono manovrate altrove: la toga capace di dettar legge, per colpa di una metamorfosi forse connaturata al Dna di quell’organismo, poi accelerata a ritmi esponenziali negli ultimi tempi, è la toga che dirige i giochi alla Consulta. E di porte girevoli, in questo caso, abbiamo recenti esempi preclari: l’attuale Guardasigilli, che nasconde la sua politicizzazione dietro il velo del ruolo tecnico; per non parlare di Amato, ex presidente del Consiglio, ex ministro dell’Interno, ex ministro del Tesoro, ex ministro per le Riforme, ex deputato, ex senatore, trasmigrato dal Psi, ai Ds, al Pd.
Sì: poiché un terzo dei membri della Corte è di nomina parlamentare, è scontato che essa non sia avulsa dalla politica. Ormai, però, siamo ai giudici che diventano parti in causa. Dovrebbero essere i guardiani della Costituzione, si comportano come se ne fossero i padroni. Un vizio di forma, al di là delle ragioni di sostanza, addotte dal Dottor Sottile per liquidare referendum pasticciati. In fin dei conti, il problema di ogni sistema politico resta quello inquadrato da Giovenale duemila anni fa: chi sorveglia i sorveglianti?