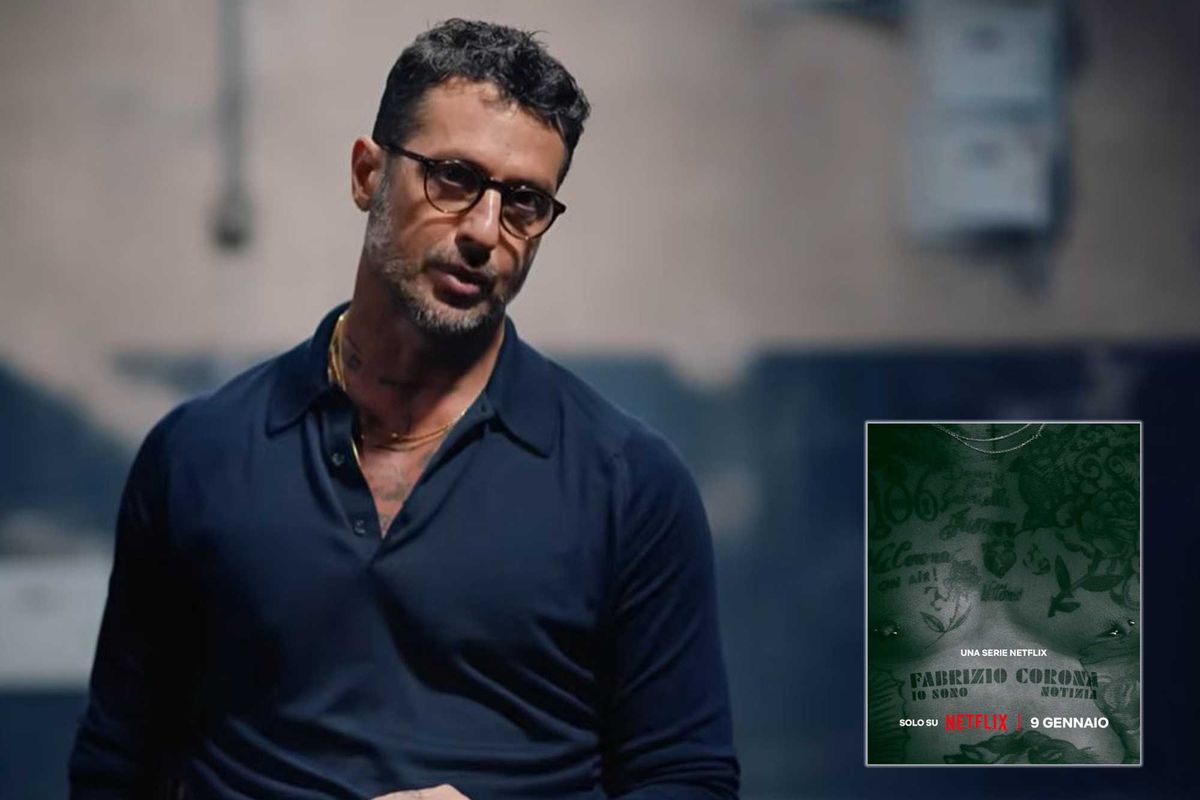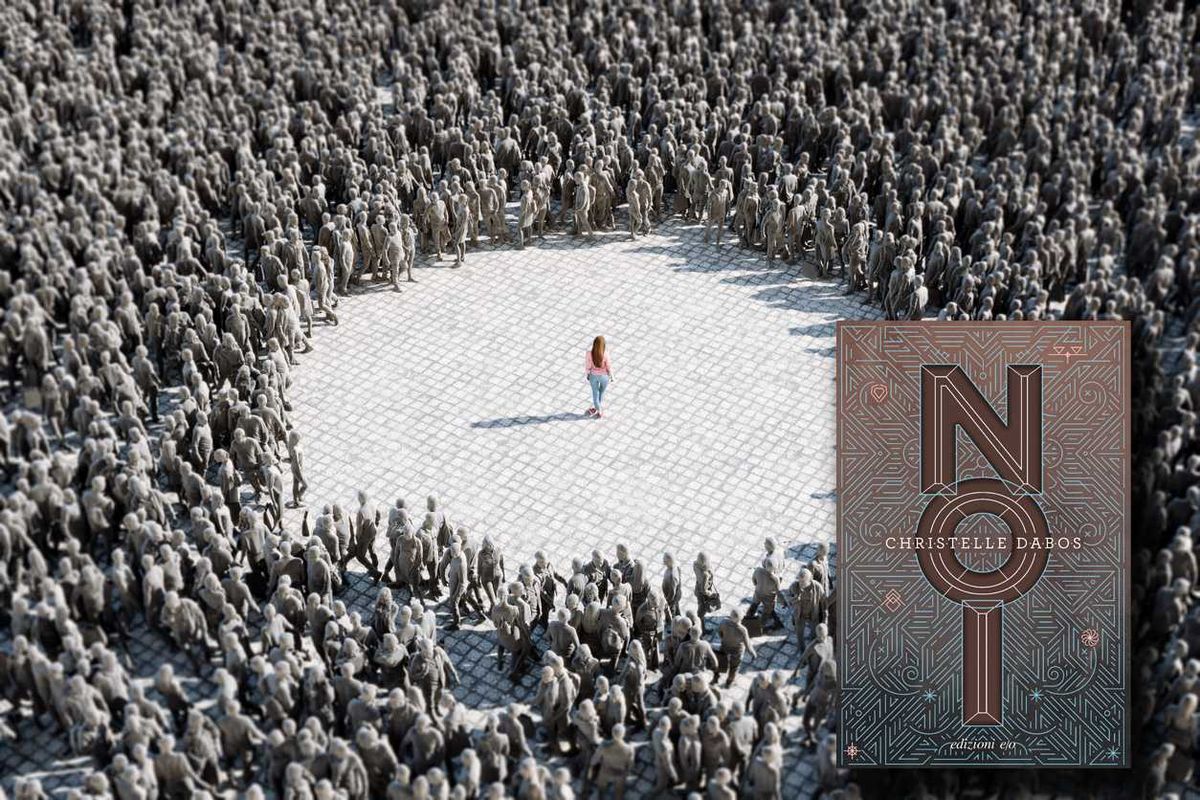L’intelligenza sarà anche artificiale ma consuma troppa energia naturale
- L’Irlanda vieta la costruzione di un data center a Google perché sarebbe mancata l’elettricità per famiglie e imprese.
- Il ministero dell’Ambiente vara le linee guida in un settore che vale da noi 15 miliardi.
Lo speciale contiene due articoli.
La transizione energetica si scontra con quella digitale, evidenziando, ancora una volta, le contraddizioni insite nel modello di sviluppo che le élite contemporanee stanno portando avanti.
Le notizie di questi giorni sottolineano come le due «rivoluzioni» tecnologiche non solo non vanno a braccetto, ma ora entrano in chiaro conflitto.
Qualcuno ha fatto i conti e, come riporta Il Sole24ore di ieri, risulta che i big della Silicon Valley hanno molta fame di energia, e non certo per l’aria condizionata degli uffici. Sono i data center, gli enormi contenitori di potenti server, a richiedere quantità massicce di energia, per il funzionamento e il raffrescamento. Ciascuna delle due maggiori società americane del settore, Microsoft e Google, ha consumato nel 2023 circa 24 miliardi di kilowattora di energia elettrica per le proprie attività di cloud computing, compresa l’Intelligenza Artificiale (AI). Il che significa che, insieme, le due compagnie hanno consumato il 50% in più di interi paesi come la Nigeria (che ha 230 milioni di abitanti) o la Serbia.
Qualche giorno fa, poi, è emerso che il South Dublin County Council, in Irlanda, ha negato il permesso a Google di espandersi per costruire un nuovo datacenter nell’area metropolitana di Dublino. Ci sono valide ragioni, per questo diniego.
Nell’isola britannica vi sono già 82 data center, la maggior parte nell’area sud di Dublino, con un impegno di potenza di oltre 1.200 megawatt in tutte le ore del giorno. Nel 2023, il 21% dei consumi elettrici in Irlanda era dovuto ai datacenter, contro il 18% dei consumi delle famiglie. Secondo le stime di EirGrid, il gestore della rete elettrica, nel 2030 oltre un terzo dei consumi elettrici irlandesi sarà dovuto ai datacenter.
Il regolatore irlandese, Commission for the Regulation of Utilities, nel 2021 ha innalzato i requisiti per le connessioni alla rete elettrica dei datacenter. Dal gennaio 2022 le domande per costruire le strutture nell’area di Dublino sono sottoposte ad una moratoria di fatto sino al 2028. È in questo stop è incappata Google: il punto è che le reti non sono adeguate e non c’è abbastanza energia green
Tra le motivazioni che spingono le compagnie tecnologiche di tutto il mondo a stabilire in Irlanda le proprie infrastrutture, secondo molti, vi sarebbero il clima, la lingua e la poca burocrazia. Ma un fattore ben più rilevante è che l’Irlanda è un paradiso fiscale all’interno della zona euro (aliquota combinata pari all’11%), da cui è assai conveniente esportare ricchi servizi informatici. Nel 2023 l’export di servizi dall’isola è stato pari a 340 miliardi di euro, di cui il 60% circa di servizi in Information e Communication Technology, per un controvalore di 196 miliardi di euro. Davvero buono, il clima, in Irlanda.
Irlanda a parte, se ai consumi mostruosi del digitale mondiale si aggiunge la spinta all’elettrificazione dei consumi energetici imposta dal green deal, è chiaro che tra pochi anni i sistemi elettrici rischiano di saltare. Il problema è produrre energia in abbondanza, a basso costo, in sistemi elettrici affidabili e sicuri. Ma il green deal sta portando il mondo esattamente sulla strada opposta.
La crescita vertiginosa delle attività digitali richiede robusti interventi nel mondo fisico. I data center consumano una quantità spropositata di risorse fisiche, e siamo solo all’inizio di una crescita che durerà per molto tempo ancora, a meno di buttare via i miliardi di investimenti sostenuti sin qui nel digitale. Ciò che è appare sempre più irrealistica è la transizione energetica a base di rinnovabili e buone intenzioni.
I sistemi elettrici non sono pronti a reggere una tale quantità di domanda elettrica, per diversi motivi. Intanto la rete: questa non è adeguata e servono investimenti miliardari, ma chi paga? Se si fa come si è sempre fatto (cioè attraverso le tariffe che tutti pagano al distributore) succede che sono i cittadini a pagare per una rete che senza data center, in precedenza, era adeguata ai fabbisogni di un consumo normale. Ne consegue che far pagare ai cittadini il rifacimento delle reti elettriche è un regalo all’high tech, che non sembra ne abbia particolare bisogno. Dovrebbero essere le stesse compagnie high tech a sostenere i costi dell’ampliamento delle reti?
Dall’altra parte, il consumo elettrico tipico dei datacenter è un carico di base senza alcuna flessibilità, cioè un profilo identico in tutte le ore del giorno e della notte. Un sistema elettrico alimentato da fonte solare ed eolica, per natura discontinue, non può garantire questo tipo di fornitura, a meno di ricorrere ad accumuli il cui costo e la cui affidabilità nel lungo termine sono ancora un grande interrogativo. In sintesi, la concorrenza fiscale tra stati e la transizione digitale stanno provocando squilibri nei sistemi energetici, già sotto grave stress per il green deal. Una strategia che sta mostrando tutti i suoi limiti di praticabilità e di costi ma che, a quanto pare, la nuova Commissione europea continuerà indefessa a perseguire.
L’Italia mette un freno al far west dei cervelloni digitali energivori
Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha diffuso le linee guida per la valutazione ambientale dei Data Center. In particolare, la direzione generale valutazioni ambientali ha adottato le direttive redatte dalla commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale e di quella di valutazione ambientale strategica tenendole come riferimento per le procedure di valutazione di progetti di Data Center assistiti da gruppi elettrogeni di emergenza con potenza superiore a 50 megawatt. Si tratta di un passo importante perché, secondo le stime dell’Ue, i Data Center rappresentano quasi il 3 % della domanda di elettricità dell’Unione Europea, percentuale che crescerà nei prossimi anni, con l’obbligo di indirizzare gli operatori verso nuovi progetti di efficienza. In particolare, lo scopo di queste direttive è ridurre e gestire l’utilizzo di acqua e di ricorrere il più possibile a energie rinnovabili, tentando anche di riutilizzare il calore di scarto generato. Lo scopo di queste linee guida è definire i principali fattori che concorrono a una valutazione ambientale, mostrando e descrivendo le metodologie da applicare oltre che le modalità di adempimento degli obblighi previsti dalle normative di settore. Va, inoltre, ricordato, che all’interno del Pnrr sono previsti progetti riguardanti i Data Center come inizio del nuovo percorso di crescita economica.Il mercato dei Data Center in Italia vale circa 15 miliardi di euro e a contendersi la torta ci sono colossi come Google, Amazon e Microsoft o anche il gruppo Aruba che lanciato una nuova area per i dati a Roma. L’Italia, tra l’altro, si sta posizionando come importante punto di snodo per i Data Center dopo che altre aree europee come Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi sono ormai vicine alla saturazione. In particolare, la città di Milano sta diventando sempre più importante per via della posizione geografica favorevole e della presenza di infrastrutture avanzate come il cavo Sparkle che va da Genova a Mumbai e che si aggiunge al progetto Medusa per collegare il continente africano.Secondo uno studio dell’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, il mercato delle strutture per l’immagazzinamento dei dati sta godendo di una importante crescita. Tra il 2023 e il 2025, 23 istituzioni, incluse otto nuove aziende, hanno prospettato la costruzione di 83 nuove strutture, con investimenti che potrebbero sfiorare i 5 miliardi di euro. Milano e la Lombardia, con il ruolo centri finanziari del Paese, sono al centro di questo mercato, con l’Italia che potrebbe essere un punto nevralgico tra Europa centrale e Mediterraneo, attirando l’interesse di investitori internazionali.Ora, insomma, l’obiettivo è quello di mettere ordine nel settore a livello di efficienza energetica. Anche perché, ad oggi i data center sono classificati come edifici industriali generici, causando incertezze e disomogeneità nelle procedure di costruzione a livello locale. Certo, la tecnologia sta facendo passi da gigante e i nuovi Data Center oggi sono in grado di ridurre il consumo di energia elettrica fino al 70% rispetto alle vecchie infrastrutture. L’obiettivo è quello di portare in Italia investitori internazionali con capitali freschi da investire nel settore. Il progetto del governo «Invest in Italy» voluto da Mimit, pensato per supportare gli imprenditori stranieri che vogliono investire in Italia potrebbe essere di grande utilità per il settore dei Data Center e per il suo efficientamento energetico.