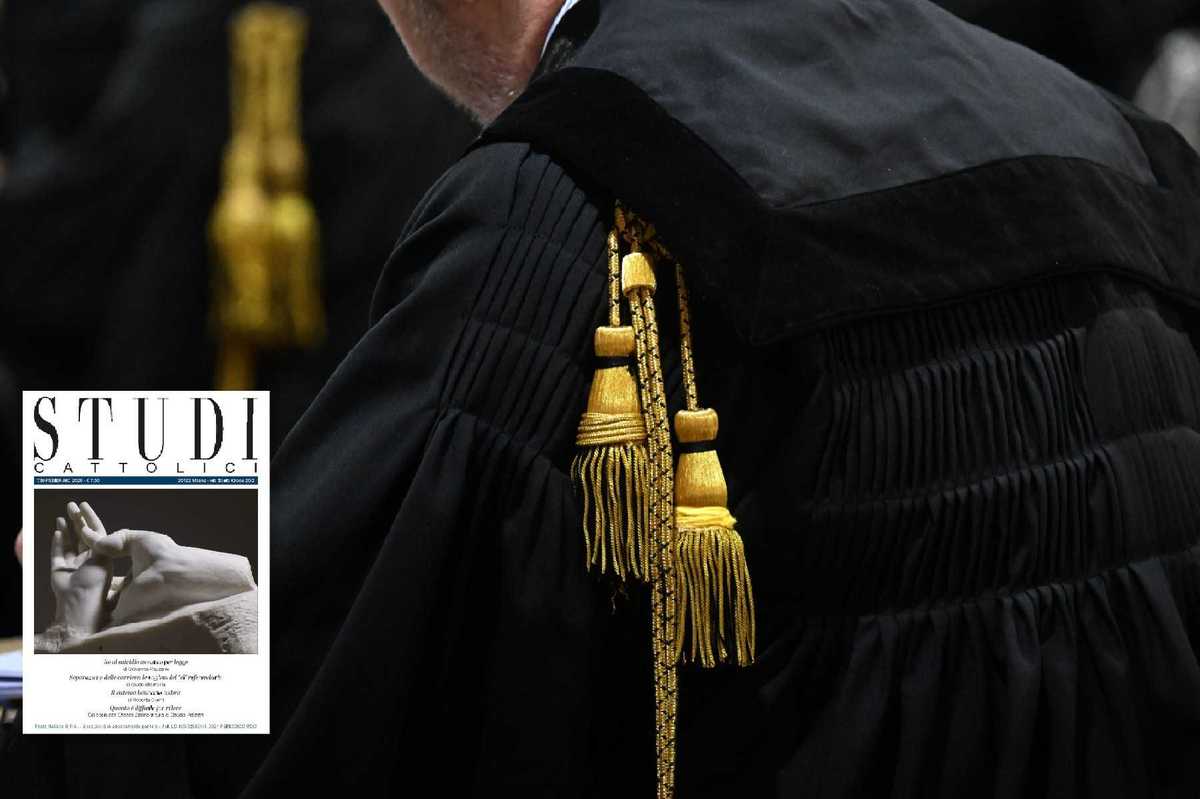L’import di elettricità dalla Francia a +121%. Il nucleare d’Oltralpe fa la parte del leone

Il 21 ottobre si terrà una riunione del Consiglio europeo che si occuperà tra l'altro dell'aumento dei prezzi dell'energia. Sì cercherà di trovare un rimedio ai danni che le quotazioni di gas ed elettricità stanno portando alla ripresa economica. Non sembra però che dal consesso possano uscire decisioni incisive. Le soluzioni di cui si discuterà non affrontano i nodi strutturali del mercato energetico europeo e si limitano ad arginare una situazione ritenuta transitoria. Il Commissario all'energia, la estone Kadri Simson, ha affermato che si consentirà agli Stati membri di applicare sconti fiscali, di incentivare l'uso dei bonus sociali per le famiglie in difficoltà e di agevolare pagamenti dilazionati. Strumenti di corto respiro, il cui insieme viene ribattezzato dal gergo burocratico di Bruxelles, con eufemismo idraulico, tool box.
Si esaminerà anche l'ipotesi di stoccaggi di gas comuni tra Paesi europei. Lanciata da Francia e Spagna, questa soluzione è complicata e in ogni caso inciderebbe sulla prossima stagione invernale. La Simson ha aggiunto che l'unico modo per evitare nuove crisi è accelerare la transizione all'energia verde.
Intanto in Italia a settembre 2021 la produzione da fonte rinnovabile è diminuita rispetto a quella del settembre 2020 di 1,2 Twh (quasi tutta mancata produzione idroelettrica), più che compensata da maggiori importazioni di energia, per la quasi totalità nucleare, dalla Francia (1,46 Twh, +121%).
L'Unione persevera nel Green deal, senza variazioni. La scelta politica di essere la prima a muoversi sul terreno climatico è molto chiara. Una decisione che porta con sé conseguenze nel medio termine di difficile gestione, tra cui costi più alti per imprese e famiglie e svantaggi competitivi. Nell'ottica dell'Unione e del blocco industriale finanziario tedesco che ne è il principale ispiratore sì tratta di una scelta obbligata. Indietro rispetto agli Usa su Web e digitale, appaltata l'industria di base in Asia, fuori gioco sull'elettronica e sull'intelligenza artificiale, nella partita economica mondiale l'Europa non può restare schiacciata tra i giganti Usa e Cina. Il modello di sviluppo europeo del secondo dopoguerra (infrastrutture, edilizia e automobile) è tramontato da 30 anni. È vitale dunque creare un nuovo terreno di competizione in cui l'Europa a trazione tedesca, deflazionista e mercantilista, possa primeggiare. La creazione di un salto tecnologico quale è il Green deal (auto elettrica in primis) impone una selezione all'interno dell'industria, una distruzione dell'esistente in favore di un nuovo paradigma. Proprio questo è l'intento che l'Europa pone alla base del Green deal: da first mover, dettare lo standard a cui gli altri dovranno adattarsi. Per usare le parole di Frans Timmermans, commissario per il Clima, si tratta di una vera e propria rivoluzione industriale. Un esempio evidente di burrasca di Schumpeter, per quanto politicamente indotta.
A favore di ciò gioca la crescente attenzione dell'opinione pubblica al tema ambientale. L'allarme climatico costituisce un decisivo supporto a una politica industriale che, pur se liberale, nei fatti necessita di una dose massiccia di dirigismo. Lo dimostra il numero e la complessità delle norme che fanno parte dei «pacchetti» della Commissione. Il processo di approvazione del Fit for 55 richiederà due anni, mentre la pretesa della regolazione europea è di pianificare nel dettaglio anche ciò che avverrà tra 30 anni.
Gli elementi contrari a un disegno di così ampio respiro sono però molti, a cominciare dalla posizione di svantaggio dell'Europa sulle materie prime. Per il successo del progetto sono infatti necessari acciaio, alluminio, rame, terre rare, tutti fattori produttivi di cui l'Europa non dispone. La Commissione intende affrontare questa debolezza attraverso accordi internazionali di lungo termine, ma la realtà rischia di essere assai diversa dal piano.
Inoltre, come stiamo sperimentando sui costi del gas naturale, i settori economici messi in secondo piano dal nuovo corso industriale non cederanno posizioni facilmente, cercando di massimizzare nel breve termine. Un capitolo a sé andrebbe aperto sugli impatti occupazionali del nuovo corso. Di certo esiste solo il Fondo sociale europeo per il clima da 72 miliardi, delineato nel pacchetto Fit for 55, che però non piace molto ai Paesi frugali. Nel frattempo si viene a sapere che Volkswagen pensa di licenziare oltre 30.000 lavoratori.
L'Unione europea, con un tempismo che farebbe invidia al ragionier Ugo Fantozzi, lancia la sua distruzione creativa nel mezzo di una crisi mondiale senza precedenti, che coinvolge a vario titolo la logistica, le materie prime, gli alimentari, il debito privato (l'esposizione finanziaria del settore immobiliare cinese ha le dimensioni del Pil di un Paese del G7) e i timori di inflazione. Le aspettative sul nuovo corso green europeo aggiungono volatilità a una situazione già complicata. Uno stormo di cigni neri volteggia sopra le teste degli europei e degli italiani, forse troppo impegnati a discutere di certificati vaccinali e polverose categorie storiche per accorgersene.