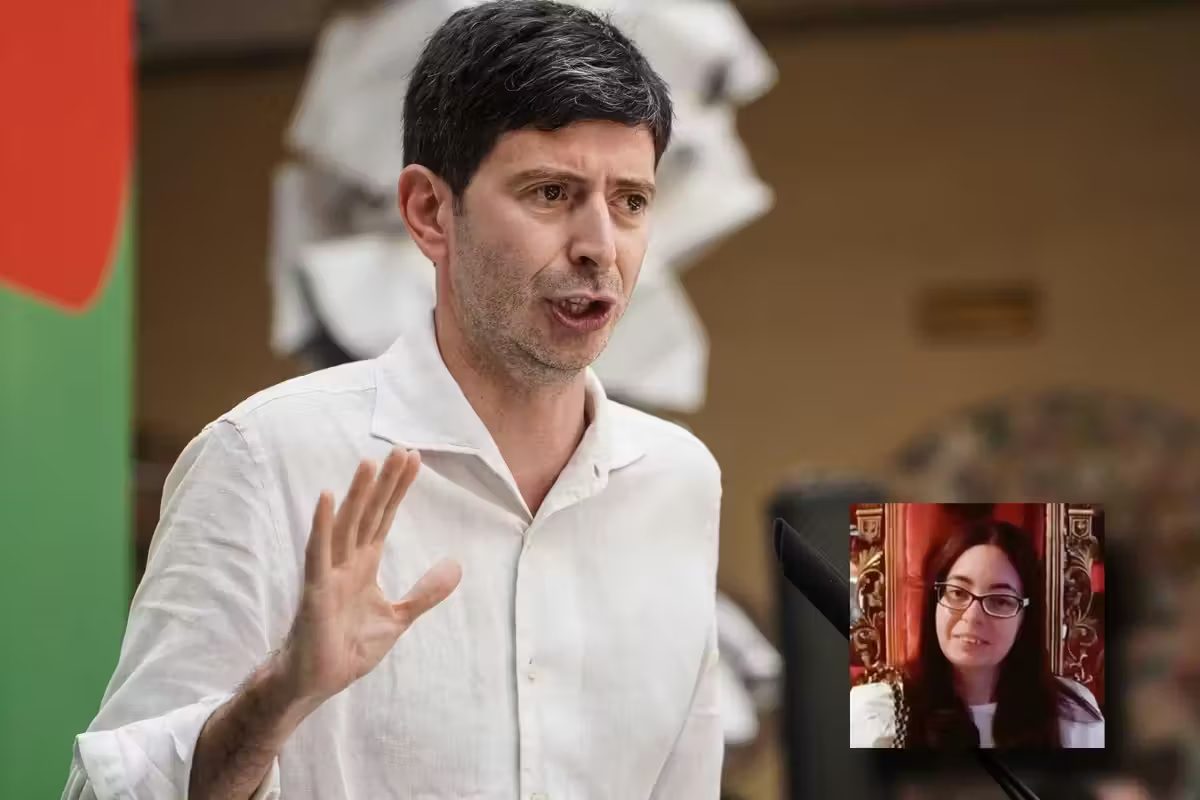Lievito quotidiano. In panetti o liquido, è l’elemento base per pane, dolci e salati

Il bellissimo verbo «lievitare» ha un significato principale intransitivo che è «aumentare di volume per l'effetto della fermentazione del lievito» (per esempio, il panettone sta lievitando). Ma presenta anche un significato figurato - ovvero «crescere di volume o di forza» - riferito a qualsiasi campo. Come verbo transitivo, poi, lievitare vuol dire «sottoporre a fermentazione con lievito». Il verbo nasce, infatti, dal sostantivo «lievito», che a sua volta deriva dal latino volgare levitum (per il latino classico levatum), participio passato di levare, cioè «alzare». Se guardiamo al verbo italiano «sollevare», notiamo che, pur con lo stesso significato di lievitare, ha mantenuto una somiglianza maggiore con l'originale latino. Siamo tutti abituati a pensare che il lievito per i panificati, soprattutto salati ma anche dolci come il panettone, il pandoro e la colomba, sia solo quello in cubetti, detto «di birra». Invece, negli ultimi anni sono tornati in voga agenti lievitanti che il lievito di birra aveva relegato in cantina e, al contempo, ne sono emersi altri. Il lievito di birra, anche detto «compresso», è elaborato dall'industria a partire da colture di Saccharomyces cerevisiae o di Candida utilis per lievitare i panificati, ma anche il vino e la birra. Da qui il nome che, per aumentare la già non indifferente complessità del discorso sul lievito, a volte viene indicato sul panetto come «lievito naturale».
Come nasce il lievito? «Hai fatto un impasto di acqua e farina, per preparare la solita focaccia secca e pesante. Lo hai messo in varie ciotole. Il giorno dopo scopri che una te la sei dimenticata. La guardi: l'impasto ha cambiato colore; puzza, anche. Che fai? Butti tutto? No: vivi in condizioni precarie e di sussistenza, in cui ogni cosa anche minimamente commestibile va mangiata, o in qualche modo riutilizzata. Allora ti arrangi: prendi l'impasto avanzato e lo mescoli con altra acqua e farina. Dopo qualche ora, miracolo, è aumentato di volume. E quando lo cuoci, perbacco, si gonfia e mentre lo mangi diventa molto più morbido, più leggero, più buono. Altro che focaccina: è nato il pane. Questo, si immagina, deve essere successo quattromila o seimila anni fa, in Egitto o in Mesopotamia. E come sempre l'uomo, con l'osservazione e i tentativi, ha saputo trasformare un evento casuale in una pratica quotidiana: la creazione della pasta madre - in realtà all'inizio è più probabile che si trattasse di pasta di riporto, cioè un pezzo dell'impasto finale che viene lasciato fermentare invece di cuocerlo ed è poi riportato nell'impasto successivo - e la lievitazione del pane». Così, spiega il libro Pane e dolci al naturale (Slow Food Editore) nel capitolo «La magia della lievitazione».
«Che poi gli antichi sapessero effettivamente quello che succedeva nell'impasto» prosegue ancora il libro, «questo è un altro discorso: ovviamente no, lo facevano e basta, pensate che anche in epoca moderna fino a pochi anni fa erano ignoti l'esistenza di certi microrganismi e il loro contributo alla lievitazione». I responsabili della lievitazione diversi dal lievito di birra sono, innanzitutto, la pasta madre e i suoi figli: licoli, biga, poolish, pasta di riporto. Ma anche, come ci spiegano Sara Papa e Antonio Polzella nel magnifico manuale di panificazione Di grano in grano. Dal campo, pane e pizza come natura comanda (appena pubblicato da Gribaudo editore), l'acqua fermentata e il kefir d'acqua, agenti fermentati - come la pasta madre - e perciò a loro volta fermentanti. Ma andiamo per ordine.
Che cosa succede quando impastiamo acqua e farina? Seguiamo ancora Pane e dolci al naturale: «Da un lato c'è la formazione del glutine, cioè l'unione e la trasformazione della parte proteica della farina, sotto l'effetto dell'acqua e dell'energia dell'agente impastatore (macchina o mano); diciamo che la maglia glutinica si forma, e per il momento se ne sta là. Dall'altro l'acqua bagna la parte amidacea della farina, soprattutto bagna gli enzimi».
Gli enzimi sono soprattutto alfa e beta amilasi che, da una situazione statica, grazie all'acqua e all'impasto, si risvegliano e attaccano le catene di zuccheri complessi, trasformandole prima in sequenze medie (destrine), poi in zuccheri semplici, disaccaridi come il maltosio, e poi monosaccaridi come il glucosio. Solitamente noi impastiamo acqua, farina e un agente lievitante, che può essere il lievito di birra o qualsiasi altro fra lievito madre e i suoi figli. Alcuni figli del lievito madre (lievito madre compreso) sono fatti di sola acqua e farina, talvolta ci si aggiunge un pizzico di zucchero per velocizzare la reazione di fermentazione. Altri sono fatti di acqua, farina e lievito di birra. Ma anche nel caso in cui noi utilizzassimo lievito di birra o kefir d'acqua come agenti lievitanti (e non quei lieviti di acqua e farina), potremmo avvantaggiarci del riposo di un impasto fatto solo di acqua e farina prima di aggiungere il lievito, qualunque esso sia. Questa tecnica si chiama impasto con autolisi. Vediamo di che cosa si tratta: «L'autolisi consiste nel fare un impasto iniziale esclusivamente di acqua e farina, e solo dopo un po' aggiungere i lieviti. In questo modo quando i lieviti entrano a contatto con la pasta è già in parte avvenuta quella operazione di scissione di amidi che si diceva, e loro trovano subito qualcosa da mangiare. Più o meno la stessa funzione ha l'inserimento nell'impasto di uno zucchero semplice - un cucchiaino di zucchero da cucina o, meglio ancora, di malto o di miele - così mentre gli enzimi provvedono a trasformare gli zuccheri complessi, i lieviti non se ne stanno senza fare niente, con il rischio che poi si annoino e muoiano, anzi iniziano a moltiplicarsi così da essere poi belli in forze per gettarsi sul pasto principale». Il principio dell'autolisi è, com'è facile notare, alla base della produzione del lievito madre, fatto solo con acqua e farina che poi si lasciano fermentare e si rinfrescano con altra acqua e farina.
Spiega Piergiorgio Giorilli, acclamato nume della panificazione, in un bell'intervento nel sito dell'Accademia dei pizzaioli che «i metodi di impasto possono essere suddivisi, secondo una classificazione semplificata, in: metodo diretto; metodo semidiretto (con pasta di riporto); metodo indiretto (con biga o con poolish). Il metodo diretto consiste nell'impastamento di tutti gli ingredienti in un'unica fase (e possiamo usare come lievito tutti i lieviti sopracitati esclusi pasta di riporto, biga e poolish, n.d.r. ). Il metodo semidiretto con pasta di riporto consiste nell'impastamento in un'unica fase, ma utilizzando pasta di riporto. Il metodo indiretto prevede due fasi: nella prima si prepara un preimpasto (che può essere biga o poolish), nella seconda si aggiungono ai preimpasti precedentemente fermentati tutti gli altri ingredienti. I due preimpasti principali sono la biga e il poolish».
La pasta di riporto è un avanzo di impasto completo da usare come lievito entro pochi giorni - ma si può anche congelare - per impastare un nuovo panificato. La differenza tra lievito madre e licoli da una parte, biga e poolish dall'altra, è che i primi si preparano, si utilizzano solo in parte e si continuano a portare avanti nel tempo con i rinfreschi. Mentre la biga e il poolish si preparano e si usano una sola volta. I primi sono lieviti perenni, i secondi una tantum.
Ebbene, vediamo questi «usa e getta... nello stomaco» facendoci guidare ancora da Giorilli: «La biga è un preimpasto asciutto che può avere molte ore di fermentazione (da 16 a 48), ottenuto con farina, acqua e lievito», di solito 450 grammi di acqua, 1 chilo di farina e 10 grammi di lievito di birra fresco. Questa biga - che si chiama proprio come il carro da combattimento degli antichi romani trainato da due cavalli perché traina la lievitazione - esiste anche nella forma liquida chiamata poolish, «un preimpasto semiliquido ottenuto da farina e acqua (in eguale quantità) e lievito compresso». Giorilli spiega anche che «la poolish si è diffusa in Francia all'inizio del Novecento grazie a fornai provenienti da Vienna, per cui il termine viennoiseries è entrato nell'uso comune estendendosi però anche a prodotti come brioches e croissants». Che sono lievitati, come anche il pain au chocolat, ma dolci. Il nome viennoiserie, in Francia, si riferisce al negozietto che prepara e vende le viennoiseries, cioè i dolci da forno lievitati diversi dai prodotti della pâtisserie (la pasticceria). Il nome viennoiserie deriva dalla pasticceria viennese aperta dall'ufficiale austriaco in congedo August Zang a Parigi, in rue de Richelieu, alla metà del XIX secolo: il successo è tale che subisce l'imitazione di tanti fornai francesi e oggi quel nome indica il forno dolce francese per antonomasia.
Ma torniamo alle nostre lievitazioni. Che cosa accade quando inseriamo il lievito nell'impasto? Gli zuccheri cominceranno a essere scissi, così i lieviti inizieranno a nutrirsi e a riprodursi. Alimentandosi, creeranno CO2 cioè anidride carbonica - esattamente come noi quando digeriamo - e altri composti gassosi della fermentazione che daranno aroma e sapore al lievitato. Essi aumenteranno col passaggio del tempo - il tempo della lievitazione - perché ci saranno sempre più lieviti in fase di nutrizione e di riproduzione che resteranno imbrigliati nel reticolo glutinico dell'impasto, gonfiandolo. Come ci spiega di nuovo Pane e dolci al naturale: «La storia non va avanti all'infinito: a un certo punto il cibo inizia a scarseggiare, i lieviti sono al massimo della loro popolazione, e cominciano a morire o addirittura a mangiarsi tra loro. Prima che accada questo, il pane va messo in forno, dove gli ultimi frenetici momenti di vita dei lieviti (a 30 gradi mangiano e si moltiplicano a gran velocità, a 50 gradi muoiono) e l'evaporazione di parte dell'acqua contenuta nell'impasto produrranno una ulteriore crescita della pagnotta, più o meno nel primo quarto d'ora della cottura. Per chi fa il pane in casa ed è alle prime armi: se questo non succede, cioè se il pane messo in forno resta tal quale, la lievitazione è andata troppo avanti. Ma la pagnotta sarà commestibile ugualmente, solo con una punta di acido o forse un po' cruda in certi punti. La prossima volta infornate prima».