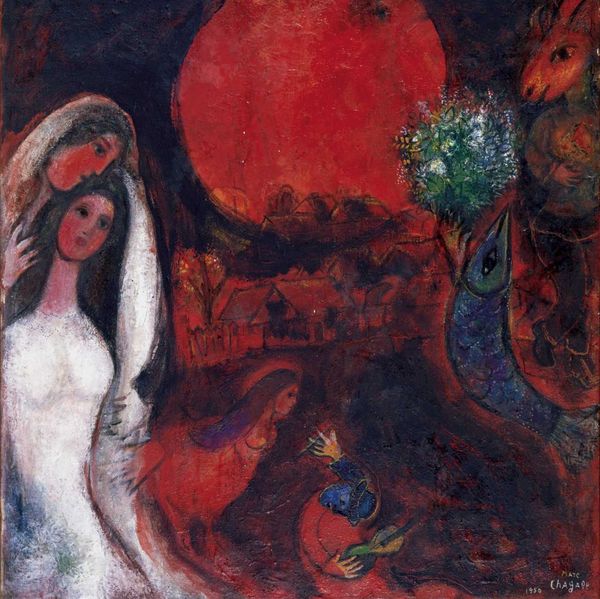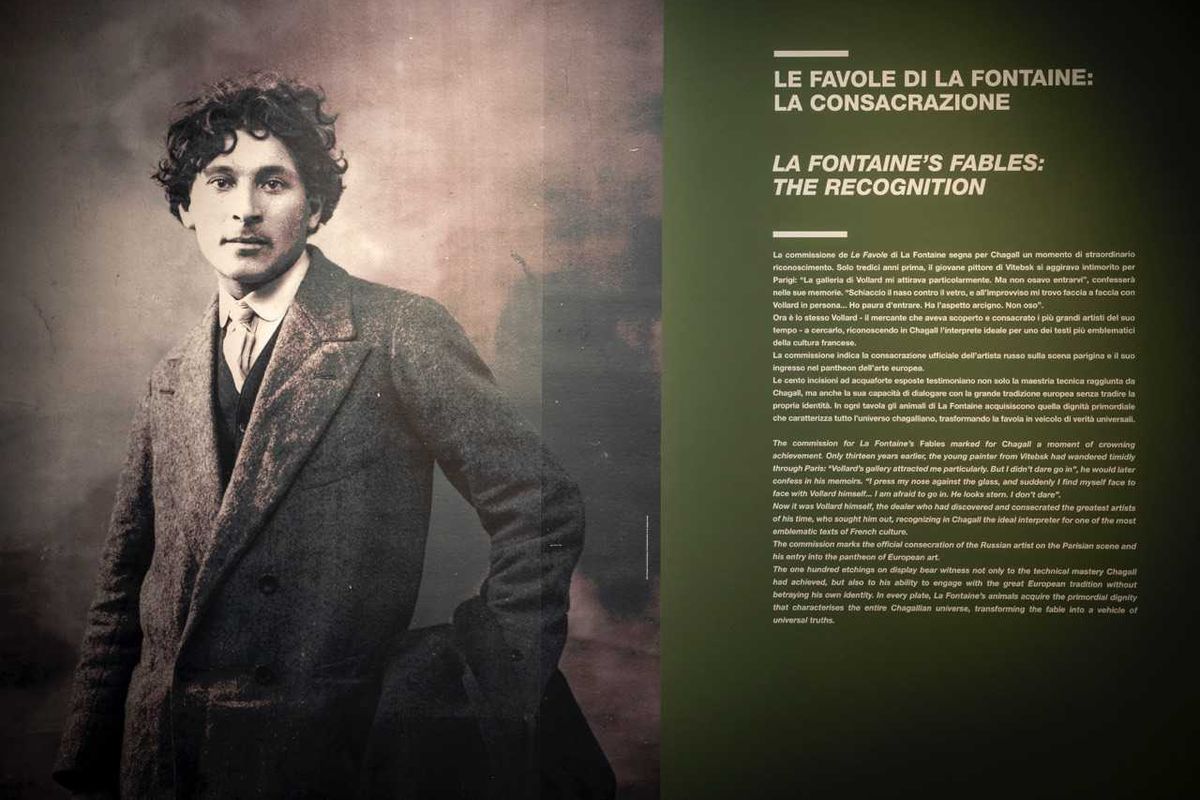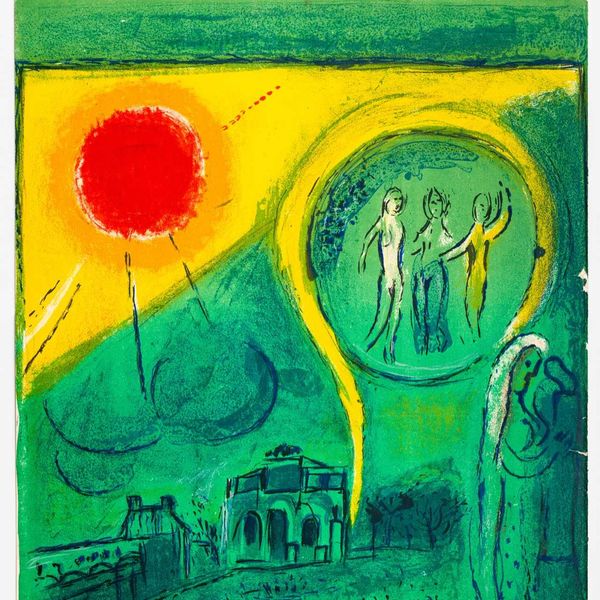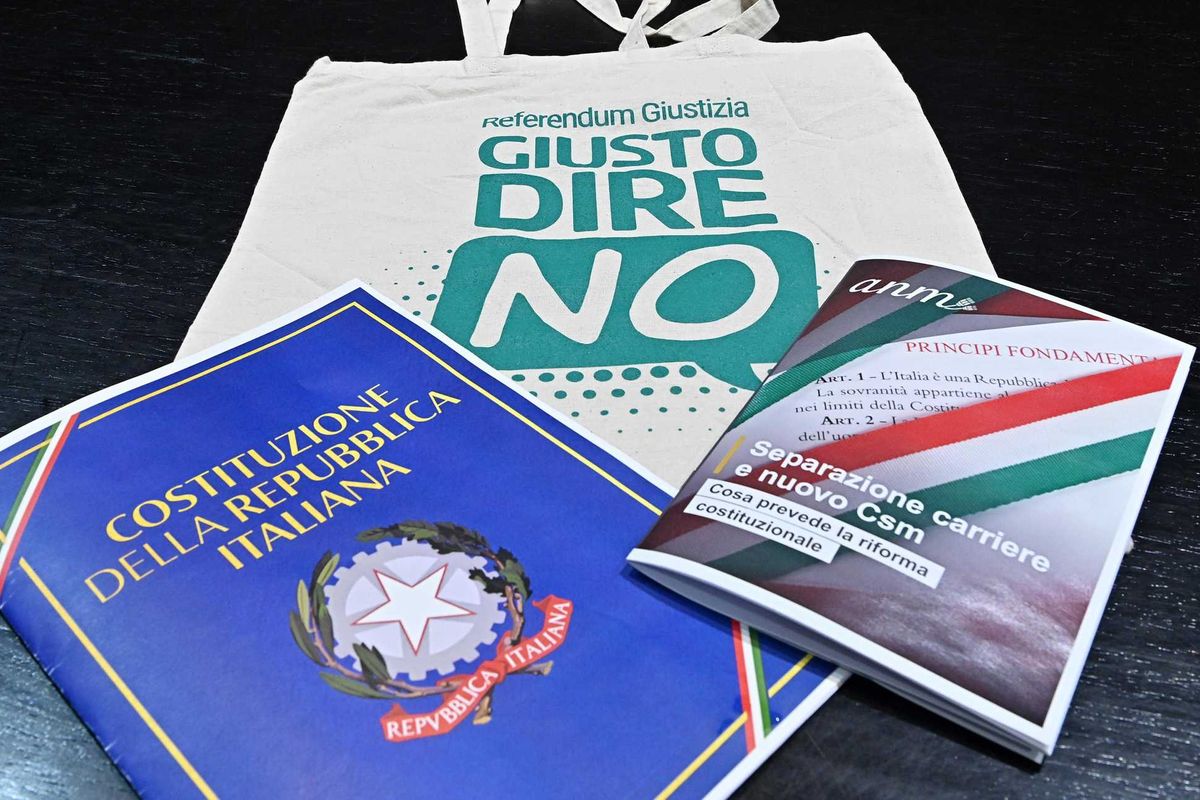«Lezioni di patria» in classe per evitare di crescere una generazione di sradicati

Qualche giorno fa, il presidente della Repubblica ha pronunciato una frase che molti giornali hanno sfruttato per alimentare la consueta polemica antigovernativa. «Io sono avanti negli anni», ha detto Sergio Mattarella, «sono nato durante i bombardamenti e, forse per questo, mi è rimasta un'innata diffidenza, e un'innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre». Sono parole molto pesanti, che meritano una riflessione profonda. Il presidente ha ripetuto un ragionamento che va per la maggiore: nazionalismo è sinonimo di guerra. È un'idea, questa, fin troppo diffusa. L'amor patrio è divenuto sinonimo di fascismo, la difesa del territorio è considerata l'anticamera del razzismo, ogni richiamo alla nazione è immediatamente osteggiato (o irriso).
Già solo la parola «patria» suona vetusta. È fuori moda, anticaglia. Per anni ci hanno spiegato che bisognava aprire le frontiere e abbattere i confini, perfino quelli linguistici. Il risultato è che oggi, se ci si imbatte in qualcuno che abbia una minima padronanza della lingua italiana, viene voglia di stringerlo e proteggerlo come un animale in via d'estinzione. L'inglese si è infiltrato in ogni pertugio: ovunque si vedono cartelloni pubblicitari con slogan anglosassoni. I termini inglesi stanno colonizzando e creolizzando la nostra lingua.
Ci siamo totalmente piegati - per ragioni di praticità e di efficienza, insomma per un motivo economico - al predominio della neolingua commerciale. Eppure resta vero ciò che sosteneva lo scrittore americano Wendell Berry, e cioè che «saremo in grado di capire il mondo, e di conservare al suo interno noi stessi e i nostri valori, soltanto fino a che possederemo un linguaggio pronto e reattivo nei suoi confronti». Bene, questo linguaggio ce lo stiamo facendo sottrarre da sotto il naso, ormai da troppo tempo.
Da un lato ci dedichiamo con perizia a smantellare il nostro patrimonio linguistico e culturale. Dall'altro inculchiamo nei ragazzi la necessità di accogliere l'altro e di rispettare ossequiosamente tutte le sue esigenze. «Inclusione», ci vuole. Nonostante, con il nuovo governo, il vento sia cambiato, certi vizi rimangono duri da estirpare. Si possono fare leggi e decreti, ma se non si cambia mentalità, ogni sforzo legislativo, a lungo termine, si rivelerà inutile. Se fossimo minimamente intenzionati a proteggere il nostro patrimonio - umano e intellettuale -dovremmo avere una sola «priorità nazionale». Quella di trasmettere agli studenti, fin da piccoli, un briciolo di amor patrio. Dovremmo rompere quel legame ribadito pure da Mattarella tra nazionalismo e guerra, tra orgoglio nazionale e violenza.
Sì, dovremmo fare «lezione di patria» in classe. Spiegare ai giovani, ai bambini persino, che amare il Paese in cui sono nati e cresciuti non è cosa da biechi reazionari. Che l'Italia merita (anche) di essere amata, rispettata e protetta.
Ma non lo facciamo. Dalla musica alla letteratura, sacrifichiamo tutto sull'altare dell'efficienza produttiva. Si parla di patria, e subito qualcuno s'indigna per lo sventolio dei gagliardetti. È una malattia, questa, e particolarmente grave. Roger Scruton l'ha chiamata oikofobia, e consiste in una raffinata quanto pericolosa forma di odio di sé.
Non si tratta, badate bene, di insegnare agli studenti a presidiare i confini e ad affondare i barconi dei clandestini. L'amor patrio diffuso avrebbe anche altri effetti. Ci si lamenta in continuazione, tanto per fare un esempio, della diffusione endemica della corruzione nel nostro Paese. Forse, se invece di sfiancarle con lezioncine mortifere sui «valori della legalità», avessimo insegnato alle nuove generazioni ad aver cura della loro terra - della loro casa - ci sarebbero meno funzionari corrotti, meno manager infedeli. Ci sarebbe un po' più di rispetto per la cosa pubblica. Ma da una generazione di sradicati, che cosa possiamo aspettarci?
Sarebbe bello leggere nelle classi il bel saggio di Simone Weil intitolato La prima radice. «Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell'anima umana», scrive la filosofa. «Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice».
E dove ci si radica «naturalmente» se non nella patria? Ciò non significa chiudersi a ogni influenza esterna. «Un determinato ambiente», scriveva ancora la Weil, «dev'essere influenzato dall'esterno, non per essere arricchito, ma per essere stimolato a rendere più intensa la propria vita. Deve nutrirsi degli apporti esterni soltanto dopo averli assorbiti».
Negli ultimi decenni, tutto è stato fatto pur di reciderla, questa «prima radice». Tutto è stato fatto pur di creare giovani senza patria, pronti a spostarsi alla bisogna, sempre disponibili, mobili, neutri, disinteressati alle sorti del loro Paese e concentrati soltanto sulla riuscita personale. È il momento di invertire la rotta.