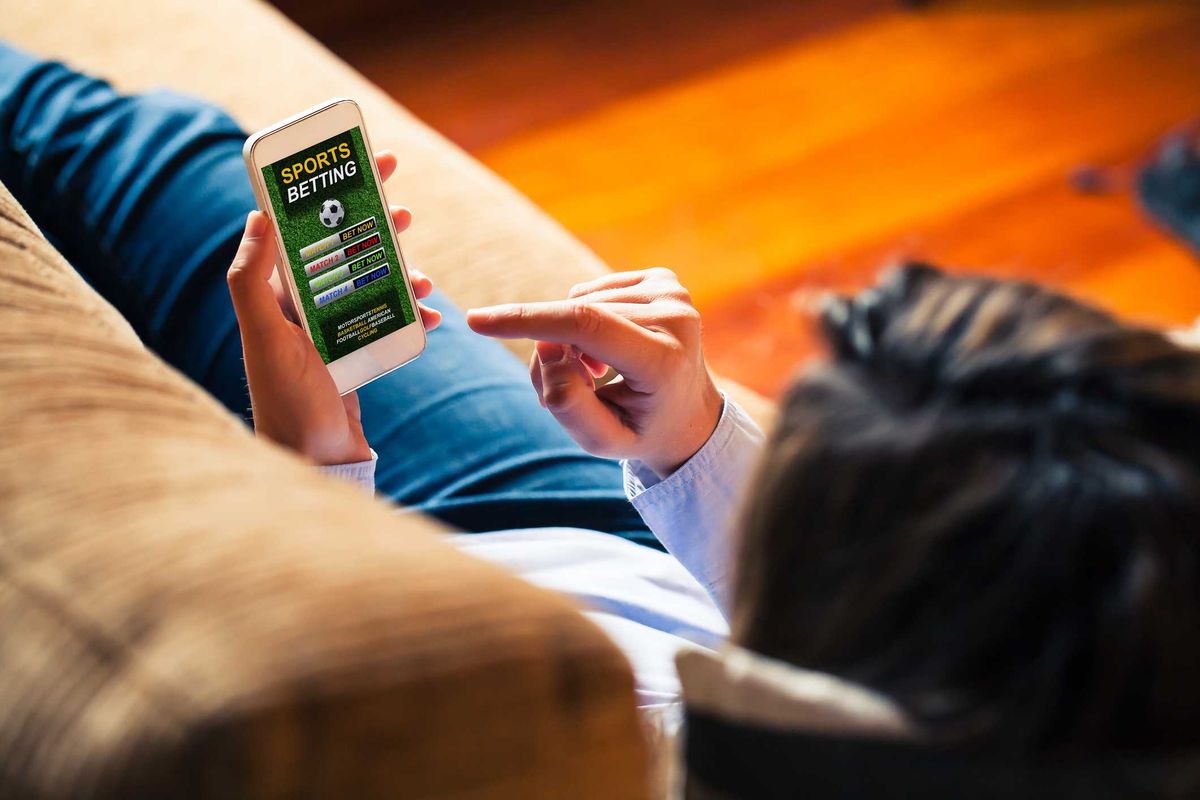2018-08-09
L’eredità dei Mandela: persecuzioni anti bianchi
Del leader sudafricano non si raccontano mai i lati oscuri, che hanno condotto all'attuale situazione del Paese: tra omicidi ed espropri di terre. L'attuale presidente, Cyril Ramaphosa, vuole modificare la Costituzione per rendere legale la sottrazione di fattorie senza risarcimento.Negli ultimi mesi, sui giornali e in televisione, si è molto parlato di Nelson Mandela. A metà luglio, l'ex presidente americano Barack Obama ha tenuto un appassionato discorso al Mandela Day organizzato a Johannesburg. Una cerimonia che ha assunto un particolare significato dal momento che, lo scorso aprile, è morta Winnie Madikizela, ex moglie di Nelson e storica leader dell'ala femminile del suo partito, l'African national congress. Ovviamente anche nel nostro Paese si sono sprecate le celebrazioni, le librerie sono invase di testi dedicati al celebre premio Nobel per la pace. Il Saggiatore ha pubblicato le sue lettere dal carcere, altri volumi sono usciti per Castelvecchi, Sperling, Rizzoli e Feltrinelli. Purtroppo, però, è molto difficile trovare un testo che vada oltre l'agiografia e consenta di fare luce sul Sudafrica di oggi. L'unico libro che offra spunti di riflessione interessanti in questo senso risale al 2014 e si intitola Mandela, l'apartheid e il nuovo Sudafrica (D'Ettoris editore). Lo firmano Giuseppe Brienza, Roberto Cavallo e Omar Ebrahime, con una bella prefazione di Rino Cammilleri. Intendiamoci: questo volume non offre chissà quali letture complottistiche. Semplicemente racconta una parte della storia che i grandi media preferiscono tenere in ombra. Cominciamo da quella che riguarda Winnie. Nelson la sposò nel 1958, dopo aver divorziato dalla precedente moglie (Evelyn, che lo accusò di adulterio). Divorziarono nel 1996, dopo l'uscita di Mandela dal carcere, ma si può dire che condivisero tutta la battaglia contro l'apartheid. Nel 1998, la South African Truth and Reconciliation Commission, cioè la commissione di riconciliazione sudafricana (voluta soprattutto da Mandela), dichiarò «la signora Winnie Madikizela Mandela politicamente e moralmente responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Mandela United Football Club», nonché «responsabile di gravi violazioni dei diritti umani». Il Mandela Football club era in effetti una squadra di calcio, ma era composto per lo più dalle guardie del corpo di Winnie, conosciute per il modo in cui trattavano gli oppositori politici (definirlo violento è un eufemismo). Come racconta Omar Ebrahime, «Winnie ha dichiarato più volte di approvare la pratica del necklacing (consistente nel dare fuoco alle persone dopo averle legate a un copertone di automobile, gettandogli sopra della benzina) e nel corso degli anni persino i suoi più stretti collaboratori della prima ora hanno decisamente preso le distanze da lei, accusandola di volta in volta di avere commesso dei reati e dei veri e propri crimini». In particolare, sarebbe stata coinvolta direttamente nell'omicidio, previa tortura, del quattordicenne James «Stompie» Seipei, brutalmente ucciso perché accusato di essere un informatore della polizia. Anche un altro ragazzo, Lolo Sono, sarebbe stato fatto fuori in modo analogo, così come il medico Abu-Baker Asvat. Nel 1997, il quotidiano britannico The Independent (decisamente schierato a sinistra) scrisse che «ci sono testimonianze dei genitori dei ragazzi scomparsi che descrivono la signora Mandela come un Angelo della morte delle baraccopoli». Nel 1998, pure Repubblica scrisse che l'African national congress tentò di impedire la pubblicazione del rapporto della commissione per la riconciliazione proprio perché conteneva queste «rivelazioni» su Winnie, che molti consideravano un'eroina. Fu addirittura Desmond Tutu, ex arcivescovo anglicano - anche lui premio Nobel e icona delle lotte anti apartheid - a pretendere che il rapporto fosse divulgato. Tutu attaccò duramente l'African national congress: «Ho combattuto contro la tirannia», disse. «Non l'ho fatto per sostituirla con un'altra. Se c'è una tirannia, mi opporrò con tutto me stesso». Winnie Mandela è senz'altro la figura più discutibile dell'intero pantheon mandeliano. Ma anche di Nelson viene spesso presentata un'immagine stereotipata. Di solito viene descritto come una specie di Gandhi sudafricano, un combattente per la pace e la giustizia. In realtà, egli fu sempre un fiero sostenitore della lotta armata. Anzi, fu lui a spingere sulla strada della battaglia violenta l'African national congress. Nella sua autobiografia (Lungo cammino verso la libertà, Feltrinelli) egli racconta di un dialogo con il governo afrikaner avvenuto nel 1988. «I rappresentanti del governo», scrive, «ribadivano che l'Anc doveva ripudiare la violenza e rinunciare alla lotta armata prima che il governo accettasse di sedere al tavolo dei negoziati. […] Risposi che proprio lo Stato era il responsabile della violenza […]. Se l'oppressore usava la violenza, l'oppresso non aveva alternativa che rispondere allo stesso modo, e nel nostro caso si trattava di una legittima forma di autodifesa». Non è un segreto, dunque, che l'Anc di Mandela facesse ricorso a tecniche di guerriglia. Né che intrattenesse rapporti molto stressi con i comunisti, in particolare con l'Unione sovietica. Sempre nel 1988, quando a Mandela fu chiesto di prendere le distanze dal partito comunista, egli rispose ai suoi interlocutori governativi che «un vero combattente per la libertà non poteva prendere ordini dal governo contro cui combatteva, e tanto meno separarsi da un alleato di antica data per far piacere all'avversario comune». A più riprese il leader sudafricano dichiarò di aver studiato i testi sacri del comunismo, e non rinnegò mai il suo legame con i sovietici.L'esame delle relazioni con l'Urss e delle fondamenta ideologiche dell'African national congress aiutano molto a comprendere che tipo di guerra si sia combattuta in Sudafrica fino a metà degli anni Novanta. Una guerra di cui la lotta anti apartheid era solo una parte, quella più raccontata dai media. I sovietici avrebbero voluto trasformare la nazione nel loro avamposto africano, per questo collaborarono con l'Anc a lungo. Ovviamente tutto ciò creò tensione, e tramutò la battaglia per i diritti civili in qualcosa di diverso. In verità, un processo distensivo fra bianchi e neri era già in corso. Si dimentica spesso infatti che assieme a Mandela a vincere il Nobel fu anche Frederik de Klerk, un afrikaner che nel 1989 conquistò la presidenza del National party sudafricano sostenendo posizioni apertamente anti apartheid. Nello stesso anno, de Klerk incontrò segretamente i vertici dell'Anc e dialogò pure con i sovietici onde preparare la fine della segregazione. Il ruolo dei bianchi nel crollo del regime razziale passa quasi sempre in ombra, ma va ricordato, specie oggi. Così come è bene ricostruire il ruolo che l'ideologia comunista ha svolto all'interno dei movimenti neri. La corrente radicale di sinistra che è sempre stata presente nell'Anc negli ultimi anni è cresciuta e si è trasformata in un nuovo partito, quello degli Eff (Economic freedom fighters) guidato da Julius Malema, il quale dal 2008 al 2012 è stato presidente della sezione giovanile dell'African National congress. Malema è un estremista, è a capo delle cosiddette «camicie rosse», ed è noto per aver invitato i suoi compagni di partito, tramite apposita canzoncina, a «sparare al boero». È il suo movimento ad aver avanzato, mesi fa, una proposta di legge per l'esproprio delle terre dei bianchi senza risarcimento. Secondo lui «il tempo della riconciliazione è finito, ora è giunto il tempo della giustizia». Purtroppo, le sue idee raccolgono parecchi consensi. Pochi giorni fa, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato che modificherà la Costituzione onde consentire l'esproprio delle terre dei bianchi. «Il programma di riforma agraria garantirà un accesso equo alla terra e sbloccherà la crescita economica portando al pieno utilizzo di un maggior numero di terreni in Sudafrica e consentendo la partecipazione produttiva di milioni di sudafricani all'economia», ha detto Ramaphosa. Non stupisce. Fu proprio Winnie Mandela a far avvicinare, anni fa, Malema e Ramaphosa. Del resto, come ha detto un intellettuale nero sudafricani, «se Julius Malema fosse una donna, sarebbe Winnie Mandela». Proprio al funerale di Winnie, Malema ha tenuto un appassionato discorso e si è riavvicinato a Ramaphosa perché «Winnie avrebbe voluto così». Qualche settimana dopo, a maggio, Ramaphosa ha dichiarato che «i membri dell'Eff sarebbero i benvenuti se volessero rientrare nell'Anc». Nei mesi successivi, gli scontri verbali tra i due sono proseguiti, ma è evidente che il governo sudafricano stia scivolando sempre più verso sinistra. E a farne le spese sono i boeri. Nonostante i bianchi abbiano fatto la loro parte per consentire la fine dell'apartheid, nonostante abbiano partecipato al processo di riconciliazione, oggi sono sotto tiro. Nel solo 2018, hanno spiegato all'Independent i responsabili dell'associazione Afriforum, gli attacchi alle fattorie dei boeri sono stati 109, e hanno causato la morte di 15 persone. Nel 2016, gli assalti sono stati 423, e i cadaveri rimasti a terra ben 82. Secondo le organizzazioni che rappresentano gli agricoltori, nelle zone rurali c'è un morto ogni cinque giorni. Sia la Russia che l'Australia, nelle scorse settimane, si sono dette disponibili ad accogliere i contadini che intendessero lasciare il Paese onde sfuggire agli attacchi. Quando però si fanno notare questi fatti, la risposta più comune è l'indifferenza. Ma c'è pure chi reagisce sostenendo che gli agricoltori bianchi dovrebbero smetterla di atteggiarsi a vittime. Questa posizione è comune pure tra gli intellettuali bianchi sudafricani liberal. Vergogna, romanzo del premio Nobel J.M. Coetzee, la esprime molto bene, così come Terra di sangue, thriller di Karin Brynard appena pubblicato in Italia da E/O, che pure riconosce l'esistenza delle violenze contro i farmers. Intanto, leader politici come Malema guadagnano consensi invocando gli espropri. Chissà se Nelson Mandela avrebbe apprezzato.