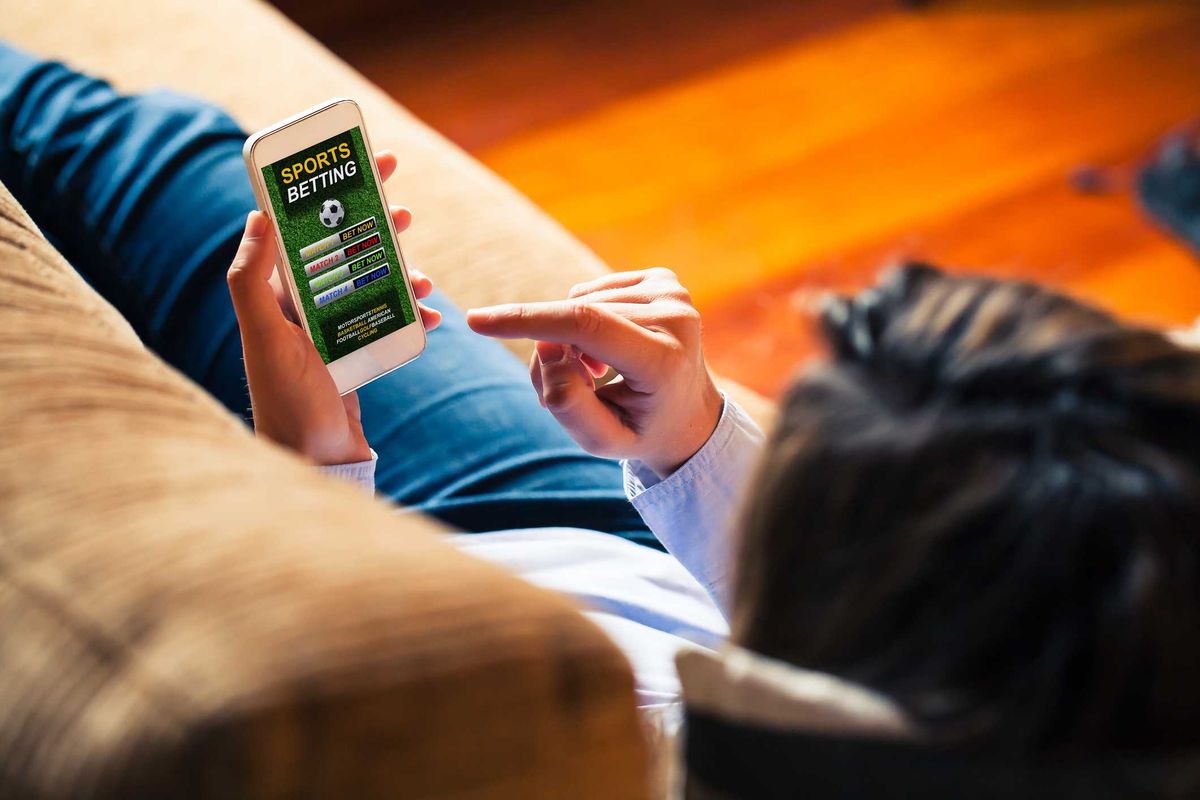2019-06-14
«Le fake news c’erano ai tempi di Socrate»
Il sociologo Gabriele Giacomini: «Sembra che le informazioni distorte e ingannevoli siano il male assoluto del nostro tempo. Ma la democrazia obbligò il filosofo a suicidarsi sulla base di dicerie. Oggi si cerca di dare ciò che un certo gruppo chiede: il conforto nelle proprie opinioni».Forse il modo migliore per affrontare la questione delle fake news è in prospettiva storica. Almeno così sostiene il sociologo Gabriele Giacomini, autore di libri e articoli scientifici sul rapporto tra neuroscienze, filosofia e politica, che La Verità ha incontrato per capire come mai su questo tema si sia arrivati a fare del terrorismo, eleggendo le informazioni distorte e ingannevoli a male assoluto del nostro tempo. Sul serio dobbiamo impaurirci per le bufale che corrono in Rete?«Si parla di fake news come se fosse una cosa moderna, contemporanea, alla moda, quando in realtà sono sempre esistite. Se non si coglie questa prospettiva, diventa molto difficile comprendere la novità delle fake news di oggi».A quando risalgono?«Pensi che la filosofia occidentale, per esempio, è nata per superare le fake news, difatti Platone l'ha fondata per opporsi ai sofisti di Protagora e di Gorgia». Cosa facevano esattamente costoro?«Utilizzavano le tipiche dinamiche delle fake news, come ad esempio l'obiezione ad hominem, cioè la strategia della retorica con la quale ci si allontana dall'argomento della polemica contestando l'interlocutore e non le sue affermazioni, oppure usavano il relativismo spinto, una scarsa adeguatezza ai fatti o alla realtà. Addirittura, anche la morte di Socrate è legata a una fake news».In che senso?«La democrazia lo ammazza, lo obbliga a suicidarsi sulla base di alcune dicerie sul suo comportamento che diventano delle prove per mandarlo a morire. Platone, scottato da queste conseguenze molto gravi della falsità che vince contro la verità rappresentata da Socrate, fonda la filosofia. Tant'è vero che esiste la distinzione tra doxa ed episteme, la prima sono le opinioni, la seconda è la scienza». Quindi si può dire che il pensiero occidentale sia nato in Grecia proprio come opposizione alle dicerie?«Sì, ma questo è solo un primo elemento, perché poi la storia continua. Dall'elezione di Donald Trump in poi si è cominciato, in maniera esponenziale, a parlare dell'impatto di queste notizie menzognere, ma già nel Medioevo c'erano delle donne che venivano accusate di stregoneria, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste, ma se ci pensate bene, si trattava di accuse fatte sulla base di fake news». E le conseguenze, checché se ne dica, erano molto più gravi di quelle che ci sono adesso…«Queste donne venivano arse vive, veda un po' lei».Durante la prima guerra mondiale secondo lei giravano le bufale?«Le trincee furono dei luoghi dove i soldati italiani si conobbero per la prima volta, uomini di diverse regioni che divennero Nazione in quel tragico momento, però furono anche il luogo di diffusione delle notizie manipolate».Qual è la spinta che crea le fake news? «Nascono quando non si crede più alla comunicazione istituzionale. I proclami di Cadorna o di Diaz erano poco credibili perché erano propaganda e quindi le dicerie si diffondevano tantissimo di bocca in bocca. Le fake news spesso invertono il verso di casualità, infatti in quel periodo si diceva che i commercianti di cannoni avevano causato la guerra, ma la verità era all'opposto, difatti la guerra aveva arricchito i commercianti di cannoni, ma non avrebbero mai avuto il potere, la forza, per farla scoppiare». Nell'ambito della cronaca contemporanea ci si dimentica che le caratteristiche della disinformazione hanno questo imponente passato…«Addirittura se ne estendono le conseguenze a degli elementi che non dipendono solo dalle fake news. Il classico esempio è quello di Hillary Clinton nelle ultime presidenziali americane: si dice che esse abbiano avuto un ruolo importante nella sua sconfitta, ma forse ci si dimentica che in queste dinamiche la parte del leone la fanno i partiti e quindi se si sbaglia candidato c'è poco da demonizzare le finte notizie che circolano sui social».Esiste però un elemento di novità nelle bufale di oggi rispetto a quelle di ieri? «Sì. Questo elemento lo troviamo nella personalizzazione dei contenuti, difatti oggi c'è una capacità di studio e di analisi molto più approfondita. Lo scenario attuale è forse più collegato al concetto di echo-chambers (camere dell'eco, ndr)». Ci dica di più…«Nel momento in cui io posso studiare in maniera accurata il mio pubblico di riferimento e nel momento in cui, con le tecnologie, riesco a creare degli ambienti informativi misurati sulle singole persone, allora io riesco a soppesare le loro opinioni e mi basta semplicemente portarle a confermare quelle proprie opinioni». Insomma, non serve inventarsi balle?«Più che costruire fake news, nel nostro tempo si costruiscono gruppi ristretti in cui i gusti sono simili e le grandi società tecnologiche non devono far altro che limitare gli incontri casuali, cioè tendono a dare ciò che piace e non ciò che non piace. In questo modo, il gusto si atrofizza e l'incontro con altre persone, con quanti la pensano diversamente, rischia di limitarsi».Ed è pericoloso?«In questo ambiente è vero che c'è un mattoncino in più per la diffusione delle storiche fake news, ma guai a dire che qui sono nate. Il vero tema di attualità è che oggi non esiste più una piazza con diverse voci, ma esistono diverse piazzette, dove si tende ad ascoltare una stessa e unica voce. Se lì, all'interno della piccola piazzetta con un pubblico omogeneo viene lanciata la giusta fake news, ecco che si diffonde». La riflessione etica, dunque, più che monito rivolto agli utenti dei social andrebbe secondo lei diffusa ai piani alti della Silicon valley?«Parlerei più di strumenti intellettuali diffusi che di etica: un utente con spirito critico diffida dalle bufale. Le grandi aziende, dal canto loro, pensano troppo agli scopi commerciali, ma avendo un ruolo importante dal punto di vista pubblico, dovrebbero esserne più responsabili»La paura all'ordine del giorno sembra anche legata all'odio in rete, ai cosiddetti hate speech: sicuri che non sia solo una scusa per abbassare il volume di qualsiasi protesta, anche lecita?«Il termine hate speech si riferisce a una dinamica che avviene su Internet, dove in effetti la comunicazione mediata dal computer disattiva alcuni freni inibitori che noi abbiamo nel nostro sistema del cervello emotivo. Quando abbiamo di fronte un viso abbiamo molti più freni nel dirgli possibile offese, quindi in Rete c'è un tasso di incitamento all'odio che non è presente nella realtà».