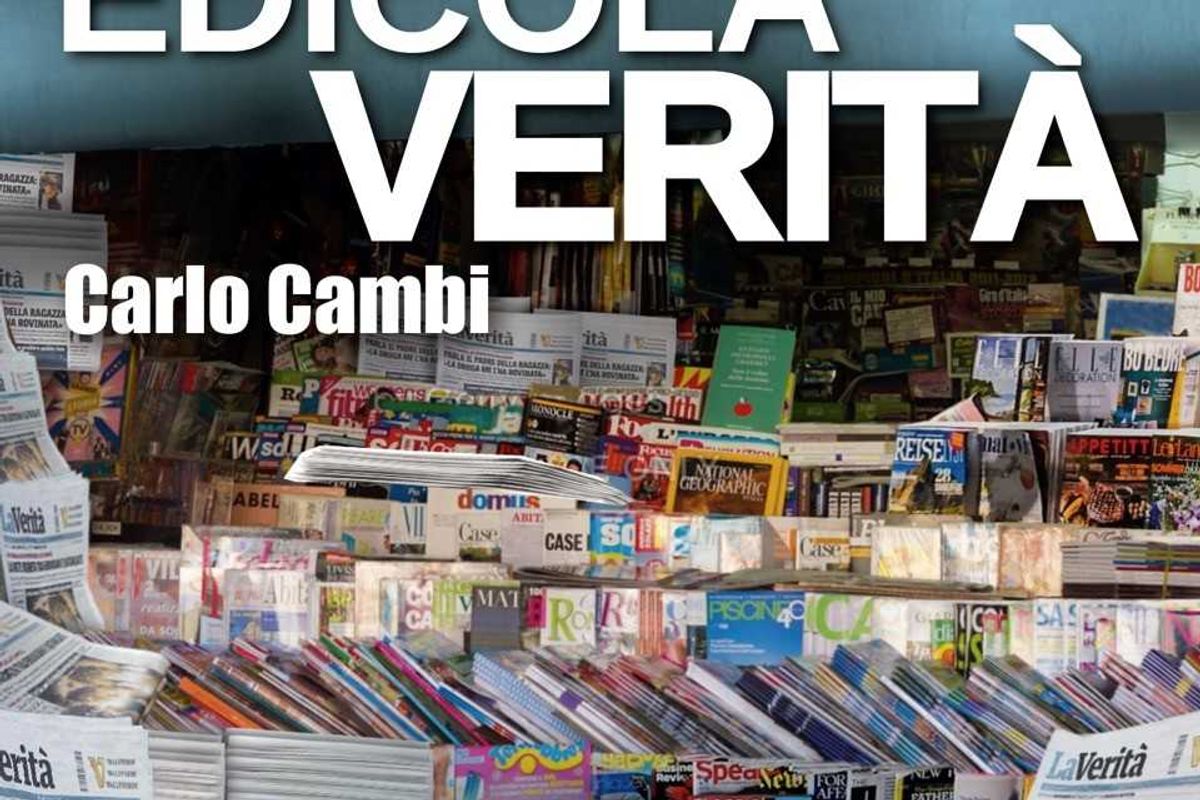L’articolo 1 della Carta: un mito rosso scritto da chi fu sedotto dal fascismo

«Fondata sul lavoro». Preparatevi bene, perché in questi giorni questa formula la sentirete parecchio, magari sulla bocca di gente che non ha lavorato un solo giorno della sua vita.
Ma ci si è mai chiesti chi fu l’autore di quella definizione presente nel primo articolo della Carta? Gli atti dell’Assemblea costituente sono facilmente reperibili online e la storia del primo articolo è nota. La sua prima formulazione, il 16 ottobre 1946, si deve a Giorgio La Pira, della Dc: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale e la sua partecipazione, adeguata negli organismi economici, sociali e politici, è condizione del nuovo carattere democratico», vi si leggeva.
Due giorni dopo, il 18 ottobre 1946, Palmiro Togliatti propose una nuova formula, tutt’altro che «innocente»: «Lo Stato italiano è una Repubblica di lavoratori». Ne nacque un serrato dibattito in punta di diritto e di filosofia, con scritture e riscritture. La formula togliattiana pareva alludere troppo direttamente al gergo dei regimi comunisti. Per alleviare un po’ il tono classista, il dirigente del Pci propose di aggiungere «lavoratori del braccio e della mente». Alla fine, il 22 marzo, l’Assemblea costituente, su proposta di Amintore Fanfani e di Aldo Moro, approva l’articolo 1 nel suo testo attuale: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».
Così Fanfani spiegava il senso della formulazione poi diventata definitiva: «Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa si fonda sul dovere, che è anche diritto a un tempo per ogni uomo, di trovare nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere d’ogni uomo di essere quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali». Parole davvero ispirate, non c’è che dire. Del resto Fanfani era uno che di lavoro se ne intendeva, avendolo studiato a fondo… durante il fascismo.
Iscritto al Pnf, docente alla Cattolica dal 1933, Fanfani era un convinto sostenitore del corporativismo, certo in continuità con la lezione della Quadragesimo anno di Pio XI, ma con una netta propensione per l’esperimento mussoliniano. Ricorda l’enciclopedia Treccani: «Le sue spiccate simpatie per il fascismo si estendevano ad altri aspetti politici, tra cui l’imperialismo etiopico e l’eugenetica, arrivando ad appoggiare con qualche passaggio nei suoi articoli la nuova politica razziale nel 1938-39. Collaborò al periodico Dottrina fascista e partecipò al comitato scientifico della rivista Geopolitica […] Era un orientamento che doveva rimanere duraturo, fino almeno al 1941, ben oltre l’alleanza con la Germania nazista e l’ingresso in guerra. Solo nel corso del 1942 ci furono i segni di un giudizio che diveniva sempre più critico». Fanfani aveva anche curato i primi due volumi di una monumentale Storia del lavoro, approvata da Benito Mussolini in persona e progettata nell’ambito dei sindacati fascisti.
Quanto all’altro ispiratore del primo articolo della Carta, Aldo Moro, giova ricordare che anche lui fu fascista fino al 1943, prima nei Guf, poi come docente universitario, lambendo, in un corso universitario del 1943, persino posizioni razziste.
Leggendo gli atti della Costituente, peraltro, di nomi che parteciparono alla discussione sulla Repubblica «fondata sul lavoro», ma che avevano un passato ambiguo, ce n’erano. Pensiamo ad Arturo Labriola, già soreliano e anarcosindacalista, poi antifascista ed esule, ma protagonista di una clamorosa svolta personale nel 1935, quando sostenne la guerra in Etiopia e rientrò in Italia. Mussolini lo ricompensò con l’offerta di un impiego per lui e per il figlio Lucio, rispettivamente al Banco di Napoli e alla Montecatini. Cominciò a collaborare con due giornali italiani stampati in Francia, Il Merlo e poi La Tribuna d’Italia che avevano come principale bersaglio gli antifascisti in esilio.
Comunista di provata fede era, invece, un altro membro dell’Assemblea intervenuto sul tema, Concetto Marchesi. Quando però morì, nel 1957, un suo compagno di partito, Ludovico Geymonat scrisse, in una lettera indirizzata alla Stampa di Torino, della «difficoltà di conciliare l’affermata intransigenza del Marchesi con il suo compromesso nei riguardi del fascismo, allorché restò sulla cattedra di Padova, mentre scienziati come Martinetti, Carrara, Volterra, Venturi etc. si lasciavano cacciare dall’Università per non voler giurare fede al regime fascista, e Gramsci e tanti altri compagni rimanevano in carcere per non chiedere grazia a Mussolini».
I suoi ripetuti giuramenti al regime fecero scalpore. E nella sua stessa veste di latinista, ha scritto recentemente Luciano Canfora, «il suo modo di ripensare e rievocare quel passato (dell’Impero romano, ndr), compresa l’esaltazione - giustificazionista - del ruolo civilizzatore-mondiale di Roma, lo poneva in una posizione di confluenza rispetto all’uso fascista della “romanità”». Ma non ditelo ai sindacati.