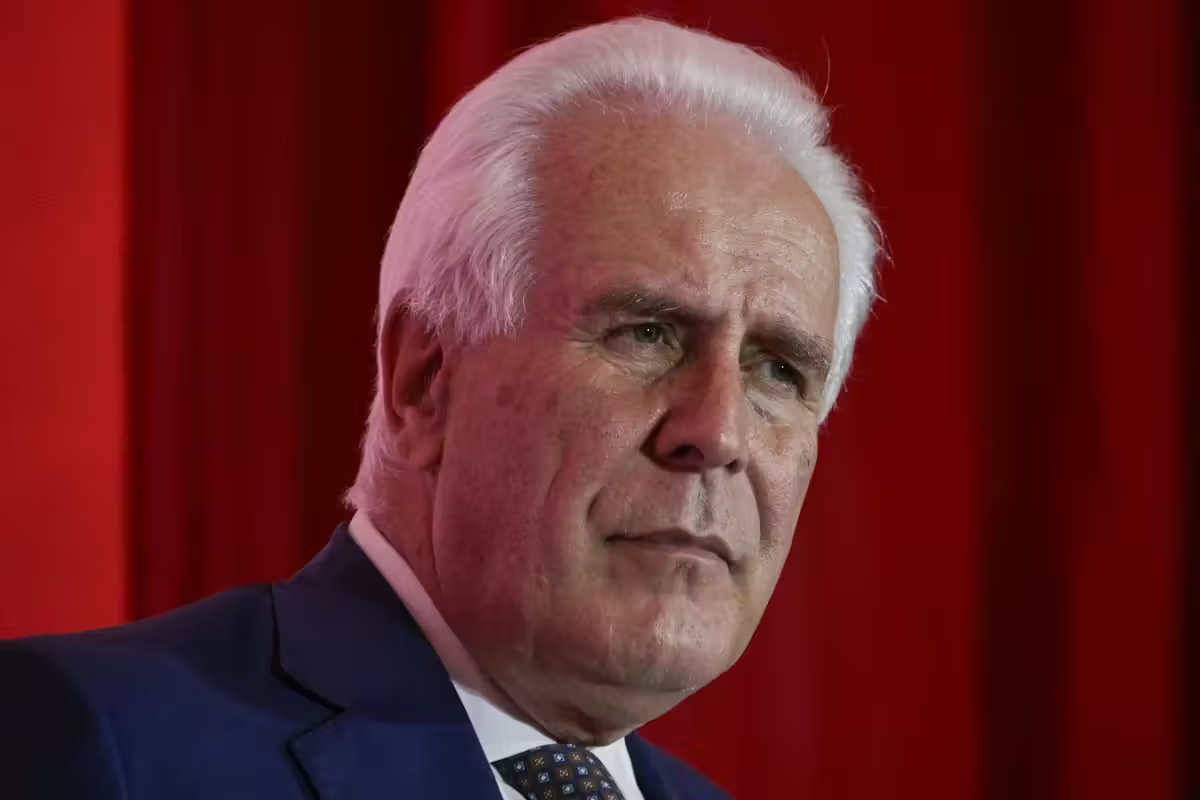Spaturnati di tutto il mondo unitevi. Spaturnati, nel lessico meridionale, calabrese in particolare, sono letteralmente i nati senza patria. Esattamente come i proletari senza patria a cui si rivolgeva il manifesto comunista di Marx ed Engels. Ma da noi mediterranei e meridionali, al Sud, non ci si unisce per fare la rivoluzione semmai per compiere la lamentazione. Reciproca, teatrale, corale. A Soveria Mannelli, un paese dell’alta Calabria (anche la Calabria ha la sua Padania), dall’1 al 4 agosto si abbatterà il festival del lamento, dedicato appunto agli spaturnati, indigeni e allogeni. Tra tanti festival che al Sud vogliono indicare o simulare dinamismo e contemporaneità, ecco un festival che al contrario riporta il Sud alla sua antica, endemica attitudine: lamentarsi. Alla lagna ancestrale è dedicato questo festival ed è evidente un filo di ironia e di autocritica; diciamo con il terronissimo Gianbattista Vico che l’intento è trasformare una maledizione in un’opportunità, un handicap in una risorsa. O per i credenti, una disgrazia in una grazia. È la Magna Grecia che non vuol ridursi a Lagna Grecia. Lagnarsi a Sud è un vizio, uno sport e a volte perfino un mestiere. «Querulo ergo sum», mi lagno dunque sono (da «querulus» latino); fa parte dell’indole meridionale o più largamente italiana, anzi mediterranea. Il convegno calabrese è fatto di relazioni e lamentazioni, musica, teatro e «piccoli lamenti» dedicati ai bambini, cori sconfortati e «conforti», come da noi si chiamavano le pietanze consolatorie mandate alle famiglie che avevano perduto un loro caro, fino a una lagna collettiva ribattezzata spopo-lamenti.
Soveria è un comune fuori dal comune, da diverso tempo: col suo estroso sindaco Mario Caligiuri, regnante leggendario per tanti anni, si fece notare per la toponomastica fantasiosa (Via col Vento, Piazza Pulita, Largo ai Giovani ecc.), per alcune cittadinanze onorarie (a Saddam Hussein, per esempio, mentre era considerato il Male assoluto), per alcuni convegni (come quello mondiale sulle pompe funebri), per alcuni assessorati (come quello al «dissolvimento dell’ovvio»). Io scoprii questo Comune e il suo sindaco dell’epoca perché al tempo in cui piangevano le statue delle madonne, lui si inventò che al suo paese piangeva il busto di Garibaldi, commiserando l’Italia spaturnata.
Ma torniamo al Sud che riconosce la sua propensione al lamento. «Buon segno quando si fa amicizia con i propri difetti», commenta il poeta e paesologo Franco Arminio, del profondo Sud. E Lino Patruno nel suo libro Il sud ha vinto (ed. Secop) - un titolo che rovescia il destino di vinti al sud - osserva: «Non è più tempo di dolorismo, di sconfittismo, di perditismo, di fatalismo, di sfortunismo». Basta lagnarsi, l’alibi della sfiga porta sfiga…
La lagna è una richiesta di commiserazione e di coccole, ma anche il segno di un’atavica attitudine un tempo versata nella rassegnazione religiosa e nelle preghiere e ora invece vagante nell’aria e poi precipitare nel vittimismo. Il fatalismo è rassegnazione, il vittimismo è richiesta di compatimento e magari di aiuto e risarcimento. Viviamo nell’epoca del vittimismo, come in modi diversi ci hanno detto René Girard e di recente Peter Bruckner; ma al sud il vittimismo gioca in casa. Campione odierno del vittimismo è Roberto Saviano, che ha fatto del vittimismo il suo eroismo di martire potenziale e la sua ricerca di affetto corale; ma oltre il suo narcisismo, il suo egocentrismo, e la sua ossessiva richiesta di attenzione, c’è da riconoscergli di aver vissuto anni di sofferto isolamento (anche se ben risarcito) perché sotto scorta e sotto eterna, presunta minaccia. Al mio paese chi si lamentava sempre pur vivendo negli agi veniva chiamato «la gatta del seminario» perché si lagnava di continuo ma vivendo presso un refettorio, e in un luogo considerato ameno e caritatevole, non le mancavano il cibo, la sicurezza e il benessere. Non era un gatto di strada, era coccolato da una comunità di anime pie.
Agli occhi del nord, in particolare tra i calvinisti, la lagna è la commutazione in lacrime della scarsa voglia di fare, di agire, di lavorare tipica dei meridionali. Anche se, a dir la verità, io conosco, sì, il Sud che si perde nell’ozio, nell’inerzia, o al meglio nella contemplazione, conosco il furbo far niente o l’atavica indolenza ma c’è una vasta popolazione di origine contadina, artigiana, marinara, oltre che di massaie, fatta di veri e severi «fatigatori» che «gettavano il sangue» per campare e per far mangiare le loro numerose famiglie; e li allevavano fin da piccoli a guadagnarsi il pane col sudore della fronte. In alcune zone del sud lavorare si dice in dialetto «travagliare», come in sala parto; ma il verbo che identifica il lavorare col penare non ha origine magno-greca e terrona, è un francesismo. E l’idea del lavoro come pena è di origine biblica, risale alla cacciata dall’eden.
La lagna non è solo l’alibi per non fare, ma è anche la resa dell’esagerato orgoglio meridionale; è l'ammissione di mortalità, di vulnerabilità, di vecchiaia e di sottomissione, sentirsi in balia di cose più grandi, a partire dal Fato o per i credenti la Divina Provvidenza. Resta tuttavia che lamentarsi è sempre stato l’alibi dei popoli vinti che si arrendono prima di combattere e sfidare la sorte; è la polizza, in verità un po’ misera, per giustificare i propri fallimenti e la propria inadeguatezza, salvo i casi in cui vere tragedie e inevitabili miserie si sono realmente abbattute su inermi esistenze e collettività, piegandole o spezzandole.
Non può mancare nel convegno sul lamento il riferimento in uno spettacolo teatrale a Ernesto De Martino, il grande etnologo del sud che scrisse tra l’altro Morte e pianto rituale. Lui studiò l’antropologia del lamento del sud. Proprio in questi giorni sono stati pubblicati alcuni suoi scritti sotto il titolo suggestivo La storia velata; velata sia perché nascosta sia perché velata di lacrime, di pianti antichi. De Martino indaga sulla matrice religiosa, magica, sacra, dei simboli, dei miti e dei riti, humus profondo del Sud. De Martino è per certi versi speculare a Mircea Eliade, che ammirò e avversò con particolare accanimento: De Martino racconta la fenomenologia del sacro e delle religioni da un punto di vista storico-sociale, in una lettura storicista tra Croce e a Marx. Ma quando si libera del razionalismo e del dominante materialismo del suo tempo, riaffiora nello studioso napoletano la sua indole di uomo del Sud, non così lontano da coloro che studiava e osservava. In fondo al testo c’è una sua lirica dedicata alla «beata ovvietà del mondo» e alla «beata patria anonima, radice segreta, suolo fermo, orizzonte sicuro». Quasi una risposta al sud spaturnato, non più terra del rimorso ma quasi terra del ritorno; e l’evocazione di una continuità tra «vivi e morti, padri e paesaggi», «generazioni scomparse, civiltà sepolte», «stanchezza di popoli ormai dimenticati», padri «congiunti a me come capelli», «preghiera di vita custodita ora nelle abitudini del mio corpo». Lo studioso lascia le carte e la distanza critica dal suo popolo e riprende mani nelle mani il cerchio della vita, tra mani visibili e invisibili; torna alla sua gente e a quel mondo antico da cui proviene. È quel che go voluto fare anch’io col recente C’era una volta il Sud. (Me lo cito da solo visto il silenzio stampa sul libro).
Giusto o sbagliato che sia, è comunque il «suo» mondo (ed anche il mio). Un mondo di cui magari non essere sempre fieri ma da amare e di cui riconoscersi figli. Ma lagnarsi, come inorgoglirsi, è fuori luogo.