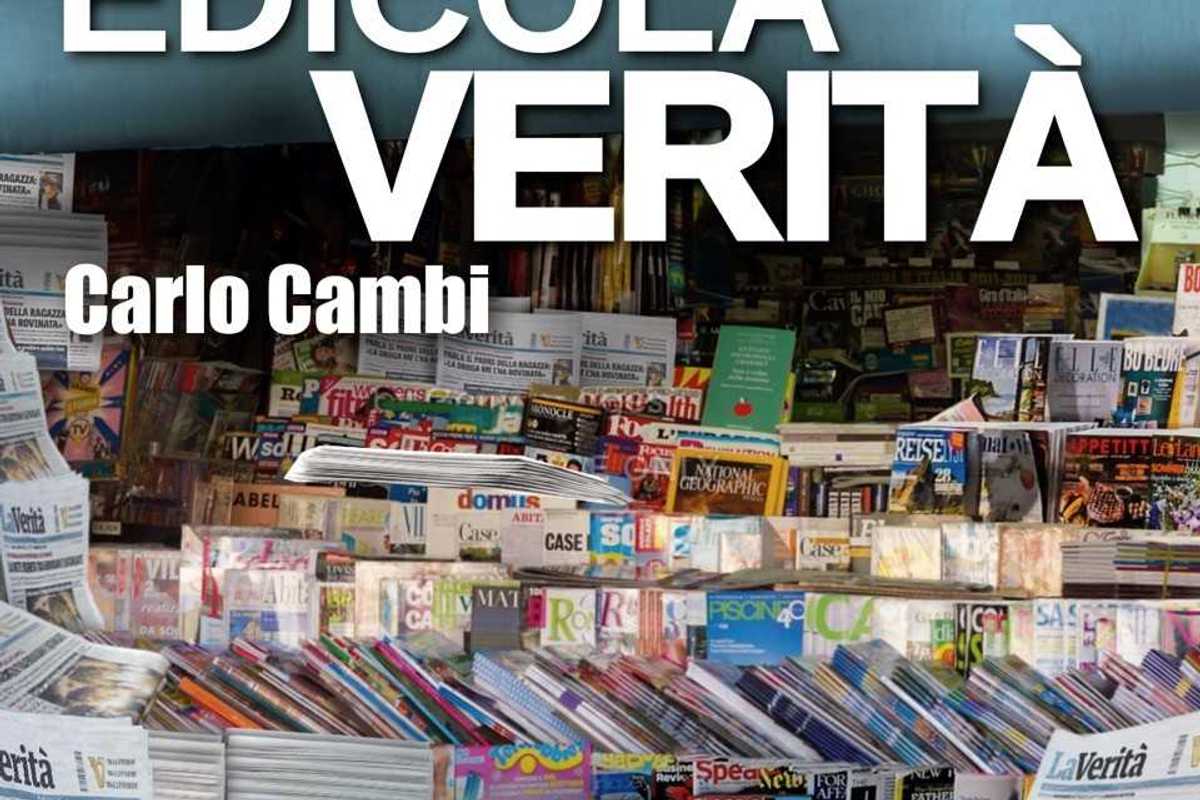Oggi se ne conserva un'eco solamente in qualche vignetta satirica, per il resto il marketing politico lideristico ha fagocitato qualsiasi riferimento a simboli storici identitari. Eppure, per diverse generazioni di connazionali, l'Italia ha sempre avuto un volto e delle fattezze ben riconoscibili: sembianze di donna - trionfante o, per lo più, sofferente - e una corona a forma di torre. È la famosa icona dell'Italia turrita, a cui sono dedicati gran parte dei saggi raccolti in un nuovo saggio appena uscito per i tipi di Marsilio: L'Italia immaginata. Iconografia di una nazione, a cura dello storico Giovanni Belardelli. Beninteso, non è solo l'Italia a incarnarsi in fattezze femminili: dalla Marianne francese alle antiche raffigurazioni della Britannia, si tratta anzi di un'iconografia ricorrente e che, spiega il curatore, «precede di molti secoli la comparsa di qualunque idea di nazione in senso moderno e poi quasi scompare per un lungo periodo. Ricompare all'inizio dell'età moderna, quando si formano le grandi monarchie nazionali europee e con il Rinascimento si tornano a studiare sculture e monete antiche, che di quelle allegorie femminili forniscono numerosi esempi». Se lo Stato nazione è sicuramente creazione recente, quindi, l'idea della nazione come personalità storica, entità culturale e persino archetipo sacrale affonda invece le sue radici nella notte dei tempi. Molto opportunamente, nel suocontributo Francesco Marcattili riconduce l'immagine dell'Italia turrita a quella della Magna Mater e della Cibele turrita, «divinità introdotta nell'Urbs dall'Asia nel 204 a.C., e che gli autori latini dei secoli successivi definiranno o descriveranno “turrita", “vertice turrigero", “muralique caput summum [...] corona" (“con la sommità del capo cinta da una corona di mura"), trasportata su un carro “Phrygias turrita per urbes" (“attraverso le città frigie con la corona di torri") o ancora, nella preghiera di Enea del x libro dell'Eneide, amante delle “turrigerae urbes"».
Nel saggio viene tuttavia solo accennato il legame tra la Cibele anatolica e la potente emersione dell'idea di Italia che si verifica in un momento ben preciso della storia romana, e cioè nel corso della seconda Guerra punica. Durante la consultazione dei libri sibillini nel 205 a.C., infatti, fu scoperto un carmen in cui era scritto che ogni volta che un «nemico straniero» (hostis alienigena) avesse «mosso guerra alla terra Italia», questi avrebbe potuto essere cacciato e vinto, «se la Madre idea fosse stata trasportata a Roma da Pessinunte». La Madre idea non era altro che Cibele, così chiamata dal monte Ida, situato presso Troia. È degno di nota che il nemico citato nel vaticinio stesse conducendo una guerra contro l'Italia, non soltanto contro Roma, che infatti non viene nominata. Per sconfiggere il nemico straniero, quindi, e rendere inviolabile tutta la sacra terra italica, si procedette a incorporare Cibele nel corpus religioso romano. Per Roma, comunque, si trattava di un vero e proprio «ritorno alle origini»: origini troiane, quindi origini italiche, alla luce del ricordo del mitico fondatore della città anatolica, Dardano, che proprio dalle coste italiane era salpato. Significativo di questa nuova sensibilità è il discorso che, secondo Tito Livio, Gaio Terenzio Varrone rivolse ai capuani dopo la sconfitta di Canne: «Bisogna quindi, o campani, che comune voi consideriate questa di- sfatta, che una patria comune voi sappiate che si deve ora difendere. Non con sanniti o con etruschi è ora la lotta, tale che il dominio, anche se fosse tolto a noi, rimarrebbe pur sempre in Italia; ora il nemico è punico, neanche indigeno: dalle più remote contrade della Terra, dallo stretto oceanico e dalle Colonne d'Ercole, si trae dietro una soldataglia ignara d'ogni ordine, quasi d'ogni umano linguaggio». Dopo questa epifania dell'idea culturale e sacrale della «Terra Italia» e dopo il progetto augusteo di riattivazione del mito ancestrale della Saturnia Tellus, l'immagine dell'Italia subirà varie emersioni e sommersioni culturale.
Una sua riapparizione diventata canonica è quella tratteggiata nella famosa Iconologia dell'erudito rinascimentale Cesare Ripa, pubblicata per la prima volta a Roma nel 1593, a cui dedica un saggio Cristina Galassi. Eloquente la descrizione della rappresentazione dell'Italia fatta da Ripa: «Una bellissima donna vestita d'abito sontuoso e ricco, la quale siede sopra un globo; ha coronata la testa di torre, di muraglie, con la destra tiene uno scettro, ovvero un'asta, che con l'uno e con l'altra vien dimostrata nelle sopradette medaglie, e con la sinistra mano un cornucopia pieno di diversi frutti, et oltre ciò faremo anco che abbia sopra la testa una bellissima stella».
Il tema della stella ci riconduce a un altro simbolo di origine antichissima collegato all'Italia: il famoso Stellone, cioè l'astro di Venere che pare sia particolarmente brillante nei cieli del Belpaese. Le testimonianze dell'epoca raccontano che quando, il 27 novembre 1871, re Vittorio Emanuele II inaugurò il Parlamento a Roma, nei cieli della capitale brillò lucentissima sul Quirinale la stella di Venere. La circostanza è ricordata anche nei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci: «La visibilità di Venere in pieno giorno pare sia fenomeno raro, non rarissimo, già osservato dagli antichi e nel Medio Evo. Nel dicembre 1797 quando Napoleone tornò trionfalmente a Parigi dopo la guerra italiana si vide il pianeta di giorno e il popolo diceva che era la stella di Napoleone». Ma, di nuovo, le origini del simbolo ci riportano a Roma, giacché quell'astro altro non era che l'antica stella della gens Julia, di Enea, di Cesare, di Augusto, che appunto avevano Venere come numen di riferimento.
Lo Stellone ha comunque avuto lunga vita, tanto da finire nell'emblema della Repubblica italiana adottato ufficialmente il 5 maggio 1948 e disegnato da Paolo Paschetto. Il secondo dopoguerra fu del resto un'epoca ricca di rivisitazioni simboliche, dopo i vent'anni precedenti in cui il fascismo aveva incorporato nella propria liturgia tutti i simboli nazionali. Rispuntò fuori anche l'Italia turrita, non più però come simbolo unificante. Come spiega Cristina Baldassini nel suo saggio, dopo il 1945, «l'Italia turrita non recuperò il suo carattere neutro: negli anni immediatamente successivi la Democrazia cristiana e soprattutto i settori della destra moderata e monarchica se ne appropriarono ampiamente, raffigurandola nelle vesti dell'unica e vera Italia di cui tali forze si ritenevano rappresentanti e perciò in dovere di salvarla dalla minaccia comunista. La nota figura allegorica seguitò così a rappresentare solo una parte della nazione, lasciando irrimediabilmente fuori l'altra. Questo passaggio avvenne attraverso alcune espressioni della satira politica e massimamente nella campagna elettorale del 18 aprile 1948». Per attendere una rivalutazione dei simboli nazionali a sinistra si sarebbe dovuti attendere Bettino Craxi e quello che Giano Accame chiamava il «socialismo tricolore». Ma questa, decisamente, è un'altra storia.