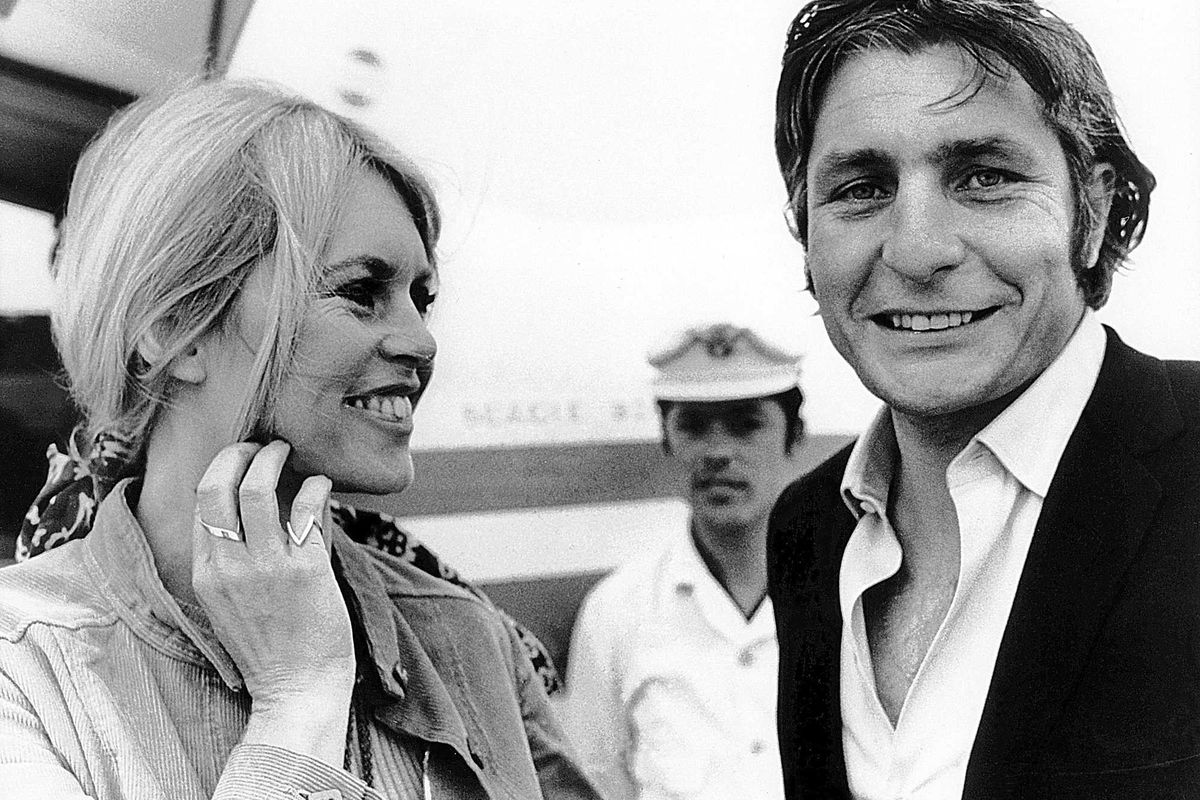- Freno alla Commissione, nuovo mandato alla Bce, immigrazione «spalmata». Il menu delle riforme è pronto e all'Ue non dispiace.
- Berlino amministra il condominio comune pro domo sua. Perciò non subirne i rigidi vincoli di bilancio è questione di sovranità .
Lo speciale contiene due articoli.
«L'Europa è affetta da zoppia»: con questa definizione il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e grande sostenitore dell'adesione al Trattato di Maastricht, nonché principale autore della confluenza della lira nell'euro, manifestava la sua insoddisfazione per la mancata trasformazione dell'Unione economica e monetaria in un'unione politica dell'Europa. […]
Il consueto atteggiamento della Germania, sorretto da quello francese, impedì di dare all'architettura istituzionale dell'Unione europea la sostanza necessaria per attuare il solenne impegno alla crescita materiale e civile del Vecchio continente. I contenuti furono dettagliatamente indicati nell'articolo 2 dell'Atto unico europeo del 1986 che diede vita nel 1992 al Trattato di Maastricht, poi ribaditi nel Trattato di Maastricht del 1992 e in quello di Lisbona del 2007 (ma all'articolo 3), dopo la bocciatura della proposta di Costituzione da parte dei francesi. La cultura della Francia e della Germania era e resta caratterizzata da una forte impronta nazionalistica secondo la quale la partecipazione all'Ue è solo un modo per meglio tutelare i loro interessi.
errore storico
Aver accettato la zoppia fu un errore storico commesso dai gruppi dirigenti, sia di quelli che hanno aderito con poca meditazione al mercato unico e agito con troppa precipitazione per entrare nell'euro sia di quelli che hanno ritenuto di partecipare a un'Europa come soluzione ai problemi interni del Paese. L'incomprensione si sarebbe dovuta dissolvere di fronte all'evidenza ma la trascuratezza continua: stavolta però con forti componenti di malafede, dato che si sa bene che le prospettive di una riforma dei trattati europei che porti fuori dalle secche l'Unione sono nulle: quella che si delinea sotto la spinta del presidente Emmanuel Macron e della cancelliera Angela Merkel rafforza la zoppia in quanto accresce i vincoli all'agire dei Paesi membri, che per noi italiani equivale a essere emarginati dal processo decisionale e conduce prima di tutto a un vero protettorato europeo e all'ulteriore decadenza dal benessere raggiunto, nonostante i solenni annunci contrari. […]
Vi sono pochi dubbi sul fatto che l'Unione europea poggi su una gamba sola, quella della stabilità, mentre manca quella della crescita economica e sociale, a causa del sospetto che quest'ultima sarebbe il veicolo dell'instabilità temuta dalla Germania. Questo Paese, che vanta indubbi meriti, si ispira tuttavia alla sua storica visione delle relazioni internazionali secondo cui si considera il «Paese d'ordine» in Europa, quello che gode di una superiorità nell'industria, che ritiene necessaria una gestione dell'euro stile marco tedesco e che il resto del mondo si debba dedicare all'agricoltura e al turismo dove può eccellere. Su queste basi ogni speranza che l'Unione europea si doti di caratteristiche istituzionali adeguate ai tempi e alle richieste dei cittadini è un'illusione, neppure se la Francia lo volesse. Piaccia o non piaccia questa è l'Europa e non si vede all'orizzonte un cambiamento che sani la zoppia. [...]
Nonostante la maggioranza degli analisti condivida ormai queste interpretazioni, si sostiene che l'Italia debba rimanere nell'euro e nel mercato comune anche a costo di una crisi irreversibile, perché se abbandonasse l'uno o l'altro scudo monetario o reale sarebbe anche peggio. A questa si contrappone una minoranza che sostiene non vi sia più nulla da fare e non resta che uscire dall'euro anche rischiando di essere banditi dal mercato comune. Un «mondo di mezzo» inascoltato insiste che occorre intraprendere la strada delle riforme europee di seguito proposte, adducendo solidi argomenti scientifici, ricercando chiarezza di esposizione e ponendo fermezza politica. Ciò non è stato ancora tentato.
In estrema sintesi queste riforme dovrebbero riguardare l'architettura istituzionale dalla quale possono discendere differenti politiche: creazione di una scuola europea di ogni ordine e grado che crei una cultura in comune senza cancellare la ricchezza di quelle nazionali; stabilire i compiti da assegnare alle istituzioni sovranazionali rispetto a quelle nazionali, con particolare riferimento alle relazioni internazionali; decidere i modi di assolvimento dei compiti fiscali da assolvere a livello sovranazionale, assegnando al Parlamento europeo e alla Commissione potere di iniziativa congiunta; attribuire alla Commissione il compito di attuare le decisioni parlamentari e di proporre le soluzioni più efficienti al Parlamento; ampliare lo Statuto della Bce assegnando a essa obiettivi di crescita sotto vincolo di stabilità e strumenti per svolgere funzioni di lender of last resort (prestatore di ultima istanza) e di intervento sui cambi e sui titoli di Stato simili a quelli delle altre grandi banche centrali di rilievo globale; stabilire le regole di burden sharing sui flussi di immigrazione.
Queste riforme rappresentano solo un passo importante sulla strada dell'Unione politica e non consentono il raggiungimento dell'unità politica, ma tracciano il sentiero per una soluzione confederale della zoppia istituzionale. Tuttavia esse sono in condizione di dare vita a creature biogiuridiche che consentirebbero di attuare politiche capaci di migliorare la crescita del benessere economico e sociale dell'Ue. Si definiscono in questo modo i tratti delle nuove politiche economiche: attuare investimenti infrastrutturali che unifichino le condizioni di ambiente economico e sociale in cui operano le imprese e vivono i cittadini europei; ricorrere anche all'emissione di eurobond e consentire alla Bce di concedere finanziamenti ponte per finanziarli; intervenire sul mercato dei cambi per controbilanciare azioni speculative o politiche di Paesi che distorcono i fondamentali della competizione europea; sistemare i debiti sovrani in eccesso al 70% in contropartita dell'accettazione di un pareggio strutturale dei bilanci pubblici e un piano di rimborso da parte dei Paesi emittenti della durata e di costo adeguati; ammettere la possibilità di avere un deficit di breve periodo in funzione della presenza di avanzi di bilancia estera corrente del Paese che li attua; obbligare i Paesi che presentano un twin surplus di bilancia corrente estera e pubblica a spendere di più per assorbirli; unificare i trattamenti fiscali per evitare il fiscal dumping.
La possibilità di raggiungere siffatti obiettivi trova conforto in un episodio personalmente vissuto e nel parere di persone vicine ai vertici europei. Nel corso di un seminario tenutosi a Bruxelles ho esposto queste idee e, al termine, un direttore della Commissione europea ha preso la parola per affermare che le mie proposte potevano anche essere discusse, ma non erano quelle che i governi italiani avanzavano, quasi del tutto incentrate su un rilassamento monetario e fiscale e richieste di assistenza per qualche settore.
Deve cioè essere impostato un dialogo su solide basi logiche, tenendo conto dei punti di vista degli interlocutori. Il parere dei vertici dell'Unione e di quelli dei principali Paesi membri è che l'Italia sia inattendibile. Vi sono fondati motivi perché lo credano, ma non è certo con visite di Stato o strette di mano che il convincimento può essere debellato. Le linee indicate possono fungere da traccia di un'agenda da discutere da parte del Parlamento e del governo di nuova costituzione, creando un apposito gruppo di elaborazione e proposta del piano da sottoporre all'approvazione degli organi della democrazia per essere portato all'esame del Parlamento europeo.
Paolo Savona
Senza liberare soldi per gli investimenti niente tagli al debito
L'architettura finanziaria dell'area euro è rimasta sostanzialmente ferma alla creazione, nel luglio 2014, del Meccanismo di risoluzione unico, nell'ambito del percorso dell'Unione bancaria iniziato nel 2012. Essenzialmente lo stallo è tra due diverse visioni. Quella di chi chiede maggiore condivisione dei rischi assieme ad una maggiore governance a livello dell'area euro e chi ritiene che i problemi dell'area euro derivino solo da cattive politiche nazionali e che quindi meccanismi più efficaci di stabilizzazione comuni siano controproducenti perché allenterebbero il rispetto delle regole fiscali e della disciplina di mercato.
Poiché su queste due visioni contrapposte si pongono rispettivamente Francia e Germania, i principali negoziatori di una possibile riforma, ciò che è allo studio sono soluzioni che tengano conto delle due preoccupazioni. Poiché tuttavia le riforme nascono sempre da compromessi, la preoccupazione italiana è quella di un compromesso che non tenga conto dei suoi problemi specifici. [...]
Il punto centrale della discussione sulla riforma dell'architettura finanziaria verte sulla relazione tra rischio bancario e rischio sui titoli del debito sovrano, e l'Italia è al centro delle preoccupazioni europee. Questo rischio è considerato, da parte soprattutto della Germania, come il principale ostacolo al completamento dell'unione bancaria e in particolare all'approvazione di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi. I termini della questione sono noti. Quando le banche hanno un portafoglio di titoli dei debiti sovrani dello stesso Stato di appartenenza che rappresenta una quota elevata del totale, le banche risentono del rischio di default degli Stati. Ciò implica che un meccanismo comune di riassicurazione bancaria, e la previsione di un possibile bail-out con l'intervento delle istituzioni europee, significherebbe implicitamente porre i debiti dei singoli Stati sono l'assicurazione europea sui depositi. La conseguenza sarebbe un rallentamento della disciplina di bilancio, poiché i singoli Stati possono far acquistare il proprio debito dalle banche nazionali e poi porlo sotto garanzia europea tramite gli istituti di salvaguardia dell'Unione bancaria. […]
Il nodo sembra essere quello della capacità della Germania di non guardare alle riforme europee solo attraverso la lente dei suoi effetti distributivi, in preda al timore che una riforma del bilancio comunitario, l'adozione di un sistema di assicurazione della disoccupazione o un sistema di assicurazione dei depositi bancari possa implicare trasferimenti dai tax-payers o dai risparmiatori tedeschi a favore dei cittadini francesi, spagnoli o italiani. Questi timori sono legittimi, ma fino ad oggi hanno poco fondamento. Il contributo al bilancio comunitario della Germania in percentuale del suo Pil non è superiore a quello degli altri Paesi, il sistema del Meccanismo di stabilità europeo in caso di perdite distribuirebbe il peso su tutti i contribuenti e il sistema Target 2 essenzialmente garantisce tutti coloro che esportano in Paesi a rischio che i loro crediti saranno sempre onorati.
Ciò che preoccupa non è questa attenzione ad evitare una unione dei trasferimenti, ma il fatto che questo terrore ancora impedisca di porsi di fronte alle riforme dell'Unione monetaria europea e della Ue partendo dal punto di vista della loro funzionalità rispetto alle sfide strategiche che motivano la stessa adesione all'Unione. In altri termini, la domanda è se si tratta solo di correggere alcuni malfunzionamenti guardando ai problemi che si sono rivelati nel passato, con al centro i problemi di crisi dei debiti sovrani, di instabilità finanziaria e difficoltà di convergenza delle economie al suo interno, o si tratta di riconoscere che il contesto globale in cui opera oggi l'Europa è cambiato rispetto a quando la costruzione europea è stata concepita e poi progressivamente realizzata.
È evidente dal dibattito in corso che è ancora prevalente nelle discussioni europee quella che abbiamo chiamato l'ossessione tedesca, ossessione che può portare a scelte orientate prevalentemente alla limitazione del rischio che si traducono in penalizzazioni per Paesi come l'Italia ma che sono anche potenzialmente catastrofiche per il futuro dell'Europa.
La risposta non può essere, tuttavia, il non riconoscimento dei problemi e il gioco difensivo alla ricerca della condivisione del rischio. Deve cambiare l'alternativa, ponendo la limitazione del rischio come un compito immediato, nazionale ed europeo, e questo significa indicare un piano percorribile e credibile di riduzione e ristrutturazione dei debiti. L'Italia in particolare non dovrebbe sedersi al tavolo negoziale senza un piano specifico sul debito italiano da contrattare in Europa in cambio, tuttavia, di impegni sul bilancio europeo in grado di mobilitare risorse per far fronte alle sfide sul tappeto. Si tratta di predisporre un piano massiccio di investimenti pubblici concordato a livello europeo e di dimensioni tali da contrastare nel breve termine una nuova fase di deflazione europea e soprattutto in grado di evitare nel medio-lungo termine di porre l'Europa al di fuori della competizione tecnologica, scientifica ed economica globale.
Non si tratta di una strada «sovranista» ma il suo contrario. Una strada che può essere accettata anche dalla Germania in cambio di un progresso verso l'Unione fiscale e politica europea, che deve essere vissuta non in chiave di controllo della disciplina condominiale, ma in chiave di affermazione di una sovranità sovranazionale in grado di scelte chiare nell'interesse comune europeo. La prospettiva peggiore è quella di continuare ad affidarsi a regole automatiche sotto la vigilanza di istituzioni senza discrezionalità o organismi tecnici, regole e istituzioni che producono politiche che, anche quando si rivelano inadeguate o dannose, solo dopo eventuali diffusi danni possono essere faticosamente cambiate adattate alle circostanze. Il «sovranismo» trova spazio quando manca una sovranità politica sovranazionale.
Giovanni Tria