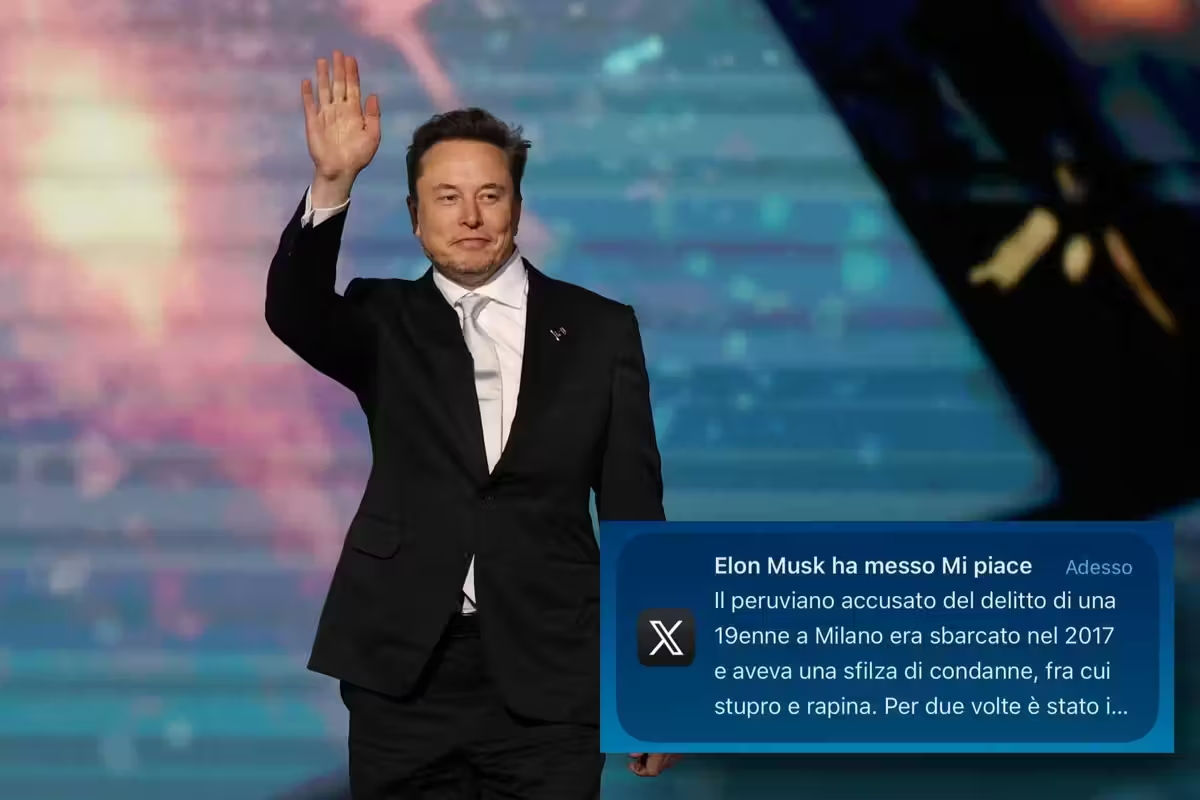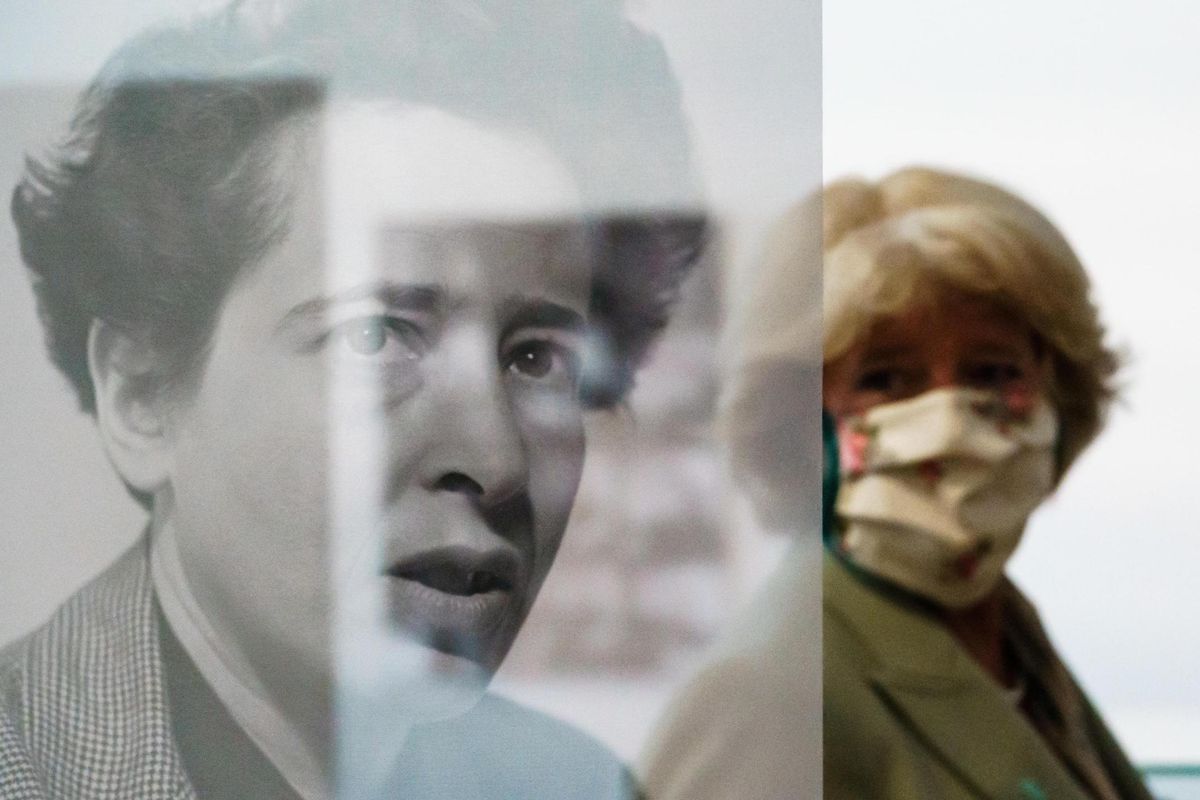
Tempi duri, non c'è dubbio. Eppure sorprendentemente interessanti anche per chi si trova a scriverne, o ad ascoltare cosa ne dicono le persone in psicoterapia (per fortuna sempre meno appassionate al presunto complesso d'Edipo che furoreggiò nel secolo scorso, o alla «minaccia fascista sempre incombente»). Interessa e dà sollievo l'ormai evidente «crisi delle chiacchiere», dopo tutto il parlare senza dire nulla degli ultimi anni, il gesticolare vanesio, il non concludere mai niente, mentre c'erano decisioni che aspettavano, creditori che premevano, urgenze che marcivano. Una situazione tossica come se ne ricordano poche, che (non solo a causa dei micidiali lockdown) ha gettato in depressione un popolo intero. Fino a spingere in questi giorni al suicidio uno dei più esperti e controllati alti funzionari dello Stato, persone che anche per formazione professionale nulla può scalfire o scuotere.
Il fatto è che non c'è niente di più triste e sconfortante del vedere chi dovrebbe tutelare il benessere degli altri e invece ci gioca, si pavoneggia e lo usa pensando soltanto al proprio interesse. Da questo punto di vista l'ultimo anno, con le intercettazioni delle conversazioni tra magistrati, o i documenti del retrobottega della gestione della pandemia (e tantissimi altri fatti e documenti) ha fornito un materiale antropologico di prim'ordine per capire i miasmi che rischiano di soffocare l'anima italica, con le sue tradizionali virtù di coraggio e generosità. Riconoscere tutto ciò è amaro, ma tuttavia indispensabile per uscire dai guai.
Ricostruire l'unità del Paese (della quale lo Sguardo si è occupato la scorsa settimana, suscitando accesi commenti), può avvenire solo su un piano di verità. Coprire l'orrore del malfatto e indorare la pillola, come la vecchia politica sempre fece e ancora vorrebbe fare per restare in sella, non è più possibile senza mettere a rischio ogni possibilità di cambiamento e di salvezza. Occorre ora dire le cose come davvero stanno: malissimo. Oggi è ormai finalmente possibile dirlo proprio perché siamo sull'orlo di una crisi economica straordinariamente grave, dove «fame» non è più un modo di dire, ma una condizione che riguarda un numero sempre maggiore di persone come lo stesso premier Mario Draghi ha ricordato. E la fame, a differenza delle parole vuote e dei presidenti con fazzolettino iperpiegato, come ogni verità forte porta dritto alla verità.
Anche la Ricostruzione del dopoguerra, fu aiutata e resa possibile dalla fame. Anche lì c'erano i partiti con i loro diversi problemi cosmetici e anche giudiziari, più o meno gravi (molti gravissimi, come poi raccontarono ad esempio i libri di Giampaolo Pansa sul Sangue dei vinti). Ma anche lì la fame era a un passo, e rimetteva le faide al loro posto, secondario rispetto alla vita e al lavoro indispensabile per mantenerla. Non c'è fattore più obbligatoriamente unificante della fame. Anche noi oggi siamo lì, a un passo. Posizione scomoda, ma che ha un punto di forza. «In quanto noi tutti abbiamo bisogno di pane», nota la filosofa Hannah Arendt in Sulla rivoluzione, «siamo già in realtà un'unica cosa, e possiamo benissimo unirci in un solo corpo». Non c'è aspetto che riunisca di più del rischio di non sopravvivenza fisica di un popolo, di una nazione (già gravemente attaccata dal punto di vista sanitario dal Covid 19).
Per questo, seppur con grande ritardo rispetto alla necessità, è stato chiamato Draghi: perché l'Italia era (è) un Paese sull'orlo della bancarotta, dove i politici invece di mettere a posto i conti continuavano a discutere del comprare, coi soldi del contribuente, banche, autostrade, e compagnie aeree, una per partito al governo, come da tradizione. Solo l'arrivo di Draghi ha permesso, dopo pochi giorni, a stampa e a politici di prima fila di scoprire che l'Italia e le forze politiche fino a ieri al governo non avevano nessun piano industriale, andavano avanti più o meno a seconda degli impulsi delle varie clientele. Tutto ciò in un momento in cui, inoltre, la politica dello sviluppo, quella della sanità, e quella dell'educazione si intersecano inesorabilmente (come in tutto il mondo), perché proprio la mancanza di un'accurata e informata programmazione industriale è tra le prime cause della pandemia.
Sguardo selvatico ha riportato più volte gli studi internazionali (come quelli dell'Agenzia europea per l'ambiente) sulle morti premature in Italia attribuibili ai particolati, all'ozono e agli ossidi d'azoto (NO2): nel solo 2016 sono state 60.666 persone, di cui oltre 18.000 nella pianura padana e zone limitrofe. Il successivo dibattito sulla pandemia ha però accuratamente evitato di collegare i due fenomeni, le morti per agenti atmosferici tossici e la mancanza di una politica industriale; che Draghi ha invece subito evidenziato fin dai suoi primi interventi. Poi, certo, non c'è bisogno di essere un drago (come lui comunque è) per capire il fenomeno. Se metti una accanto all'altra le cartine geografiche europee con evidenziate in rosso le zone della più alta mortalità per agenti atmosferici inquinanti e quelle della più altra mortalità per Covid 19, vedi che sono le stesse. I giornali inglesi, del resto, riportarono la questione e le cartine (con pianura padana in bella mostra) fin dai primi casi a Codogno. I nostri no. I nostri politici avevano altre urgenti battaglie: dovevano occuparsi dell'odio fascista, o del decreto Zan, o altre non rinviabili emergenze.
Ora, di fronte al rischio della morte per fame, e a un presidente sufficientemente forte e competente da osare dichiararlo, è possibile e doveroso creare un'unità nazionale che eviti il disastro. La questione è vitale per lo stesso mantenimento della democrazia. Su questo aspetto Arendt, filosofa certamente tutt'altro che reazionaria, è stata molto chiara: prima di tutto va evitata la fame: «La libertà può essere perseguita soltanto da coloro che non hanno fame». Chi ha fame, infatti, non è libero; prima deve svincolarsi dal bisogno. L'errore più grande, secondo Arendt, è dunque quello di perdere tempo e energie preziose per inseguire il mito di stati sociali che poi finiscono sempre con sfociare in strutture autoritarie o dittatoriali, come appunto la Rivoluzione francese da lei studiata, o dal nazismo cui sfuggì.
Mettere i conti a posto e garantire uno sviluppo sano, e quindi un'idonea educazione delle nuove generazioni, che le mantenga nei prossimi decenni: questa è la cosa più umanamente e socialmente produttiva che la politica possa oggi fare. Speriamo che il nuovo governo e chi è interessato al bene dell'Italia ci riescano. Come già insegnava Pitagora, nulla più dei numeri mette in fuga le chiacchiere.