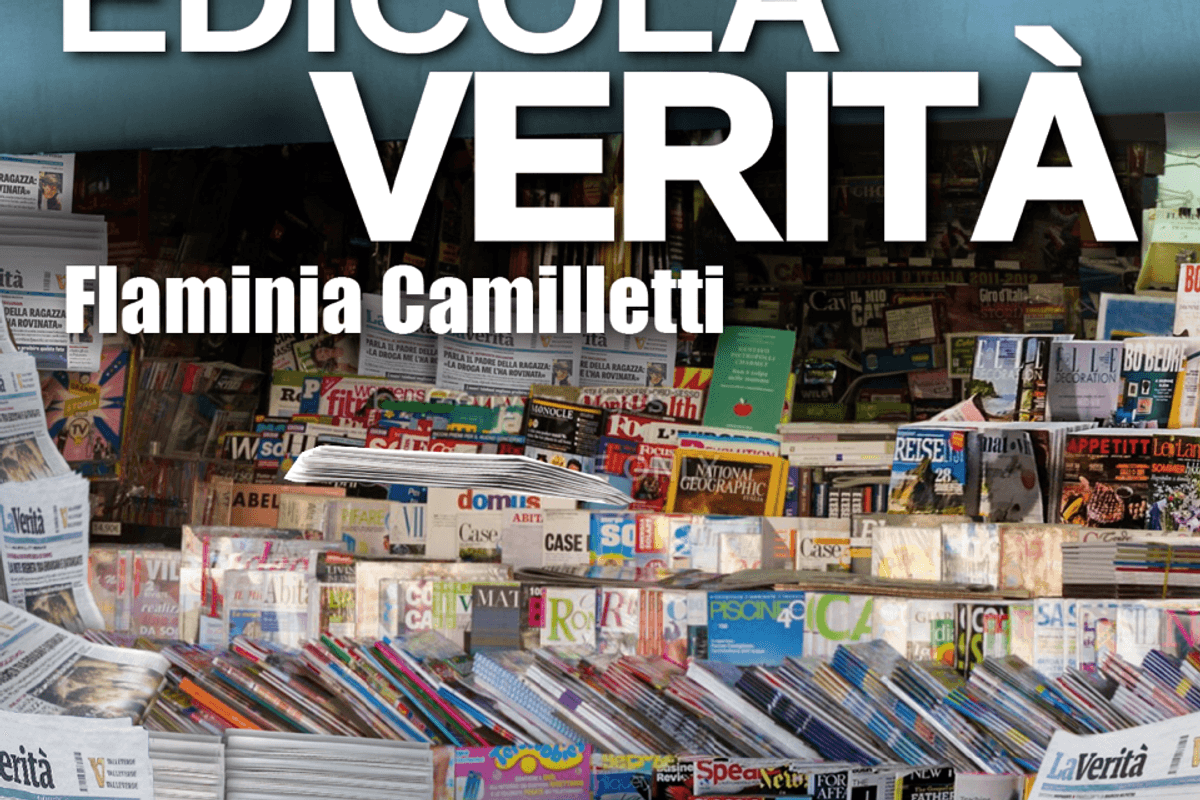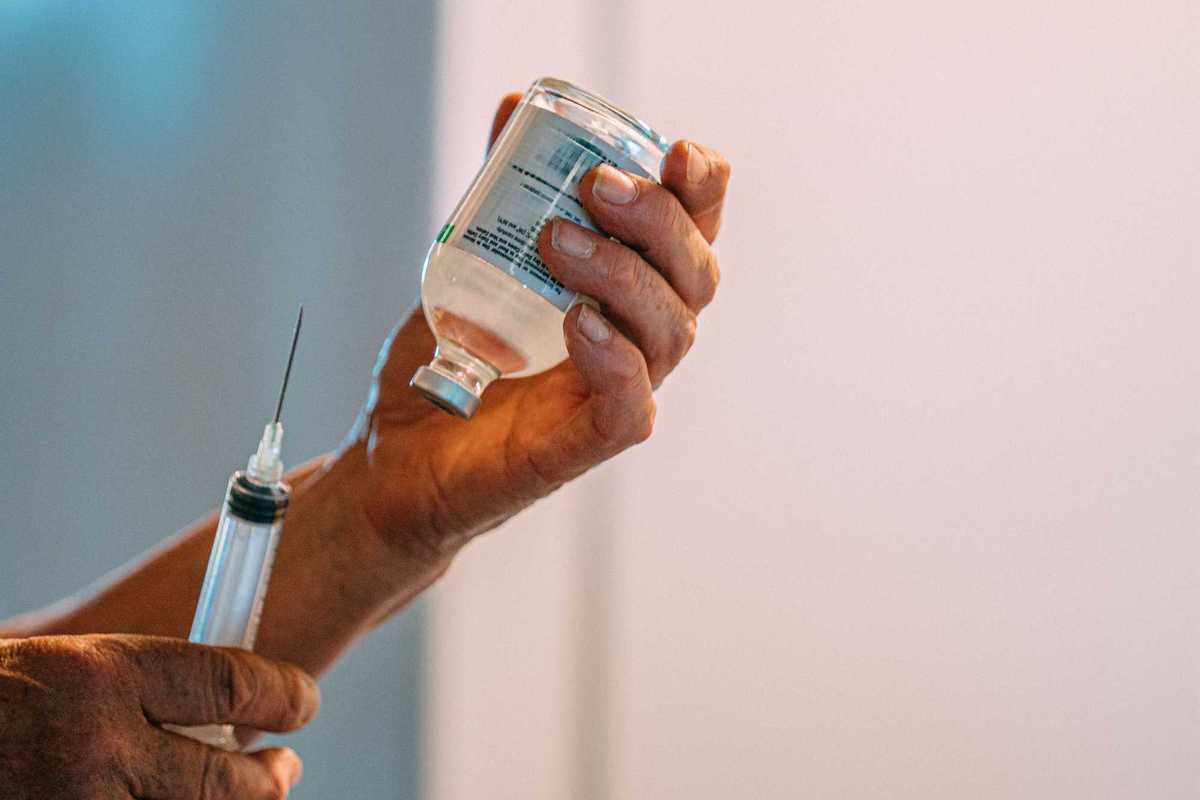Jay Gatsby: l'icona dell'età del jazz, il decennio che precedette la Grande depressione, quello della «generazione perduta», il cui esponente più emblematico fu Francis Scott Fitzgerald. Geniale nell'affabulare la biografia di un gangster ebreo, Arnold Rothstein, ne ricavò il suo idolo solitario e schivo, l'uomo che per fare colpo su una donna dà delle feste sibaritiche in una tenuta di Long Island acquistata espressamente per tale scopo. Chi è lei? Daisy, una giovane che come tutti i suoi coetanei crede di vivere in un'era dorata che non avrà mai fine, esorcizzati dall'edonismo fatuo gli incubi delle trincee francesi, dove molti coetanei perirono in cerca di gloria o restarono mutilati durante la Grande guerra. Mentre incombe un conflitto che sarà ancora più orribile e finirà con il doppio fungo atomico di Hiroshima e Nagasaki. La dedizione di Gatsby a Daisy è priva di compromessi: «Sapeva che baciando quella ragazza, e unendo per sempre quelle indicibili visioni al mortale respiro di lei, la sua mente non avrebbe più spaziato come quella di Dio».
A narrare è Nick Carraway, cugino di Daisy e testimone del suo amore impossibile con l'ex contrabbandiere di alcol divenuto Il grande Gatsby. I diritti del romanzo scadono il 31 dicembre di quest'anno, al che la storica casa editrice newyorkese Little, Brown & Co. ne annuncia il prequel, scritto da Michael Farris Smith, collaudato autore di best-seller, che firma Nick. Sì, il protagonista sarà colui al quale Fitzgerald aveva affidato il compito di raccontare la tragica progressione dell'idillio tra Gatsby e Daisy. Lo si vedrà attonito dinanzi agli orrori del fronte europeo del 1914/1919, per lasciarsi poi avvincere dall'incanto della Parigi post-bellica, fino alle delizie di New Orleans e di là ai sobborghi di New York, vicino casuale di Gatsby, con la prospettiva dei trent'anni dinanzi a lui. Uno status anagrafico imparagonabile a quello dei «bamboccioni» o degli «sdraiati» di oggi.
Ma perché invadere il campo creativo di originali che nacquero ciascuno per essere un unicum? È successo per Via col vento, per Rebecca la prima moglie. Si sono fatti resuscitare miss Marple e Poirot. Quest'ultimo nell'ennesima serie televisiva iconoclasta, dove John Malkovich somiglia quasi a Hannibal Lecter. Non basta. L'americano Roger N. Morris ha rimesso in azione nientemeno che il giudice Porfirij, il magistrato implacabile che incastra Raskolnikov in Delitto e castigo. L'apocrifo non è più un divertissement, bensì un business. Nel caso di Fitzgerald, si rivada alla filologia dello scrittore e del suo universo non soltanto letterario. Diversamente dai suoi contemporanei Faulkner, Hemingway, Saroyan, Steinbeck ed altri, non si lasciò risucchiare dal fascino dell'idealismo che si fa ideologia. Ossia il percorso che aveva avvilito la vena di Jack London. Fitzgerald perseguiva un sogno romantico destinato in partenza, come per Majiakovskij, ad infrangersi contro «la barca della quotidianità». Il risvolto dei party, percorsi da fiumi di alcol, che lui traspone nei ricevimenti di Gatsby, le vacanze sulla Costa Azzurra, il ritmo incalzante della nuova musica, precipitano nell'abisso della lacerazione interiore, della sofferenza, della follia di Zelda, sua moglie, che lui ripropone in un altro sui capolavoro, Tenera è la notte. Solo che Fitzgerald non cerca appigli politici, alla pari degli altri, tutti antesignani della vena radical-chic. Sconta il desiderio di sublime sulla propria pelle fino a morire d'infarto il 21 dicembre 1940.
Allora perché speculare sul pregresso del grande Gatsby?
Inevitabilmente, si pensa a Walter Bejamin e all'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Ai giorni nostri si configura una «pixellizzazione universale». Il segno dell'arte si decompone nei bit di cui consistono ormai tutti i linguaggi comunicativi.
Certo, Jorge Luís Borges dimostra con Pierre Menard autore del Chisciotte che ogni scrittura è riscrittura. Lo stesso Cervantes aveva riprodotto fuori tempo un romanzo cavalleresco. Guido Fink e Guido Almansi certificarono il processo in Quasi come: la letteratura parte dal preesistente. Sostenevano nell'introduzione: «Leggi assurde, come il Copyright Act del 1709, pretendevano di punire il plagio e di costringere gli autori a dire quello che avevano da dire e basta senza ricorrere a furti e rapine nel territorio della tradizione letteraria: leggi ingenue, che ignorano il fatto che la letteratura è tutta un furto e tutta una rapina. I testi sono sistemazioni provvisorie, tende da nomadi che si spostano da un luogo all'altro nel deserto, e i falsari sperimentali sono i beduini che assicurano la circolazione delle idee».
Bertolt Brecht dichiarò: «Shakespeare? Un grande ladro come me». Ammetteva che anche il suo teatro militante non su basava su invenzioni.
Né Borges né Brecht, però, sapevano che questo gioco di rimandi creativi sarebbe stato fatto rientrare nel piano di destrutturazione della società, per ridurre anche l'arte allo stato liquido.