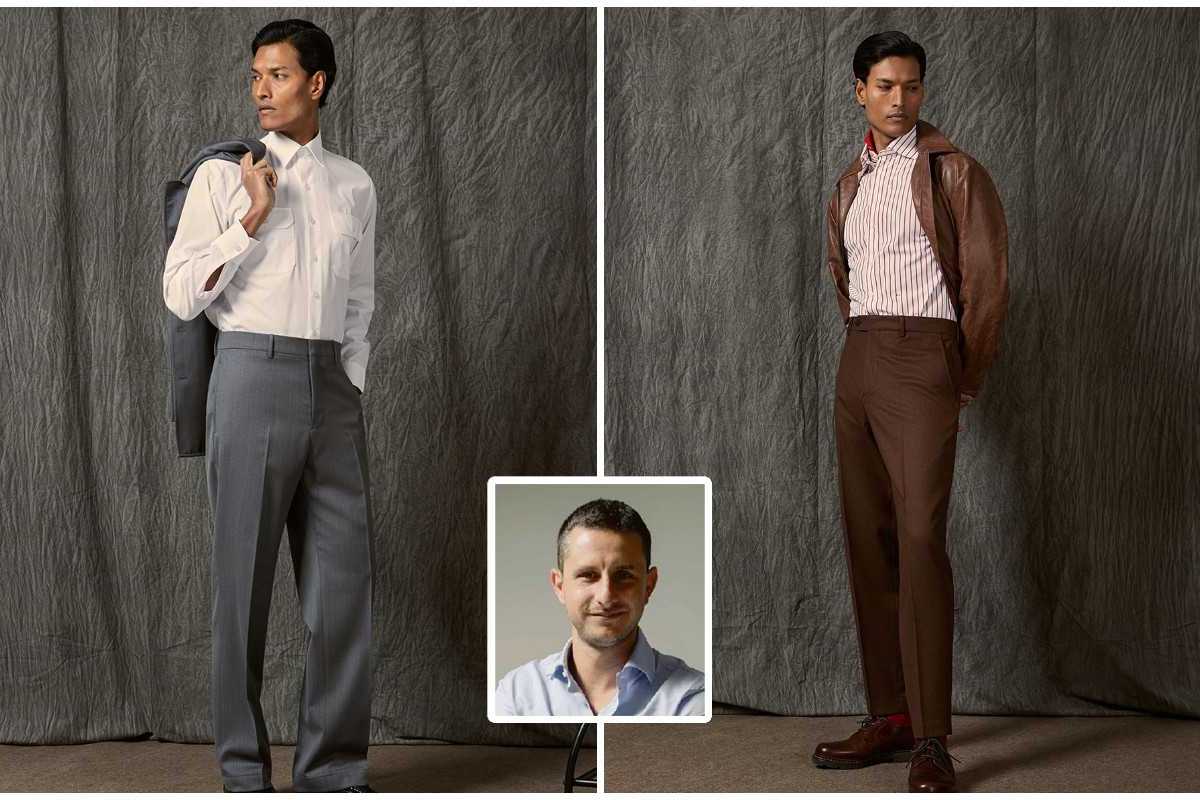C’è un’eredità scomoda che la dinastia degli Agnelli-Elkann ha lasciato in dote alla nuova Stellantis, il gruppo nato dalle nozze tra Fca e la francese Psa e che ha compiuto in questi giorni il primo anno di vita. È un lascito pesante che vale in negativo ben 2,44 miliardi di euro. Sono le perdite maturate nel corso del 2020 dalla Fca Italy, di fatto le attività della vecchia Fiat auto nell’area Emea, cioè l’Europa allargata. Quel bilancio pre-fusione è l’ultima dote, non certo gradita, portata in grembo a Stellantis e chiude l’avventura della Fiat auto di antica memoria.
Certo Stellantis, che ha chiuso il primo anno di attività con risultati record (150 miliardi di ricavi e oltre 13 miliardi di profitti netti), ha le spalle talmente grandi da assorbire del tutto l’impatto negativo delle attività in Europa dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e così via. Ma ovviamente resta sul tappeto delle nuove strategie del quarto produttore di auto nel mondo la zavorra dei passivi della vecchia Fiat auto. Si dirà che il buco da oltre 2 miliardi, trasmigrato in casa Stellantis, è figlio dell’anno drammatico del Covid. In buona parte vero, dato che Fca Italy nel suo complesso ha visto un calo delle consegne di auto di ben 242.000 unità in soli 12 mesi portando le vetture vendute nel 2000 a poco più di 1,1 milioni.
Ma il «rosso» profondo» dell’ultimo addio non è un caso isolato e il Covid ha solo accelerato una striscia negativa che dura da anni. Nel 2019 le perdite di Fca Italy furono di 380 milioni, ma con un margine pre tax negativo per 900 milioni. E prima non è mai andata bene. Dal 2015 al 2018 il passivo cumulato nell’ultima riga di bilancio è stato di oltre 4,5 miliardi, dato che porta il conto salato delle perdite, con quelle degli ultimi anni, a superare quota 7 miliardi. Segno che da anni le attività della vecchia Fiat auto lavorano con costi (cui si sommano svalutazioni di asset) che superano costantemente i ricavi. Ricavi tra l’altro saliti negli anni. Nel 2014 Fca Italy ha prodotto fatturato per 19 miliardi, saliti a 24 miliardi nel 2019 e poi caduti (effetto pandemia) a 20 miliardi pre fusione. Ma i costi mandano da sempre in rosso il margine lordo e poi ci si mettono le svalutazioni ad approfondire il quadro negativo. Solo nel 2020 Fca Italy ha svalutato le sue partecipazioni, tra stabilimenti industriali e attività commerciali, per 680 milioni. E così, perdite su perdite, la vecchia Fiat auto resta, prima con Sergio Marchionne, e ora con Carlos Tavares, il bubbone aperto del gruppo. Gruppo che con la controllante Fca nv ha dovuto continuare a ripianare le perdite con versamenti in conto capitale per oltre 8 miliardi, l’ultimo nel 2016 per 3,5 miliardi.
E non è un caso che l’amministratore delegato di Stellantis, il portoghese targato Peugeot Tavares, abbia in almeno due occasioni puntato il dito sulle performance degli impianti europei, in particolare quelli italiani, segnalando come «i costi di produzione negli impianti in Italia sono significativamente più alti per unità assemblata, a volte il doppio, rispetto alle fabbriche di altri Paesi europei, nonostante un costo del lavoro più basso». Affermazioni lapidarie e che non possono che alludere a interventi pesanti di ristrutturazione in Italia. E sul punto del costo del lavoro Tavares ha pienamente ragione. Guardando il bilancio di Fca Italy si scopre che il costo del lavoro non è certo il problema. Nel 2019 le retribuzioni lorde hanno pesato per soli 1,6 miliardi su 24 miliardi di fatturato, poco meno del 7%. Nel 2020 il peso del costo del lavoro sui ricavi (scesi) è salito a solo il 7,5%. Il problema evidentemente è altrove. Costi dell’energia e di altri fattori produttivi incidono senz’altro di più rispetto a Paesi come la Serbia e la Polonia. E poi c’è un tema di gamma di modelli, dove la leva del prezzo è difficile da usare. Non solo ma, come documenta uno studio della Fim Cisl, in Italia i volumi produttivi continuano a flettere. Tra il 2017 e il 2021 la produzione di veicoli sarebbe crollata del 33%. Una sorta di lenta consunzione.
Alla fine emerge sempre più e con forza che il vero capolavoro prodotto da Marchionne, e che ha salvato gli Agnelli dalla débâcle, è stata la conquista di Chrysler. Gli Usa hanno portato in dote un mercato ricco che grazie a vendite e margini più che, doppi rispetto alla vecchia Fiat, hanno risollevato il gruppo da una annosa china discendente. L’altro miracolo finanziario è la fusione con Psa. Ai francesi si è aperto il mercato Usa dove erano poco presenti, agli Agnelli i francesi hanno portato in dote un mercato europeo con marchi e modelli a maggiore redditività.
Certo il buco cronico delle attività della vecchia Fiat auto è la sfida che attende Tavares, il ristrutturatore famoso per aver riportato a galla il marchio Opel dissestato. Lui ha già messo più volte le mani avanti. E pur dall’alto di un bilancio che gronda profitti come mai nella storia dei due gruppi presi singolarmente, andrà dritto per la sua strada. Vista così appare un paradosso ma mentre Stellantis sfornava a livello globale oltre 13 miliardi di utili netti, in Italia la cassa integrazione in molti impianti continua a dettare legge. E nei giorni scorsi anche Melfi si è fermata per la mancanza di micro-chip. Chissà cosa tirerà fuori dal cilindro il manager portoghese per risollevare le sorti di quell’angolo di business che gli dà molti grattacapi. Per ora poco si sa. Di certo c’è un piano industriale (addirittura decennale) che promette fuochi d’artificio. Con ricavi raddoppiati a 300 miliardi al 2030 e margini operativi sopra il 10% per tutta la durata del piano e con l’Europa a recuperare quasi del tutto il gap di profittabilità industriale rispetto agli Usa. Che ruolo avrà la vecchia Fca Italy in questo nuovo miracolo economico, non è dato sapersi. Per ora.