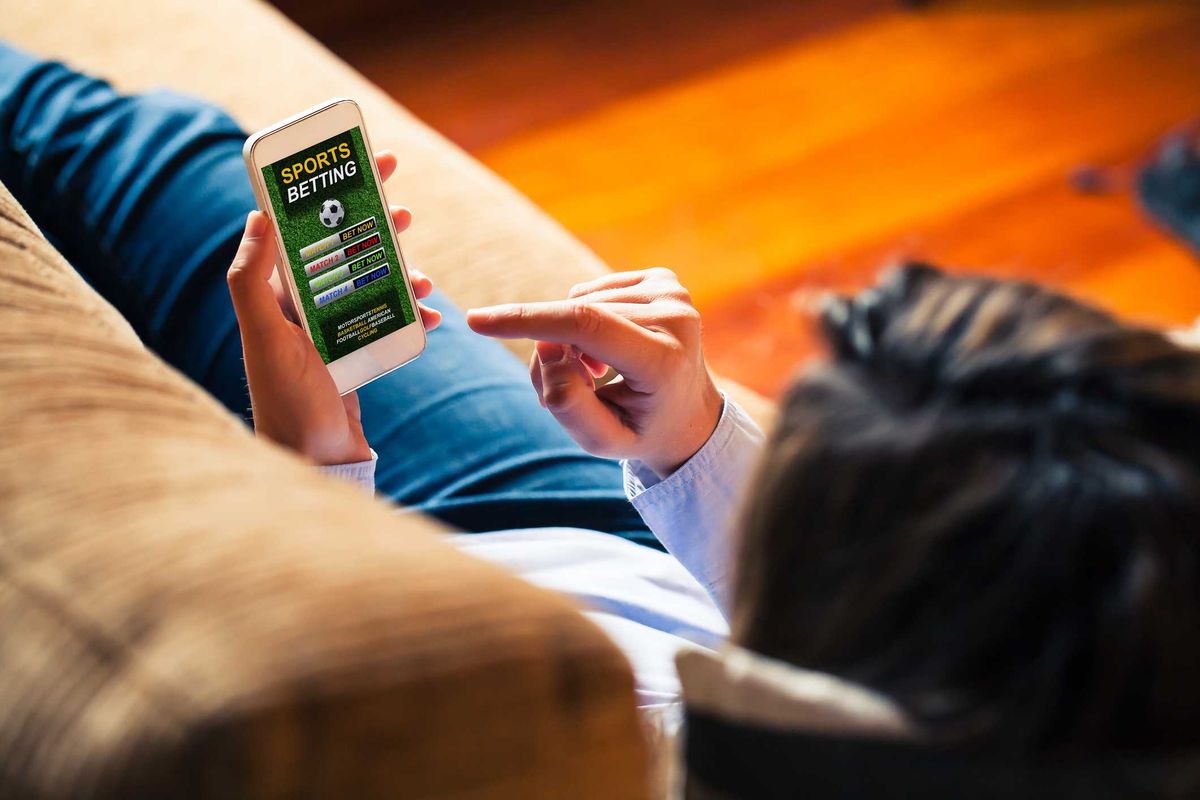Nel loro ultimo libro-dialogo, la vicepresidente della Corte costituzionale e l'ex capo della Commissione antimafia reinterpretano il ruolo dei magistrati supremi. Che dovrebbero riempire i vuoti normativi.Quando, qualche mese fa, avevamo commentato un editoriale della vicepresidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, apparso sull'Italian Journal of Public Law, muovendo critiche puntuali ad alcuni dei passaggi del testo, l'ufficio stampa della Consulta ci aveva accusato di aver «gettato discredito» sull'istituzione e di aver travisato gravemente l'analisi della vicepresidente. Non pretendiamo di essere infallibili: quanto scritto sulla Verità poteva essere davvero il frutto di un fraintendimento. Potremmo aver capito male, rimanendo, è ovvio, sempre in buona fede. Fatto sta che ci è sembrato di ritrovare alcuni degli argomenti oggetto delle nostre obiezioni anche in un'altra opera della professoressa Cartabia, un saggio scritto a quattro mani con Luciano Violante dal titolo Giustizia e mito, recentemente edito dal Mulino. Un libro che parte dall'analisi di famose tragedie greche come l'Edipo re e l'Antigone, per poi sviluppare temi di teoria del diritto e analizzare l'evoluzione recente delle principali istituzioni giuridiche. In questo caso, in effetti, i nostri dubbi si sono moltiplicati, anche perché in questo dialogo con l'ex presidente della Commissione antimafia, le pur sensibili differenze tra i due luminari paiono affievolirsi quando si arriva ai nodi che avevamo affrontato nei nostri precedenti articoli.Alcune affermazioni di Violante, ad esempio, confermano che il nostro quotidiano si era soffermato correttamente su uno dei punti sui quali i grandi esponenti della scienza giuridica italiana si stanno interrogando: il tema dell'«autoinvestitura» dei giudici costituzionali quali decisori ultimi non tanto e non solo nel processo di verifica della conformità delle leggi con la Costituzione, quanto nell'attività legislativa vera e propria. Scrive Violante: «Il processo costituzionale, quello che riguarda la conformità di una legge ai principi superiori dell'ordinamento, nasce nella sua completezza non per investitura di un Parlamento, ma per autoattribuzione». Dopodiché, l'ex magistrato tira fuori proprio il paragone con la Corte suprema americana, che sulla Verità avevamo indicato quale esempio da non imitare: «Nel 1803, la Corte suprema degli Stati Uniti nella sentenza Marbury versus Madison si autoattribuì il potere di giudicare della costituzionalità delle leggi approvate dal Congresso. Nel 1956 toccò alla Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 1, liquidare in undici brevi righe la pretesa del governo dell'epoca che voleva confinare la sua competenza solo alle leggi successive alla sua istituzione». Una tesi che occulta le sostanziali differenze tra il caso italiano e quello statunitense, che si auspica siano riconosciute in primo luogo proprio dai giudici.È vero, infatti, che in America, con una sorta di colpo di mano, la Corte suprema si arrogò la facoltà di determinare la compatibilità degli atti del Congresso con la Costituzione (la cosiddetta judicial review), facoltà che il dettato costituzionale stesso non le aveva mai conferito. Ma la natura sostanzialmente politica del collegio dei magistrati, che come noto sono soggetti a un periodico rimpasto che procede quasi parallelamente con la naturale alternanza democratica all'interno del Congresso e alla Casa Bianca, assicura un controllo democratico - sia pure indiretto - sulle sue decisioni. La contropartita, ovviamente, è una profonda politicizzazione della giustizia, come hanno dimostrato certe recenti sentenze sul matrimonio gay o sul muslim ban di Donald Trump (che ha poi provveduto a nominare il «suo» giudice, Brett Kavanaugh).In Italia, la Corte costituzionale ha piuttosto l'impostazione, di stampo kelseniano, dell'organismo indipendente dai decisori politici e dal gioco democratico. Il suo compito è esattamente quello di proteggere la legge fondamentale dai capricci delle maggioranze legislatrici, che come la Storia europea ha tragicamente insegnato, possono utilizzare la propria forza e il proprio consenso anche per perpetrare gravi abusi. Ragion per cui, tra l'altro, la Costituzione italiana si caratterizza per una rigidità ben più marcata rispetto a quella della carta costituzionale americana (la cui flessibilità, anzi, è stata il viatico di diversi emendamenti migliorativi, incluso quello contro la schiavitù). Indipendenza dalla politica, però, non significa autocefalia: la magistratura non può essere un potere autoreferenziale con ambizioni da legislatore. Fin qui, comunque, le obiezioni alla tesi di Violante. Anche nei brani della Cartabia, però, troviamo argomentazioni che lasciano perplessi.Giustamente, la vicepresidente della Consulta ricorda che «le corti non possono governare l'agenda delle loro decisioni e non possono procrastinare o evitare la decisione. Se una controversia è portata alla loro attenzione, esse devono decidere anche in assenza di una specifica legislazione di riferimento». Una circostanza che acquisisce un significato particolare se le controversie portate all'attenzione delle corti riguardano temi eticamente sensibili, dal fine vita, alla maternità surrogata, all'affidamento dei bambini delle coppie omosessuali, come è successo molte volte negli ultimi anni. Il punto è che i magistrati hanno spesso assunto decisioni che almeno l'opinione pubblica più conservatrice (o dovremmo definirla di buon senso?) ha considerato inopinatamente innovative. Per farla breve, in certi casi, alcuni dei quali molto dibattuti anche sui media, i giudici hanno operato scelte che sembravano contraddire l'impostazione della nostra Costituzione e della nostra legislazione esistente, imprimendo da un lato una svolta «progressista» alla pratica giuridica e dall'altro non esimendosi dall'esortare il Parlamento a colmare i cosiddetti «vuoti legislativi» (un invito di per sé opinabile: non è mica detto, e le coscienze liberali su questo dovrebbero convenire con i cattolici, che lo Stato debba legiferare su tutto). Si tratta di un problema che alla professoressa Cartabia dovrebbe stare particolarmente a cuore, vista la sua formazione e la sua identità culturale. In fondo, anche se a volerla all'alta corte fu Giorgio Napolitano, la sua nomina fu accompagnata dalle proteste delle associazioni lgbt, che la definirono «una ciellina omofoba».Eppure, ecco come, di fronte alla complessità della dialettica tra le prerogative dei magistrati e la necessità di arrivare a delle sentenze sia pure in assenza di un preciso riferimento legislativo, la Cartabia inquadra il compito delle corti costituzionali: «Esse svolgono a un tempo una funzione di garanzia - custodi dei valori costituzionali, stabili e duraturi - e una funzione dinamizzante dell'ordinamento attraverso l'interpretazione sempre nuova dei principi costituzionali, a contatto con l'evoluzione sociale e le esigenze del caso specifico sottoposto al loro giudizio».Ma allora qual è il punto di equilibrio tra la «custodia» e la «dinamizzazione»? Non sarà che, quando ci si vuole sintonizzare con «l'evoluzione sociale», arrivando fino a una «interpretazione sempre nuova dei principi costituzionali», quei principi si finisce per stravolgerli? Come sa bene chi studia il concetto di tradizione, è tanto facile innovare (o sconvolgere), quanto lo è fingere che in quel modo si stia conservando il traditum. Qualcuno, Oltreoceano, lo affermò in modo esplicito: in una celebre lettera del 6 settembre 1789, indirizzata a quello che di lì a pochi anni sarebbe diventato il quarto presidente Usa, James Madison, il founding father Thomas Jefferson scrisse che «la Terra appartiene in usufrutto ai vivi». Ossia che i viventi hanno il diritto di disporre come vogliono dell'eredità spirituale, culturale, politica e giuridica delle generazioni passate.Così, se in Italia, con la legge Cirinnà, è stato possibile includere nelle «formazioni sociali» tutelate dall'articolo 2 della Costituzione anche le unioni omosessuali, cosa ci assicura che, nello svolgere la sua funzione «dinamizzante», un giorno la Corte costituzionale non arrivi a stabilire che le famiglie arcobaleno sono in tutto e per tutto identiche a quelle fondate sul matrimonio - che, insomma, sono stati i padri costituenti a sbagliarsi, adottando una visione troppo limitata od oscurantista?Checché se ne dica sui potenziali fraintendimenti, ci sembra legittimo esprimere preoccupazioni sull'enormità della responsabilità che verrebbe affidata a giudici chiamati a innescare un processo di aggiornamento forzoso del diritto. Tanto più in un Paese come il nostro, in cui le porte scorrevoli tra magistratura e politica rendono i due organismi spesso permeabili, e non sempre perché è stato il corpo elettorale a esprimersi: curiosamente, prima dello stallo su Paolo Savona e dell'incarico a Carlo Cottarelli, il nome della Cartabia era saltato fuori come quello di una papabile presidente del Consiglio quando era sul tavolo l'ipotesi di un «governissimo» del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.I nostri dubbi vengono accresciuti da un altro punto del ragionamento della Cartabia, la quale, riferendosi alla difficoltà, nelle società contemporanee multiculturali, di risolvere in via di principio conflitti tra valori e visioni del mondo radicalmente differenti (questione che ha animato a lungo le diatribe filosofiche dei pensatori contemporanei, da Liberalismo politico di John Rawls in poi), allude alla possibilità di un «accomodamento nella pratica» da perseguire «situazione per situazione». Resta allora da capire dove sia il confine tra l'accoglimento dell'invito a «reinventare, in ciascuna situazione concreta, una risposta appropriata», che, a parere della Cartabia, proviene dal nocciolo stesso della tragedia greca, e la trasformazione delle nostre società in arcipelaghi di comunità che si autogovernano. Un modello che alcuni filosofi (ad esempio, Chandran Kukathas) hanno esplicitamente teorizzato e di cui troviamo esempi non proprio felici in Gran Bretagna, dove l'avvento delle corti islamiche ha instaurato oramai una sorta di pluralismo giuridico spurio, che sta soppiantando il vecchio Stato nazionale di diritto della tradizione occidentale.Può darsi che anche stavolta non abbiamo inteso bene quanto scritto dalla vicepresidente della Corte. La quale di una cosa può ritenersi soddisfatta: alla Verità può contare su lettori appassionati.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».