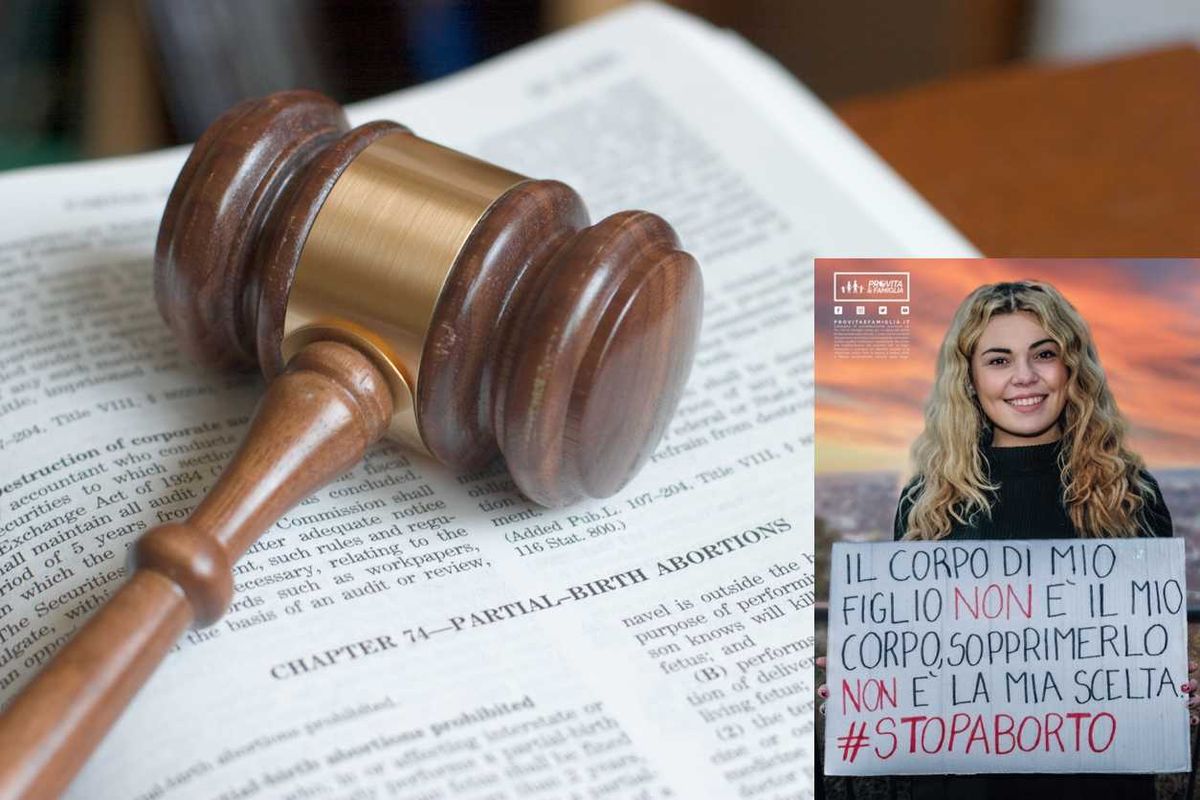La proclamazione, assieme a Bergamo, di Brescia capitale italiana della cultura per il 2023 ha acceso l’attenzione sui vari aspetti che possono valorizzare la Leonessa d’Italia, non ultimo quello che riguarda la cultura materiale, altrimenti detta gastronomia curiosa.
È vero che, per andare sul sicuro, si può viaggiare sugli affidabili casonsèi, come sullo spiedo, festeggiando poi con il bossolà ma, in realtà, Brescia e il suo territorio hanno molto altro da offrire agli Sherlock Holmes di papille. Una cucina per lungo tempo discreta e operosa, come la sua gente. Il mercato vecchio cittadino rifornito da donne e uomini che scendevano dai ronchi, sorta di orti posti sui primi colli attorno alla città, con ortaggi di varia natura. Gli agnelli dalle valli, i vitelli dalla bassa, lucci e coregoni dai laghi. Una comunità ambulante della vendita al dettaglio che non faceva mancare nulla. Fuori casa tavole rustiche a ritrovo della loro comunità, tanto è vero che, come ha scritto Paolo Pietta, «in ogni luogo in cui ci fosse baratto o vendita lì c’era un’osteria con l’oste testimone» e garante dei vari interlocutori tanto da diventare via via luogo della memoria grazie ai piatti della tradizione.
Una cucina quindi, quella bresciana, poco conosciuta al di fuori dei confini, con un cambio di passo attorno agli anni Settanta. Benedetto Girelli, di Barghe, divenne riferimento certo per chi tornava dalle vacanze montanare. Al suo tavolo presenze costanti Fred Bongusto, Mina, Celentano e il Mago Zurlì, che non aveva bisogno della bacchetta magica per divertirsi con i suoi piatti. Venne scoperto e valorizzato mediaticamente da Gino Veronelli che se lo portò spesso a fianco nelle sue trasmissioni con il ciak ai fornelli. Fu proprio Girelli a far conoscere al mondo il bagoss, da lui definito «il formaggio dell’amore».
Qualche anno dopo la cucina bresciana salì ulteriormente di grado, con nomi quali Mario Piscini a Concesio, Gino Gavazzi a Calvisano, Vittorio Fusari a Iseo, ma il botto lo fece Gualtiero Marchesi che, dopo le stelle meneghine, scelse il suo buen retiro in Franciacorta. Li valorizzò sulle rubriche dei quotidiani locali un certo Aldo Corte, pseudonimo di Enzo Vizzari, una delle grandi firme della storia gastronomica nazionale. Pur nativo di Varallo Sesia, in Piemonte, il giovane Enzo era responsabile della comunicazione di importanti aziende nel bresciano e da lì fu un lievitare virtuoso. Brescia tra le più affollate province stellate nazionali, cappellate dal buon Vizzari, divenuto responsabile delle Guide Espresso e altro ancora.
Su queste basi è conseguente intuire che, dopo spiedi e casonsèi, la Leonessa golosa può offrire anche molto altro. In un ideale menù a comanda libera non si può che esordire con la polenta, realtà quotidiana da sempre, salvafame affidabile come ben descritto in tempi non sospetti, nel 1801, da Agostino Basco: «canto la gloria della gran polenta, ch’empie la panza e ognun sazia e contenta. Delle pietanze Domina e Regina, fatta al foco con sal, acqua e farina». Con risorse insospettabili. In Val Sabbia troviamo la polenta balotta. Modellata in forma sferica custodisce al suo interno un po’ di formaggio tenero. A seguire un fondersi di amorosi sensi cotta su di una graticola appoggiata sulle braci. Per chi vuol rivivere la tradizione ecco la panissa camuna, nelle malghe della Val Camonica. Un pozzetto al centro colmo di intingoli vari, formaggio grattugiato e burro cotto. L’abilità nel gestire il cucchiaio pescando bipartisan, polenta e intruglio goloso senza rompere i bordi, per non rischiare un Vajont sugoso sul piatto e i lazzi della compagnia gaudente. Per chi vuol rivivere le emozioni dei nonni la polenta a frigole, ovvero briciole di farina tostata mischiate a latte fresco. Sorta di rustici pop corn ante litteram.
Dai pascoli montani alle rive lacustri con el sisam, che non ha origini beduine, bensì è un antico metodo di conservazione del pesce in agrodolce. Essiccato sulle rive del Garda e poi sciolto in un composto di cipolle appassite e olio. Il tocco assassino con qualche goccia di zucchero e aceto. Garda che, a suo tempo, incantò Wolfgang Goethe per la sua «armonia senza fine dove spiccano i colori del Mediterraneo», con una inevitabile ricaduta su una ampia e intrigante offerta golosa. Tra valli, laghi e pianura il bresciano è una antologia di proposte diverse. Ad esempio la minestra mariconda, fatta con gnocchi di pane raffermo. Cugini dei canederli trentini, con qualche variante locale, come a Pasqua quando, nell’impasto, vengono aggiunti beneaugurali semi di mela. Dall’etimo goliardico la bertoldina, fatta con i resti di pasta avanzati nel cassetto. Sminuzzati e lavorati con burro, farina, uova e formaggio grattugiato. Il tutto lavorato a mò di frittata.
Esiste il salame che non è un insaccato? Basta andare a Borno, in Valcamonica. Un rotolo di pasta che, per la sua forma, viene creativamente associato al cugino suino, laddove il ripieno, a base di spinaci selvatici, viene irrobustito con cervella, pezzetti di salame, per un minimo di coerenza culinaria, così come funghi, uova, parmigiano, pangrattato. Altra divertente e ghiotta scoperta camuna le piode di Monno, un piccolo borgo di 500 anime. Sono degli gnocchi molto particolari, fatti con patate crude grattugiate. Impastate con farina e appiattite con le mani vengono poi bollite come gli gnocchi, condite con burro fritto e parmigiano. Per la loro forma gemellate con le omonime pietre di ardesia dei tetti, le piode, appunto.
Intriganti i brofadei. Piccoli gnocchetti lavorati a freddo con due farine, bianca e gialla, e uova. Spadellati con un filo di burro e una volta raggiunta la giusta doratura buttati a pioggia nel brodo bollente. Altri gnocchetti golosi quelli de la cua, potenziati dal gusto intenso dei peruch, erbe di montagna e dal silter, un formaggio di lunga tradizione valligiana le cui storie si possono scoprire nel museo allestito entro un ex caseificio turnario a Cerveno. Oramai è tempo di casonsèi. Sull’etimo scuole di pensiero diverse che comunque rimandano alla similitudine con un piccolo cassone, contenitore di quanto dispensa permetteva. L’esordio letterario un po’ splatter, nel 1478, per mano del notaio Jacopo Melga, nel descrivere i danni dell’ennesima pestilenza. «Li morti li buttavano in li sagrati e li mettevano uno sopra l’altro come si fa con i casoncelli». Un tempo si usavano farine di seconda scelta, il pane ammollito nel latte. Per irrobustire il tutto del lardo tritato e poi rosolato in padella, versato poi sui casoncelli con un po’ di formaggio. Col tempo si sono sviluppate diverse interpretazioni, a seconda degli usi e costumi delle comunità locali. A Ponte di Legno si possono trovare farciti con patate e cotechino. in Val Camonica c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si va da quelli con salsiccia e mortadella a quelli più «esotici» con uvetta sultanina, pere, amaretti e noci. Per chi vuole emendarsi dai peccati di gola anche una versione più «quaresimale» con ricotta di pecora ed erbe di campo.
Sui titoli di coda non poteva mancare la citazione del risotto alla pitocca con pollo verdure e aromi. Un piatto di sussistenza se è vero che, un tempo, i pitocchi erano quei mendicanti che, percorrendo le strade da villaggio a villaggio, bussavano alle cascine chiedendo la generosità di qualcosa da mangiare. Ecco allora come anche a Brescia e nel suo territorio si può sostenere che, oltre ai casonsèi, c’è di più. E siamo solo ai primi piatti…