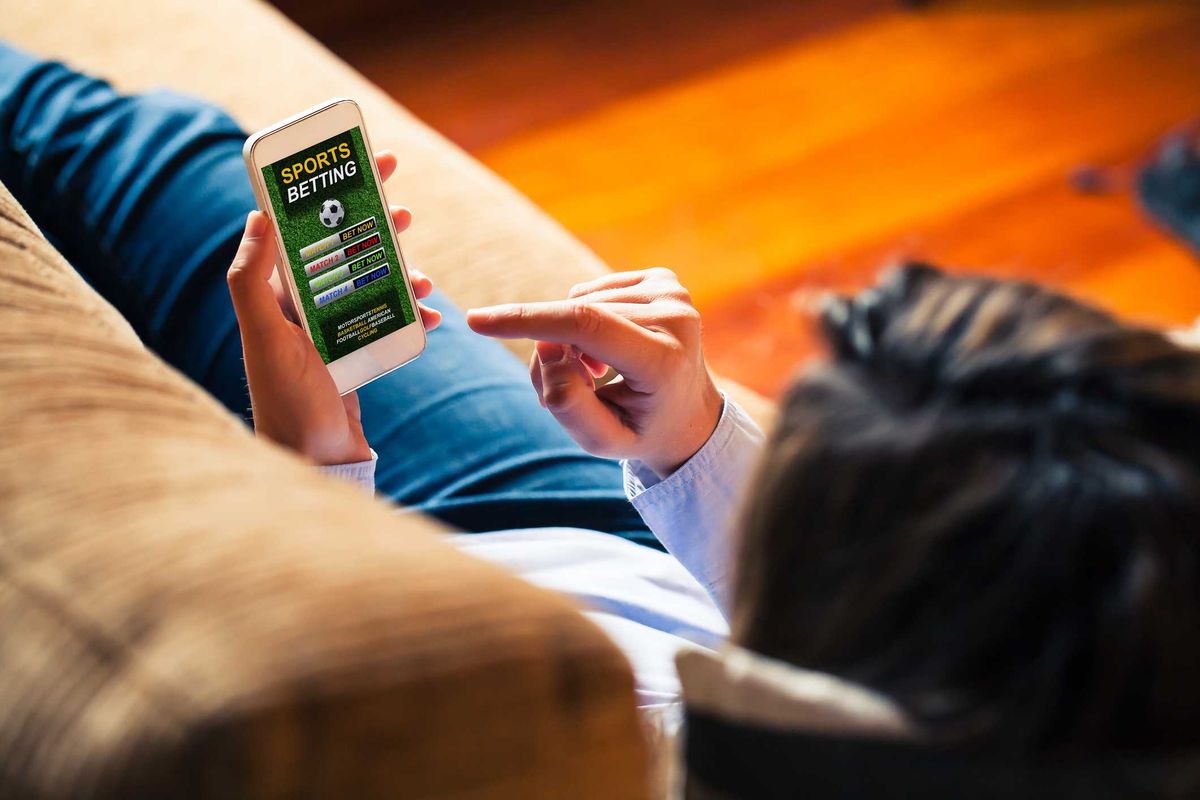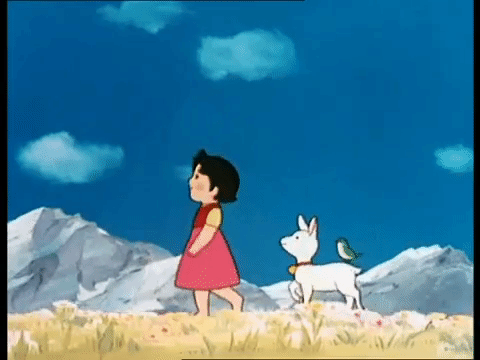
Siamo il Paese in Europa con più aziende agricole gestite da millennial farmers e crescono veloci soprattutto quelle in rosa. Solo nel corso del 2017 sono nate quasi 14.000 imprese al femminile. I numeri del ritorno alla terra e le storie di tre ragazze.C'è un campo in cui il resto d'Europa ha molto da imparare dall'Italia. Le aziende agricole guidate da under 35 sono oltre 55.000, un record che mette il nostro Paese al primo posto nell'Unione europea come ha certificato Coldiretti. Il tasso di crescita di queste realtà si aggira sul 6% ogni anno. Perché, a dispetto di lauree, master ed esperienze all'estero, sono sempre di più i ragazzi che decidono di tornare a coltivare la terra. Per loro è stato coniato anche un nuovo termine: millennial farmers. Perché questi contadini del nuovo millennio sono molto diversi da quelli del passato: sono istruiti (uno su quattro è laureato), vantano un tasso altissimo di hi-tech, sono abituati a viaggiare fuori dai confini (otto su dieci lo fanno regolarmente), si sentono perfettamente a proprio agio nel mercato globale e sanno intercettare le nuove tendenze nel campo del food. Si chiamano Andrea, Salvatore, ma anche Daniela e Silvia. Perché le donne che si dedicano alle fattorie sono sempre più numerose.Secondo il rapporto Ritorno alla Terra della Confederazione nazionale coltivatori diretti, 30.000 giovani italiani tra il 2016 e il 2017 hanno inoltrato domanda per l'insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) dell'Unione europea. Le istanze presentate superano di circa il 44% le previsioni per l'intera programmazione fino al 2020. Il 61% di questi giovani risiede al Sud e nelle isole, il 19% al Centro e il restante 20% al Nord. La Sicilia e la Puglia sono le prime due regioni, con 4.700 e 4.540 domande. C'è anche un altro dato assolutamente inedito rispetto al passato: oggi, secondo gli ultimi dati Istat, un contadino su quattro è donna. Solo nel corso del 2017 sono nate quasi 14.000 nuove aziende agricole «in rosa», con un incremento annuo del 6,6%. Ma chi sono le ragazze che scelgono la terra per costruire il proprio futuro? Le contadine 4.0 hanno mediamente un'età compresa fra 40 e 60 anni (solo il 9% del totale risulta più giovane), hanno un diploma in tasca (circa il 6% è laureata), spesso lasciano un lavoro in ufficio per dedicarsi alla nuova attività a contatto con la natura e sono molto interessate al mondo bio (il 13% coltiva biologico).La maggior parte gestisce imprese di piccole dimensioni o a conduzione familiare, così come fattorie didattiche e servizi di pet therapy. Le Regioni con il tasso più alto di donne impiegate in agricoltura sono Molise e Valle d'Aosta (con il 45% e 44% di imprese agricole al femminile), seguite da Umbria e Liguria (38% ciascuna).In questo esercito di donne appassionate di agricoltura e cura degli animali ci sono tante storie. Come per esempio quella di Daniela Pasinetti, una giovane piemontese di Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, per molti anni impegnata fra set fotografici e copertine come fotomodella. Da sempre amante della natura, ha deciso di cambiare vita dopo aver incontrato il suo attuale marito. Con lui ha deciso di chiudere con il vecchio lavoro e di trasferirsi sulle Prealpi bellunesi. Proprio qui oggi gestisce una fattoria dove alleva 450 pecore e 50 capre e dove produce latte, yogurt e formaggi. Rimpianti per la sua vecchia vita davanti all'obiettivo? Assolutamente no: «Immergersi nella natura, godere dei colori e dei profumi, è davvero fantastico. Ci si ricarica lo spirito e si dimenticano le fatiche del lavoro, che non mancano».Come lei ha deciso di cambiare tutto anche Silvia Lupi, trentenne ligure diplomata in ragioneria. Questa ragazza coraggiosa si è lanciata in una sfida difficilissima: riportare sulle montagne dell'Alta Val Trebbia l'agricoltura. Una pratica abbandonata da quasi un secolo. Così ha preso in mano la piccola azienda agricola di famiglia per cominciare a produrre latte vaccino, ad allevare vitelli e suini e per coltivare campi di cereali e frumento biologici. Il tutto con l'aiuto della sua famiglia. E poi c'è la storia di Roberta Valletti, 19 anni, originaria di Barolo. Figlia di viticoltori impegnati nelle Langhe piemontesi, ha scelto di non seguire l'attività dei genitori, ma di trasferirsi in montagna per dedicarsi alla transumanza con pecore e capre e per produrre formaggio. Una decisione della quale non si è mai pentita, nonostante i ritmi di vita difficili, che speso risultano anche molto solitari.Insomma, gli agricoltori del nuovo millennio sono giovani, e meno giovani, perfettamente calati nella realtà e nel mondo globale, ma con un occhio attento alla natura e alla qualità del cibo. Ma anche alle nuove tecnologie che, proprio grazie a loro, sono sempre più vicine al mondo dell'agroalimentare. Per loro ormai utilizzare sensori intelligenti e droni in grado di controllare lo stato del raccolto è ordinaria amministrazione. Così come fare ricorso ai big data e all'intelligenza artificiale per contrastare lo sviluppo di possibili malattie delle piante. Ma non finisce qui, perché i millennial farmers fanno ricorso anche al packaging intelligente, allo sviluppo di cibi alternativi, come alghe e insetti, e alle piattaforme social che mettono in contatto agricoltori e consumatori. In un mix sapiente, e perfettamente equilibrato, fra tradizioni antiche e innovazione.
Nadia e Aimo Moroni
Prima puntata sulla vita di un gigante della cucina italiana, morto un mese fa a 91 anni. È da mamma Nunzia che apprende l’arte di riconoscere a occhio una gallina di qualità. Poi il lavoro a Milano, all’inizio come ambulante e successivamente come lavapiatti.
È mancato serenamente a 91 anni il mese scorso. Aimo Moroni si era ritirato oramai da un po’ di tempo dalla prima linea dei fornelli del locale da lui fondato nel 1962 con la sua Nadia, ovvero «Il luogo di Aimo e Nadia», ora affidato nelle salde mani della figlia Stefania e dei due bravi eredi Fabio Pisani e Alessandro Negrini, ma l’eredità che ha lasciato e la storia, per certi versi unica, del suo impegno e della passione dedicata a valorizzare la cucina italiana, i suoi prodotti e quel mondo di artigiani che, silenziosi, hanno sempre operato dietro le quinte, merita adeguato onore.
Franz Botrè (nel riquadro) e Francesco Florio
Il direttore di «Arbiter» Franz Botrè: «Il trofeo “Su misura” celebra la maestria artigiana e la bellezza del “fatto bene”. Il tema di quest’anno, Winter elegance, grazie alla partnership di Loro Piana porterà lo stile alle Olimpiadi».
C’è un’Italia che continua a credere nella bellezza del tempo speso bene, nel valore dei gesti sapienti e nella perfezione di un punto cucito a mano. È l’Italia della sartoria, un’eccellenza che Arbiter celebra da sempre come forma d’arte, cultura e stile di vita. In questo spirito nasce il «Su misura - Trofeo Arbiter», il premio ideato da Franz Botrè, direttore della storica rivista, giunto alla quinta edizione, vinta quest’anno da Francesco Florio della Sartoria Florio di Parigi mentre Hanna Bond, dell’atelier Norton & Sons di Londra, si è aggiudicata lo Spillo d’Oro, assegnato dagli studenti del Master in fashion & luxury management dell’università Bocconi. Un appuntamento, quello del trofeo, che riunisce i migliori maestri sarti italiani e internazionali, protagonisti di una competizione che è prima di tutto un omaggio al mestiere, alla passione e alla capacità di trasformare il tessuto in emozione. Il tema scelto per questa edizione, «Winter elegance», richiama l’eleganza invernale e rende tributo ai prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, unendo sport, stile e territorio in un’unica narrazione di eccellenza. A firmare la partnership, un nome che è sinonimo di qualità assoluta: Loro Piana, simbolo di lusso discreto e artigianalità senza tempo. Con Franz Botrè abbiamo parlato delle origini del premio, del significato profondo della sartoria su misura e di come, in un mondo dominato dalla velocità, l’abito del sarto resti l’emblema di un’eleganza autentica e duratura.
iStock
A rischiare di cadere nella trappola dei «nuovi» vizi anche i bambini di dieci anni.
Dopo quattro anni dalla precedente edizione, che si era tenuta in forma ridotta a causa della pandemia Covid, si è svolta a Roma la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che ha visto la numerosa partecipazione dei soggetti, pubblici e privati del terzo settore, che operano nel campo non solo delle tossicodipendenze da stupefacenti, ma anche nel campo di quelle che potremmo definire le «nuove dipendenze»: da condotte e comportamenti, legate all’abuso di internet, con giochi online (gaming), gioco d’azzardo patologico (gambling), che richiedono un’attenzione speciale per i comportamenti a rischio dei giovani e giovanissimi (10/13 anni!). In ordine alla tossicodipendenza, il messaggio unanime degli operatori sul campo è stato molto chiaro e forte: non esistono droghe leggere!
Messi in campo dell’esecutivo 165 milioni nella lotta agli stupefacenti. Meloni: «È una sfida prioritaria e un lavoro di squadra». Tra le misure varate, pure la possibilità di destinare l’8 per mille alle attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.
Il governo raddoppia sforzi e risorse nella lotta contro le dipendenze. «Dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato, toccando quota 165 milioni di euro» ha spiegato il premier Giorgia Meloni in occasione dell’apertura dei lavori del VII Conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui Meloni ha rivolto i suoi sentiti ringraziamenti, il premier ha spiegato che quella contro le dipendenze è una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria». Lo dimostra il fatto che «in questi tre anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse, ci siamo preoccupati di costruire un nuovo metodo di lavoro fondato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto perché siamo consapevoli che il lavoro riesce solo se è di squadra».