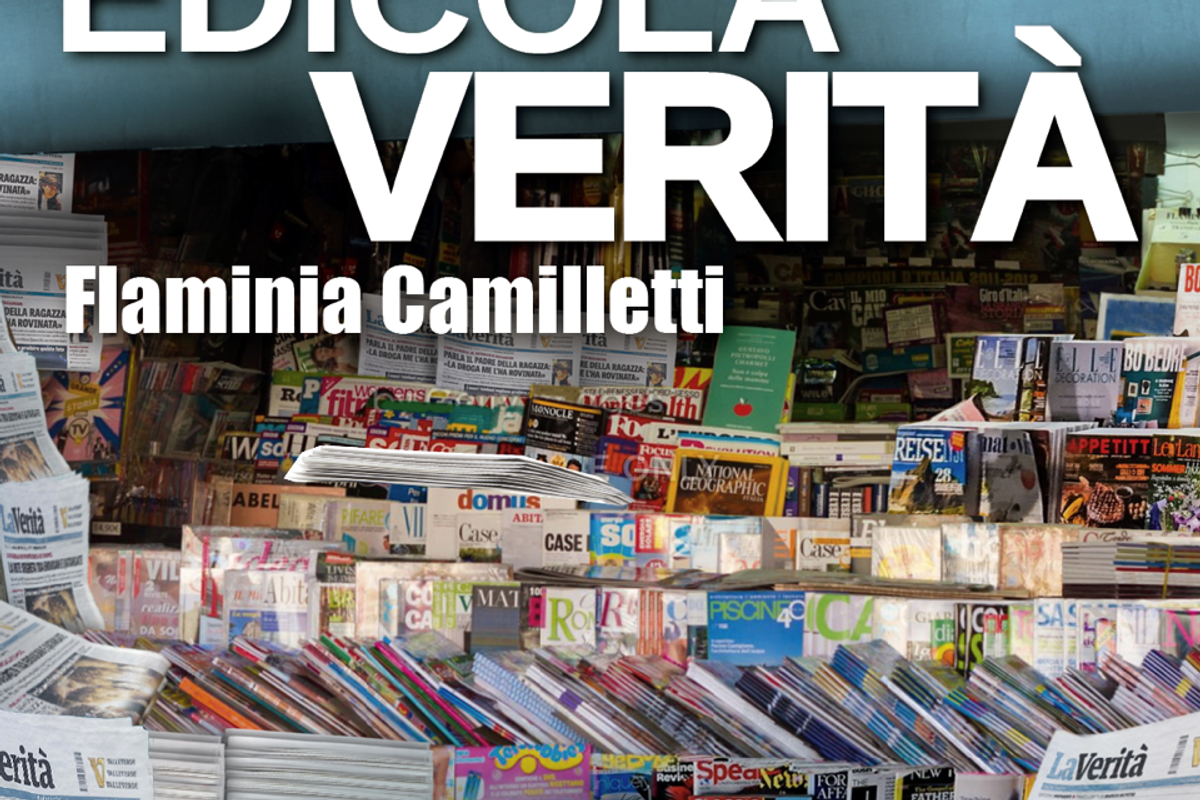2023-01-27
Il porto di Amburgo (cioè la Cina) conquista il terminal di Trieste
La tedesca Hhla ha preso la maggioranza dell’importante snodo infrastrutturale italiano. Il 25% del capitale degli amburghesi, tuttavia, fa capo al Dragone. Il governo fermi l’operazione utilizzando il golden power.Ursula von der Leyen vara un programma di «cooperazione strategica» con gli istituti del colosso asiatico. Ma Fbi e Copasir avevano già lanciato l’allarme spionaggio.Lo speciale contiene due articoliBlitz silenzioso. Da ieri il gestore del porto tedesco di Amburgo, la Hamburger Hafen und Logistik Ag (Hhla), ha preso la maggioranza del terminal di Trieste. Il 50,01% della piattaforma logistica giuliana non è più nelle mani di italiani, ma di tedeschi che a loro volta ospitano nel capitale (al momento circa il 25% di quota) il più grande colosso cinese dello shipping, la Cosco. La notizia è quindi doppiamente di rilievo. Mentre gli sforzi del governo sono diretti a Sud per dare contorno logistico a quello che dal punto di vista della sovranità energetica viene chiamato «nuovo piano Mattei», uno dei principali porti italiani asseconderà scelte e strategie decise molto più a Nord. Tutto annunciato. D’altronde Angela Titzrath, presidente dell’executive board di Hhla, l’ha detto chiaramente in occasione della sua visita a Triste: «Nel 2020 abbiamo acquisito una partecipazione in Hhla plt Italy per espandere ulteriormente la nostra rete europea di terminal e collegamenti ferroviari. Sono orgogliosa del fatto che negli ultimi due anni sia diventato un importante hub nella regione adriatica. Stiamo dando forma ai flussi di merci del futuro, collegando con successo la regione adriatica con la regione dell’Europa centrale e orientale, che è in crescita dinamica», si legge dalle dichiarazioni fedelmente riprese dal sito specializzato Shipmag. «Il nostro obiettivo è quello di espandere la posizione di Hhla come porta d’accesso meridionale all’Europa». Quindi da Sud verso Nord. Purtroppo, come scritto sopra, questo è solo uno dei due campanelli d’allarme. Il secondo riguarda i tasselli della Via della seta. Certo, nessuno chiede di bloccare gli scambi e le relazioni verso Pechino. Al contrario, sarà importante mantenere flussi di export e import, ma la questione delle infrastrutture è troppo delicata per non diventare un tema di sicurezza nazionale. A marzo del 2019, un anno prima dell’inizio della pandemia, il governo di Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno ospitato in pompa magna Xi Jinping. È toccato a Conte firmare le sette pagine di memorandum con cui l’Italia si è impegnata ad aderire alla Via della seta. Nel testo ci sono passaggi fondamentali per la strategia cinese in Europa. «Le parti si impegnano», si può leggere nel documento, «a cooperare nello sviluppo della connettività infrastrutturale e nella logistica in tutte le aree di mutuo interesse». Il riferimento è a strade, porti, telecomunicazioni ed energia con l’obiettivo di innestare nel sistema italiano il flusso di merci cinese per poi farlo circolare nelle reti europee Ten-t. L’ex premier Mario Draghi, al termine degli incontri in ambito del G7 che si è tenuto a giugno del 2022, aveva fatto sapere di voler leggere con attenzione l’accordo firmato da Conte per consentire al Paese - si intuiva dalle affermazioni - di avere le mani libere di operare con le altre nazioni Ue e soprattutto con gli Usa. Il tema del 5G e delle telecomunicazioni è finito sotto vigilanza della nuova agenzia di cybersecurity. Inutile spiegare che i porti sono l’hub per eccellenza di tutte queste tecnologie e quindi la ciliegina sulla torta del dominio logistico. Tornando all’operazione di scalata al terminal, per Pechino questo significa portare a casa il tridente: Vado Ligure, Trieste e Pireo. Per il governo Draghi tagliare la Via della seta significava intervenire a gamba tesa e bloccare la strategia. Il modo era invocare il golden power europeo. Il discorso vale anche per questo esecutivo. Un veto mai usato ma che potrebbe tornare utile con la benedizione di Joe Biden. D’altronde si deve sempre agli americani il fallito tentativo di China construction comunication company, Cccc (ora nella lista nera di Washington) di prendere Taranto, nonostante l’incessante opera di promozione da parte dell’ex sottosegretario del Conte bis, Mario Turco. Adesso, rispetto al 2021, ci sono anche ulteriori elementi sul tavolo. La visita di Olaf Scholz a Pechino lo scorso novembre, a cui è appunto seguita l’operazione sul porto di Amburgo, ha sollevato numerose critiche anche in patria. L’erede di Angela Merkel ha trovato così un escamotage. Quello di fermare i cinesi al 24,9% di Hhla nella speranza che non dettino eccessivamente la linea. Tutti gli analisti del settore sanno che è solo un fatto temporale. Come è successo con i titolari di Amburgo, su Trieste, se non ci saranno fattori di intervento esterno, accadrà la stessa cosa per mano cinese. Eppure il Mediterraneo è troppo importante perché non sia controllato dal nostro Paese o dagli alleati Nato in tutti i suoi terminali. Ci riferiamo ai principali porti da cui partirà la nuova economia del mare fatta di energia, dati, cavi e droni. Il golden power esiste per questo. Va valutato e si può usare anche contro società europee.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/il-porto-di-amburgo-cioe-la-cina-conquista-il-terminal-di-trieste-2659316786.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="ursula-lega-i-nostri-atenei-a-pechino" data-post-id="2659316786" data-published-at="1674776550" data-use-pagination="False"> Ursula lega i nostri atenei a Pechino Da anni i servizi segreti di tutto il mondo mettono in guardia i propri Paesi sul rischio di accordi accademici con la Cina. Lo scorso luglio Christopher Wray, direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), aveva ricordato che la Cina punta a «saccheggiare» la proprietà intellettuale delle società occidentali con l’unico obiettivo di diventare la sola superpotenza mondiale. Nonostante questo, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha deciso di lanciare un programma di borse di studio per promuovere «la cooperazione strategica» con le università e i think tank cinesi su questioni relative alle relazioni tra l’Ue e l’Estremo Oriente. «L’obiettivo è attingere a competenze approfondite» e «ampliare la base di conoscenze» sulla Cina all’interno della commissione europea. Del progetto se ne occuperà Idea, un oscuro organo consultivo interno alla Commissione che fa capo direttamente alla presidenza. Non solo. Di fatto, ricorda la nota diramata ieri dalla Commissione europea, le borse di studio metteranno insieme professori provenienti da think tank e università di tutto l mondo «specializzati in questioni politiche, sociali, economiche, digitali, ambientali e climatiche, di sicurezza o storiche relative alla Cina». La scelta della von der Leyen segna forse un cambio di passo nei rapporti con Pechino, dopo gli ultimi anni. Del resto, già nel 2018 l’Fbi, nella relazione «China: the risk of Academia», informava cittadini, governi e istituzioni sulla pericolosità dell’intelligence cinese, che tramite sponsorizzazioni di viaggi all’estero, borse di studio e opportunità di ricerca congiunte, avrebbe potuto accedere a informazioni sensibili sull’Occidente. In questi anni si sono registrati migliaia di casi in tutto il mondo: dal ricercatore cinese capace di sottrarre illegalmente all’università del Midwest una ricerca sul cancro, ai professori britannici invitati all’università di Nanchino a cui furono copiate e rubate le memorie di computer e cellulari. China Initiative, lanciato dall’amministrazione di Donald Trump per permettere agli Stati Uniti di difendersi dallo spionaggio industriale, è stato ridimensionato lo scorso anno dal presidente Joe Biden. C’è chi ha criticato il programma, per la profilazione etnica o la criminalizzazione della comunità scientifica, ma gli allarmi per lo spionaggio industriale cinese si sono rivelati più che fondati. Proprio mercoledì scorso una giuria federale di Chicago ha condannato a 8 anni di carcere, con l’accusa di spionaggio, Ji Chaoqun, un ingegnere cinese di 31 anni che era stato arruolato nel 2016 nell’ambito di un programma che recluta cittadini stranieri con competenze considerate vitali per l’interesse nazionale. Peccato che lavorasse in segreto per Pechino e l’intelligence cinese e che grazie al suo ruolo nell’esercito avesse la possibilità di fotografare portaerei come altri asset strategici. Negli Stati Uniti fece scalpore negli scorsi anni il caso di Hao Zhang condannato per spionaggio industriale a 18 mesi di carcere per aver rubato segreti commerciali su dispositivi wireless a due società statunitensi: una di queste società aveva impiegato oltre 20 anni a sviluppare la tecnologia rubata da Zhang. Anche i servizi segreti italiani hanno messo in guardia il Parlamento sulle possibili infiltrazioni cinesi nelle nostre università. Lo riporta l’ultima relazione del Copasir guidato dall’ex presidente Adolfo Urso (ora ministro per lo Sviluppo economico). Nel documento di 120 pagine inviato nel febbraio del 2022 a Camera e Senato, si ricorda appunto come «un ambito rispetto al quale si è evidenziata la necessità di intervenire al fine di introdurre apposite tutele e meccanismi di protezione dell’interesse nazionale è quello dell’università e della ricerca. Attraverso le informazioni acquisite dal Comitato è risultato infatti crescente l’interesse da parte di attori statuali stranieri, in particolare cinesi, nei confronti del mondo accademico italiano, in special modo per quegli ambiti nei quali più avanzata risulta l’attività di ricerca da questi condotta». Secondo i nostri servizi sarebbero diverse le modalità con cui si instaurano questi rapporti. Speso si tratta «di legami tra università italiane e istituti per la diffusione della cultura del Paese straniero interessato». Altre volte, sono invece «accordi di collaborazione tra aziende straniere, spesso sottoposte al controllo statale, e atenei italiani». Dove, «a fronte del finanziamento delle attività di ricerca erogato da parte del partner privato, ci si espone al concreto rischio di una sottrazione di tecnologia e know how». È una situazione che purtroppo in Italia si può vedere spesso, dovuta alla carenza di fondi pubblici. Si tratta però di un vero e proprio di «cavallo di Troia » che rischia di aggirare «i paletti fissati dal golden power rispetto alla penetrazione in alcuni settori industriali strategici».
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 17 novembre con Flaminia Camilletti
Benjamin Netanyahu (Ansa)