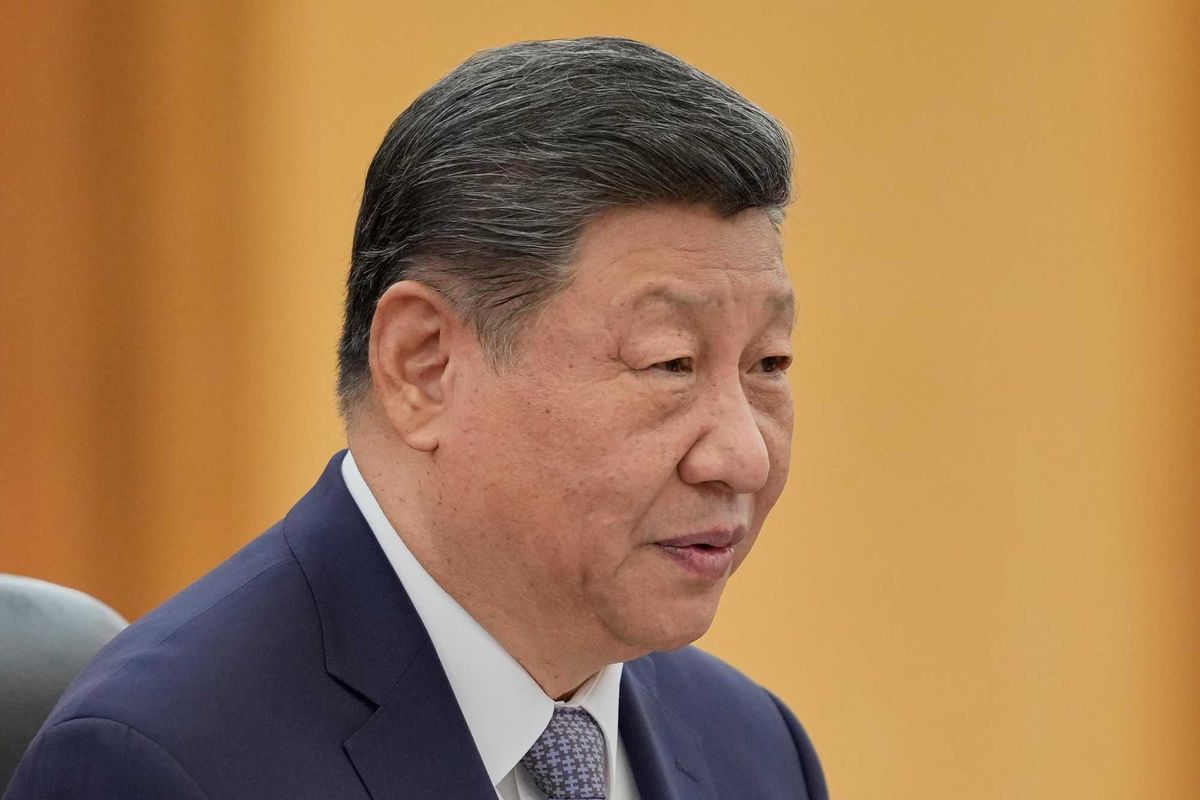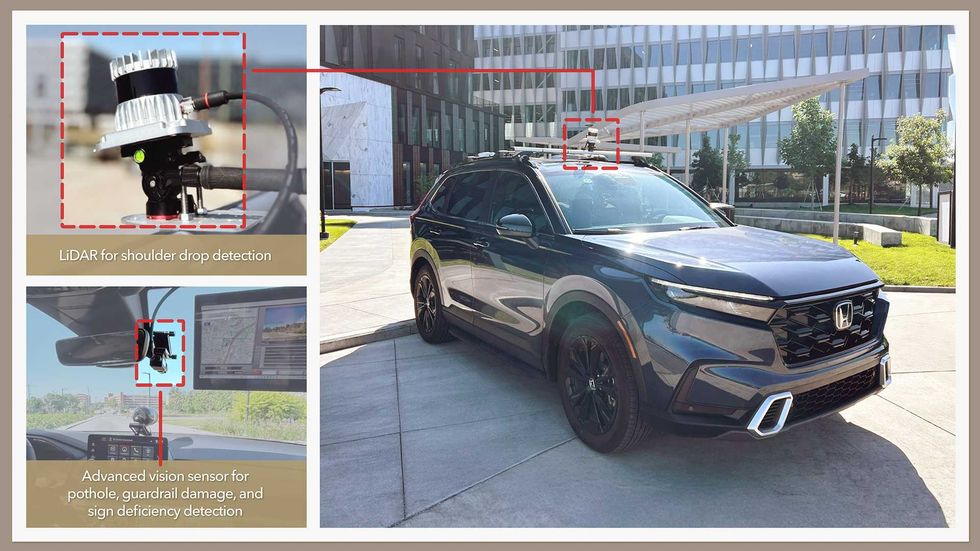Ma quale viagra! Meglio il metodo che Ovidio suggeriva agli uomini sessualmente giù di corda. Naturale e, a quanto pare, efficace: «Piper urticale mordacis, semina miscent». Tradotto liberamente, dice: «Se volete rianimarvi assumete una mistura di pepe e semi di pungente ortica». L'autore dell'Ars amatoria di queste cose se ne intendeva. Aveva naso. Anzi, Nasone.
Del resto cosa sono la vita, l'amore e la poesia senza un po' di pepe? Attenzione, però. Ce ne vuole q.b., quanto basta. Una persona tutta pepe è piacevole, simpatica, vivace e mordace. Ma quando tira troppo la corda, rompe. Fu proprio quel che accadde ad Ovidio che macinò un po' troppo pepe nei suoi versi licenziosi. L'imperatore Augusto, quando non lo sopportò più, lo spedì in esilio sul Mar Nero. Così, per troppo pepe, Ovidio conobbe come sa di sale lo pane altrui.
È anche vero che una persona che non sa di sale, né di pepe, è una persona insignificante, insipida. Meglio chi si fa rispettare, che risponde- si dice- con il sale e col pepe. Perciò una giusta quantità di pepe nella vita, nell'arte, nei cibi e nell'amore, ci vuole. Anche nella morte. Come si spiega, altrimenti, il grano di pepe nero trovato in una narice della mummia di Ramesse II? La risposta agli egittologi, noi rimaniamo sulla vita, sui cibi e sull'amore.
Giacomo Casanova, letterato del Settecento, spia (pure lui finì in galera per i suoi intrighi politico-sessuali), instancabile seduttore e gourmet sopraffino, confessa nelle Memorie, scritte quand'era ormai vecchio e senza più voglie, che le donne e i piatti raffinati gli piacquero tantissimo. Andava giù di testa per il pasticcio di maccheroni. Amava profumarlo di pepe nero pestato nel mortaio al momento. E, sicuramente, una spolveratina di pepe la metteva anche sulla sua arma segreta, le ostriche. Ne era ghiottissimo e, a quanto racconta, funzionavano.
La scrittrice cilena Isabel Allende è sulla stessa linea. La piperina e gli altri alcaloidi presenti nel pepe hanno il merito di scatenare aromi e stimoli riconosciuti dalla medicina moderna. In Afrodita, libro di ricette e racconti, sostiene che i cibi afrodisiaci sono «un ponte gettato tra gola e lussuria». Sul pepe non ha dubbi: «Garantisco che procura allegria ai vedovi e mitiga l'impotenza dei timidi e infatti lo cito in quasi tutte le ricette di questo libro, tranne che nei dolci. Meglio tritarne i grani con un macinino di volta in volta per ottenere più sapore e, soprattutto, per il rituale». Conclude il pepato discorso suggerendo di spargere un po' di spezia in polvere sul cuscino dell'amante per accendere l'entusiasmo. Il rischio? Un'irrefrenabile serie di starnuti tutt'altro che eccitanti.
Aldo Fabrizi più che ai probabili e improbabili exploit del basso ventre, era interessato al ventre. E, quindi, al tocco finale che il pepe poteva dare a un piatto. Il grande attore, superbo mangiatore e autore di 202 poesie in dialetto romanesco dedicate a Nonna minestra, rende onori alla pasta e fagioli («La favolosa! La fenomenale!/ L'eccersa! La canora! La divina!») con tre sonetti e una calda raccomandazione agli aspiranti cuochi: «Non ci va nessun tipo di formaggio; il pepe invece sì: nero, macinato sulla scodella. Ciò favorisce la digestione che, attenuando la psicosi apocalittica che incombe su tutti noi, può dare la sensazione di rivivere in un mondo di vecchie favole raccontate sommessamente in una serata d'inverno dinanzi a un fuoco di legna». Chi avrebbe mai pensato che il pepe funzionasse meglio di un'Alka Seltzer o di una camomilla? Nella Roma de noantri ci sono altri tre piatti nei quali il pepe è indispensabile: gli spaghetti cacio e pepe (un nome, un programma); la pasta e ceci e la carbonara.
Il pepe è il re delle spezie. E, come tutte le altre, nel corso dei millenni è stato usato sia per uso alimentare che terapeutico dall'oriente all'occidente. Con il pepe si curava di tutto, dal mal di pancia al mal di cuore, dal mal di denti al mal d'orecchi, dal naso costipato al fegato malandato. Nell'alto medioevo si pensava che un unguento di pepe sugli occhi guarisse le malattie oftalmiche. Sai che goduria. Per gli occhi no, ma è provato che fa bene davvero: è antisettico, antidepressivo, aiuta la secrezione salivare e la digestione (ma è sconsigliato a chi ha problemi di stomaco), depura l'organismo.
Il pepe ha conquistato tutte le cucine fin dall'antichità. Verde, nero o bianco è sempre figlio della stessa pianta, quella che Linneo battezzò Piper nigrum. Il colore dipende dalla lavorazione. Arricchisce pastasciutte, zuppe e risotti, aromatizza pesci, crostacei e carni, profuma salami e lucaniche. Le piccole drupe originarie dall'India erano conosciute già nella Grecia classica per le loro proprietà alimentari, conservative e salutari. Ippocrate prescriveva il pepe come cura e consigliava alle donne di mescolarlo a miele ed aceto per lenire i dolori mestruali. Teofrasto, allievo di Aristotele, ne vantava le proprietà aromatiche e medicinali.
Roma battezzò piper (raccomando di non pronunciare «paiper») quella spezia orientale. Il commercio decollò dopo la conquista della Siria da parte di Pompeo, ma soprattutto dopo che Augusto sollecitò i traffici marittimi verso l'India allestendo, addirittura, una flotta per andarlo a prendere senza mediatori di mezzo. La letteratura imperiale romana è abbondantemente cosparsa di pepe. Ne parla diffusamente Plinio nell'Historia naturalis. Persio Aulo Flacco, poeta satirico, prende in giro l'avaro che condisce l'insalata sacrum inrorans patinae piper, usando poco pepe, come fosse una cosa sacra. Apicio, al contrario, nel De re coquinaria, lo usa quasi quanto il garum, la salsa di pesce fermentato che i romani adoperavano come adesso si irrorano di maionese i paninazzi di McDonald. L'Artusi dell'antichità prevede l'uso del pepe nelle salse, nel vino aromatizzato, sull'aragosta, nel ghiro farcito, sulle frittate, nella salsa ai datteri da spalmare sullo struzzo bollito e perfino, orrore!, sui tartufi, con il miele. Nelle sue ricette è tutto un addes piper; desuper piper aspargis; in mortario teres piper...; aggiungi pepe; spargi sopra il pepe; pesta il pepe nel mortaio...
La spezia, custodita negli horrea, i magazzini pubblici, divenne talmente ricercata e preziosa che Alarico, re dei Visigoti, barbaro ma non stupido, nel 408 dopo Cristo accettò di togliere l'assedio a Roma in cambio di una montagna d'oro e d'argento, di sete pregiate e di tre tonnellate di pepe con le quali, se non fossero state inestimabile merce di scambio, i suoi maneschi ragazzotti avrebbero potuto insaporire la carne cruda (alla tartara) che frollavano sotto le selle dei cavalli, per la durata di cento delle loro vite.
Nelle autarchiche corti medioevali l'uso delle spezie- pepe, cannella, chiodi di garofano-, divenne importantissimo. Non solo come ostentazione di ricchezza e, quindi, di potere (nel 13° secolo la contessa inglese Eleonora di Leicester, spese in sette mesi per il pepe l'equivalente di due anni di salario di un operaio), ma, per aromatizzare carni, pesci e per preparare salse nelle quali intingere cibi per insaporirli o per correggere sapori non proprio piacevoli. Girata la boa dell'anno mille, ci fu aria nuova anche nelle cucine dei castelli e delle abbazie. Sia pure molto lentamente s'impose una diversa considerazione del mangiare. La mera alimentazione si trasformò nei secoli a seguire in gastronomia fino a quando tornarono, con la cucina rinascimentale, i fasti gastronomici del passato.
I pepieri veneziani, mercanti navigatori che, grazie alle crociate, dominavano i traffici del pepe che convogliavano nei loro fondachi del Medio Oriente e da qui a Venezia, fecero fortune immense rivendendo quell'oro nero a prezzi più che pepati. Tanta ricchezza scatenò altrettanta concorrenza. Alla fine del '400 si verificarono due avvenimenti che sconvolsero la storia e l'economia mondiale. Vasco de Gama doppiando il capo di Buona Speranza trovò la via verso l'India regalando alla sua patria, il Portogallo, la supremazia nel commercio delle spezie. Sei anni prima un altro navigatore, il genovese Cristoforo Colombo, credendo di essere arrivato primo in India via mare, scoprì l'America e con essa il cacao, la patata, il pomodoro e un frutto rosso piccante che chiamò pimiento, pepe in spagnolo. Ma il pepe delle Indie colombiane non era il Piper nigrum. È un frutto magnifico, salutare, che incontrerà altrettanto successo del pepe: il peperoncino. Ma questa è un'altra storia.