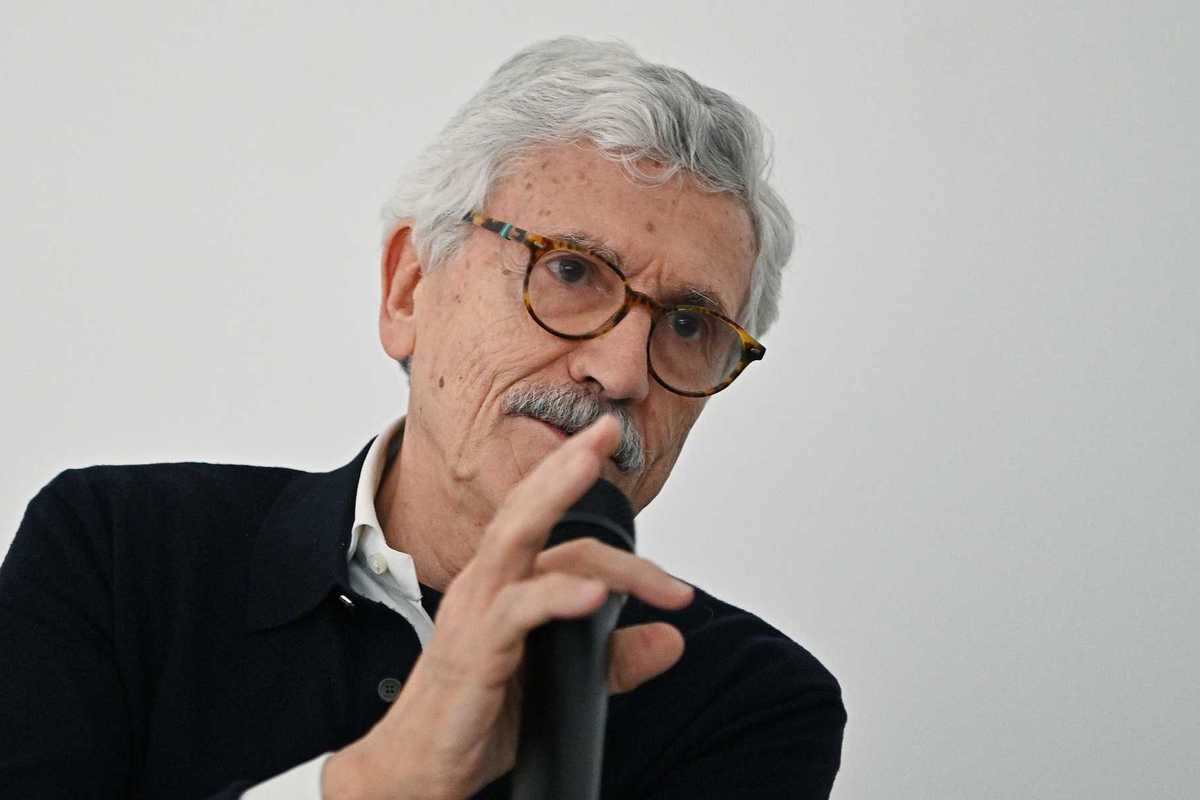«Meglio usare il termine migrazioni piuttosto che invasioni, ma furono migrazioni armate». Così parlò, a proposito delle invasioni barbariche che misero fine all'impero romano, lo storico Walter Pohl, direttore dell'Institut für Mittelalterforschung dell'Accademia Austriaca delle Scienze e insignito nel 2004 del premio Wittgenstein. La Lettura, l'inserto culturale del Corriere della sera, lo ha intervistato, dato che Pohl sarà tra i protagonisti del quarto Festival del Medioevo (Gubbio, Perugia, 26-30 settembre), che avrà come tema proprio «I barbari». Come? C'è puzza di propaganda immigrazionista? Ma cosa andate a pensare, si tratta ovviamente di puri interessi scientifici. Ma, per carità, non chiamatele invasioni. Furono migrazioni, ma con le armi. Cosa distingua una invasioni da una migrazione armata non è dato sapere.
Lo storico ci spiega che spesso questi guerrieri furono chiamati dalle autorità imperiali stesse, che avevano fame di sempre nuovi soldati, salvo poi doversi arrendere alla presenza ormai debordante di queste nuove forze assetate di potere. Pohl precisa comunque che si trattò di «un processo del tutto diverso dall'arrivo dei poveri migranti di oggi, gran parte dei quali, se ci riescono, s'inseriscono nelle nostre società dal basso, non dall'alto». In realtà la nostra società, a sentire una certa retorica, ha «fame» di lavoratori esattamente come l'impero aveva «fame» di soldati. In entrambi i casi, tuttavia, è certo che, arrivate a una certa massa critica, le «risorse» diventano contropotere, come appunto la storia dovrebbe insegnarci. Quanto alle armi, è vero che i migranti di oggi entrano in Europa per lo più disarmati, ma non sembra che abbiano troppe difficoltà a rifarsi strada facendo.
Sempre Pohl, nell'intervista citata, ci illumina con un altro ardito paragone storico: quello sulla costruzione di mura a scopo difensivo dai suddetti barbari e dalle loro «migrazioni armate». Ecco la risposta dello storico alla relativa domanda: «L'impero, paradossalmente, fu un posto molto più sicuro quando le città non avevano mura e le frontiere non erano fortificate: dunque, fino al III secolo d.C. Dopo, vennero costruite mura intorno alle città, come quelle Aureliane a Roma; oppure il limes lungo le frontiere». Capito? Non è che quella società, divenuta più insicura a causa dei barbari, cercò di proteggersi innalzando mura; il nesso causa effetto viene invertito e alla fine risulta che l'insicurezza derivò dalle mura stesse! Più muri, uguale più insicurezza. E noi che, senza aver ricevuto il premio Wittgenstein, credevamo fosse il contrario...
È comunque fin dall'Ottocento che gli storiografi romantici tedeschi hanno iniziato a parlare di Völkerwanderungen, ossia di «migrazioni dei popoli», per designare quelle che fino a qualche anno fa tutti noi abbiamo studiato a scuola con il nome di «invasioni barbariche». Fino a qualche anno fa, appunto, perché - come abbiamo recentemente documentato anche su queste stesse colonne - oggi nei sussidiari scolastici si possono trovare frasi di questo tipo: «Sarebbe più corretto parlare di migrazioni barbariche, proprio perché non interessarono solamente spietati guerrieri - che erano in minoranza - ma intere popolazioni di uomini, donne, vecchi e bambini che si spostavano in cerca di un luogo migliore dove vivere. I romani, però, la pensavano diversamente…». Salviniani ante litteram, questi romani, che non sapevano distinguere la i pochi barbari fondamentalisti dai molto più numerosi barbari moderati in fuga dalla guerra e portatori di un discorso di convivenza e tolleranza.
Succede sempre così: la star della storiografia detta la linea, che poi si riverbera là dove veramente ogni tesi ha un suo peso sociale: i libri scolastici, i testi che formano bambini e ragazzi.
E pensare che, negli ultimi anni, sul Medioevo, non sono poche le opere che hanno demolito, sì, degli stereotipi, ma proprio nel senso di un superamento del politicamente corretto. Nel 2008, per esempio, Sylvain Gouguenheim, medievista all'École normale supérieure di Lione, ha pubblicato un saggio, Aristote au Mont-Saint-Michel, che ha rimesso in discussione il debito dell'Europa medievale nei confronti della vicina cultura araba, rivalutando invece l'influsso diretto della cultura greca. Quel presidio di tolleranza e sapere critico che è l'accademia ha accolto tali tesi con la consueta sportività: sono almeno tre le petizioni contro di lui sottoscritte da decine di colleghi, anche se un autorità indiscussa degli studi sull'età di mezzo come Jacques Le Goff si è schierato al suo fianco.
Negli stessi anni, l'arabista spagnolo Serafín Fanjul García rimetteva in discussione «la chimera di Al Andalus», con allusione, ovviamente, al dominio arabo musulmano nella penisola iberica durato dall'VIII secolo sino alla capitolazione di Granada nel 1492. Un'epoca, ci viene detto, di grande prosperità e pacifica convivenza, messa a repentaglio da quegli screanzati degli spagnoli che hanno persino avuto l'impudenza di lanciarsi in una «reconquista». Ma l'epopea della Spagna musulmana, spiegava Fanjul, fu tutt'altro che contrassegnata da tale atmosfera idilliaca. Si caratterizzò, al contrario, per un regime monolingue e monoculturale, con tanto di spietate esecuzioni di infedeli. «Il potere religioso di Al Andalus cercò sempre l'islamizzazione totale e ci furono esodi massivi di cristiani verso il Nord fino al XII secolo», ha dichiarato lo storico. È strana, la storia: i suoi protagonisti in carne e ossa credono sempre di saperne di più, circa le minacce reali che gravano su di loro, rispetto agli storici politicamente corretti di qualche secolo dopo. Sarà «insicurezza percepita» anche la loro?