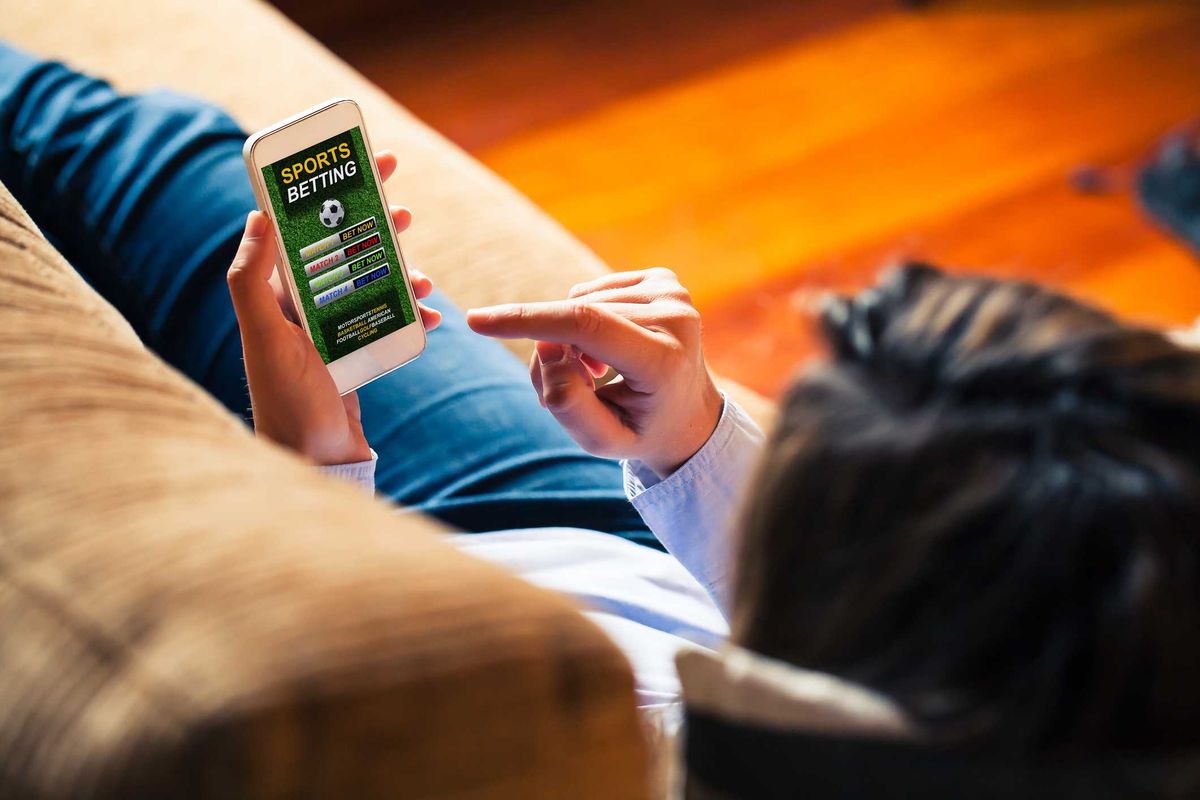2018-07-09
Grottaglie come Cape Canaveral per non avere un'altra Ilva in Puglia
True
La notizia dell'accordo siglato il 6 luglio tra l'Agenzia spaziale italiana e la Virgin Galactic di Richard Branson per ampliare la collaborazione sui futuri voli suborbitali ha fatto il giro del mondo in meno di una notte. L'obiettivo è rilanciare il sito aeroportuale dove già si fa ricerca aeronautica. La Regione cerca fondi per ampliare l'occupazione ed evitare che l'indotto vada in crisi come è accaduto a Taranto. Lo speciale contiene due articoliTrulli, taralli, mare e... astronavi. Forse saranno queste le attrazioni che renderanno celebre la Puglia alle prossime generazioni. Del resto i piloti dei biplani e dei dirigibili che nel 1916 decollavano dall'aeroporto di Grottaglie per difendere Taranto, mai avrebbero immaginato che poco più di secolo dopo quel luogo sarebbe stato candidato per diventare la Cape Canaveral italiana. La notizia dell'accordo siglato il 6 luglio tra l'Agenzia Spaziale Italiana e Virgin Galactic per ampliare la collaborazione sui futuri voli suborbitali ha fatto il giro del mondo in meno di una notte. Il patto, che ha visto il presidente dell'Asi Roberto Battiston firmare in presenza del fondatore di Virgin Richard Branson e del Ceo George Whitesides, mette nero su bianco l'intenzione dell'Asi di voler condurre esperimenti e validare strumenti di ricerca avvalendosi della presenza di uno specialista italiano a bordo dello Spaceship two, navetta suborbitale che Virgin group e l'americana Scaled composite hanno costruito e collaudato dal 2010 per poter realizzare l'impresa del turismo spaziale (600 biglietti venduti a 250.000 dollari ciascuno). All'incontro erano presenti il ministro Barbara Lezzi, il governatore pugliese Michele Emiliano e il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, oltre ovviamente agli amministratori delegati delle aziende coinvolte, Nicola Zaccheo di Sitael, Vincenzo Giorgio di Altec, Vito Pertosa di Angel Group.Tramite questa intesa l'Italia potrà sfruttare e applicare a nuovi progetti le conoscenze acquisite durante le missioni di volo, tra le quali l'uso della microgravità suborbitale per la formazione e l'addestramento di nuovi astronauti, ma anche per la ricerca biotecnologica e quella dei nuovi materiali. «Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello spazio», ha affermato Battiston. «La partecipazione dell'Asi a questa operazione è il chiaro segnale che l'Italia è in prima linea nella new space economy che rende lo spazio accessibile a più investitori. Non a caso, proprio due giorni fa, in occasione del trentesimo anniversario dell'ASI, abbiamo annunciato il lancio del primo fondo italiano per gli investimenti nello spazio. Il turismo spaziale, la manifattura spaziale, i servizi in orbita sono temi chiave del segmento spaziale di questo nuovo filone produttivo ed economico». Dal canto suo Whitesides ha confermato che la missione dell'azienda americana è proprio quella di rendere accessibile lo spazio a clienti commerciali sia per scopi scientifici sia di volo umano. Ma mentre la (troppa) politica che si infila in questi accordi è interessata alla cooperazione pubblico-privato per risparmiare sulla ricerca spaziale proprio mentre la domanda di sperimentazione sta crescendo, la comunità aerospaziale italiana, pur plaudendo all'accordo, ricorda come la Puglia non sia grande come il deserto del Mojave, dove Branson fa volare i suoi prototipi, e che intorno al tarantino passa la maggior parte del traffico aereo nelle rotte tra Nord e Sud Europa.Ma dopo vari e poco fortunati tentativi di rilanciare l'aeroporto di Grottaglie come scalo per i voli commerciali, l'infrastruttura ha trovato una sua vocazione in centro sperimentale per l'aerospazio con l'insediamento di alcune aziende del comparto. Tra queste Leonardo, Ids (Ingegneria dei distemi) e Piaggio Aerospace hanno insediato centri per lo sviluppo del settore unmanned, cioè i droni, grazie ai lavori di ampliamento che la società Aeroporti di Puglia aveva annunciato tra il 2015 e il 2017 grazie a un investimento di circa 2,3 milioni di euro fatto dall'associazione temporanea di imprese guidata dal consorzio Infratech.Il progetto, già approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, prevedeva la manutenzione straordinaria degli hangar 1 e 2 e l'ampliamento di alcuni raccordi e vie di rullaggio. Oggi a Grottaglie Boeing realizza parti della fusoliera del B787, mentre Piaggio Aerospace ha condotto i primi test di volo comandato via satellite del suo P1HammerHead, aeroplano senza piloti in classe Male (Medium Altitude, Long Endurance), che seppure sia di proprietà emiratina (l'azienda è al 100% del fondo Mubadala), tanto interessa a livello europeo per la Difesa e anche in ambito asiatico per il futuro trasporto merci automatizzato.In questo scenario tuttavia l'accordo Virgin-Asi prevede un primo volo suborbitale presso lo Spaceport America del Nuovo Messico nell'ultimo trimestre del 2019 e soltanto successivamente la possibilità di usare l'infrastruttura italiana che da aeroporto è stata battezzata "spazioporto" dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Enac nel maggio scorso grazie alla collaborazione con Altec, la società formata da Asi, Sitael e Thales Alenia Space, firmatarie della prima lettera di intenti con Virgin Galactic per fondare anche un'azienda italiana in grado di produrre navicelle spaziali e situata nel Mezzogiorno. L'Italia, che per lanciare i suoi satelliti ha sempre dovuto utilizzare la base di Kourou nella Guyana francese ora sogna il suo Grottaglie Space Center, una via di accesso per ricerca, per la messa in orbita di nano satelliti, per il nascente turismo spaziale, l'addestramento del personale specializzato e per la creazione di un polo attrattivo a carattere scientifico, una sorta di Cape Canaveral pugliese. L'aspettativa è elevata anche perché c'è bisogno di alzare il tiro dei finanziamenti se non si vuole rischiare altre crisi territoriali come quella dell'Ilva.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/grottaglie-come-cape-canaveral-per-non-avere-unaltra-ilva-in-puglia-2584594749.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="lagenzia-spaziale-italiana-ha-compiuto-30-anni" data-post-id="2584594749" data-published-at="1762657191" data-use-pagination="False"> L'Agenzia spaziale italiana ha compiuto 30 anni Giphy Era il 30 maggio 1988 quando il Piano Spaziale Nazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche si trasformava in «agenzia» per unire e coordinare tutte le attività nazionali che riguardassero lo spazio. Oggi l'ente ha un budget di 900 milioni di euro e sui programmi finanziati in ambito dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa, siamo i terzi contribuenti nell'Ue) ha visto un ritorno medio del 4%. Indietro di altri trent'anni e si torna alla messa in orbita del nostro primo satellite, il San Marco, prima impresa spaziale nazionale della storia concretizzato dall'opera del fisico Luigi Broglio, al quale è dedicato il centro spaziale Esa di Malindi, in Kenya. Nel corso dell'evento organizzato a Roma in occasione dei trent'anni dell'Asi sono emerse alcune trasformazioni in atto nell'organizzazione e nelle attività. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, starebbe valutando se esercitare direttamente il suo ruolo nel comitato interministeriale che ha il compito di disegnare la strategia spaziale nazionale oppure se delegarlo a un sottosegretario. Lo ha dichiarato all'agenzia Askanews l'ammiraglio Carlo Massagli, consigliere militare della presidenza del Consiglio, il quale guida l'ufficio che, in base alla legge sulla governance spaziale entrata in vigore lo scorso gennaio ma non ancora attivata dal nuovo esecutivo, è chiamato a supportare e coordinare il lavoro del comitato interministeriale. «Il Governo», ha aggiunto Massagli «pone molta attenzione verso questo settore. A breve daremo avvio all'implementazione di quello che prescrive la nuova legge».Il presidente Asi Roberto Battiston ha invece reso nota la creazione di un fondo di Venture Capital e il ritorno di un salone italiano nel settore spaziale, ma non tipo Le Bourget o Farnborough, bensì un evento presso la Fiera di Roma più focalizzato sulla space economy, settore nel quale è stata avviata una collaborazione con l'Università Bocconi. «In un settore così in rapido sviluppo e pieno di idee, iniziative, tecnologie e innovazione», ha dichiarato Battiston, «uno degli strumenti importanti per far crescere il settore è attirare capitali e volontà. Abbiamo deciso di realizzare in Italia un fondo di circa 80 milioni di euro di cui il 30% sarà capitale privato per identificare e investire nei progetti più promettenti».Sergio Barlocchetti