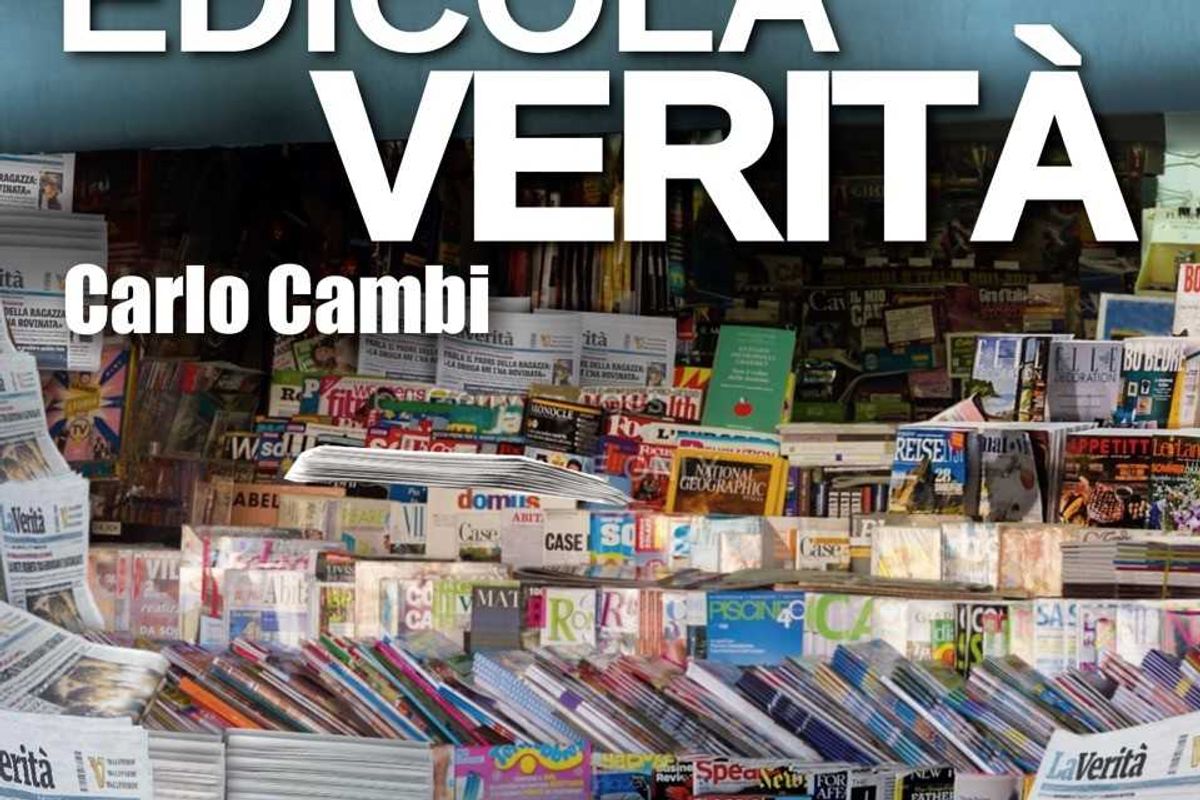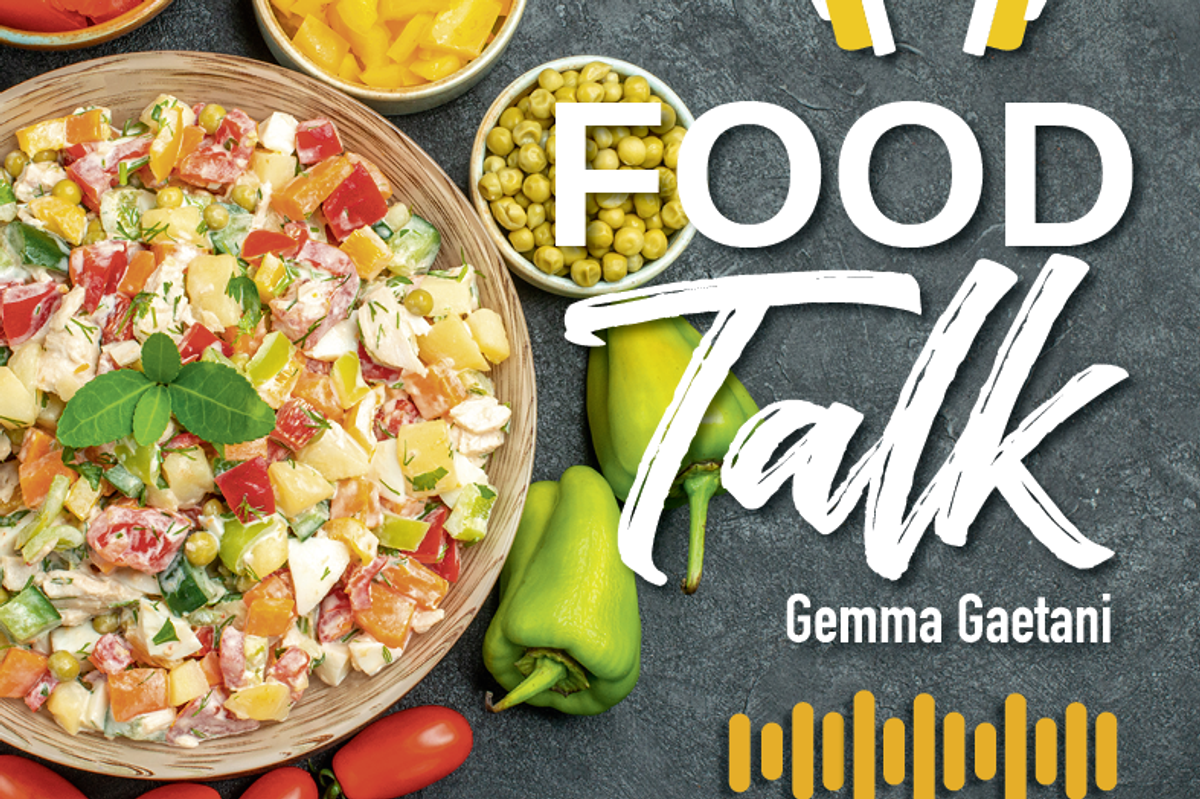S’è scoperto, leggendo il documento finale dell’accordo sui dazi, che Ursula von der Leyen ha firmato con Donald Trump, che una Mercedes val bene una bottiglia di Brunello di Montalcino. Il nostro governo spera ancora di poter riaprire la trattativa, ma è sicuro che Maros Sefcovic - il commissario europeo al Commercio - ha lavorato prima di tutto a mettere in sicurezza gli interessi della Germania. Tant’è che si è lanciato in una sorta di excusatio non petita: «I dazi su vino, alcolici e birra erano uno degli interessi più importanti dell’Ue. Purtroppo, non siamo riusciti. Nella dichiarazione congiunta però si afferma che entrambe le parti, gli Stati Uniti e l’Ue, sono pronte a valutare altri settori in cui potremmo abbassare i dazi in futuro».
Il fatto è che la vendemmia avanza (ottima per qualità, in quantità potrebbe essere più scarsa dello scorso anno e non è un male, ma là dove si è già tagliato, ad esempio in Oltrepò e Franciacorta per le basi spumanti e in Sicilia per i bianchi, i risultati qualitativi attesi sono alti) e che nelle cantine ci sono stoccati quasi 40 milioni di ettolitri di vino e gli indicatori dell’export sono in ribasso. A preoccupare è pure il calo della domanda interna e - qui si ritorna a guardare con sospetto a Bruxelles - la campagna anti alcol. Per i primi quattro mesi di quest’anno l’Istat ha certificato esportazioni complessive per 2,5 miliardi di euro in valore, in calo del 0,86% sullo stesso periodo 2024, e del 3,67% in volume, a 665.436.632 litri. Non è una disfatta, ma un campanello d’allarme considerando che il vino da solo vale 8,1 miliardi all’export ed è la prima voce del nostro agroalimentare, assai penalizzato dall’accordo sui dazi.
Nessuno lo rilevato, ma per una Dop come quella del Pecorino Romano (se ne vende in Usa per quasi 200 milioni) quello americano è di gran lunga il primo mercato. E anche per il vino gli americani sono il nostro primo cliente. Nel 2024 ne hanno comprato per 1,93 miliardi pari al 24% dell’export totale. Ebbene in giugno c’è stata la prima notevole flessione: l’export del vino italiano in Usa è diminuito in valore del 3,1% rispetto a giugno 2024. Ma è presto per stracciarsi le vesti perché complessivamente il primo semestre chiude quasi pari. Tuttavia le voci di allarme sono sempre più amplificate. La Coldiretti fa notare che le tariffe al 15% sui prodotti agroalimentari italiani senza alcuna esenzione rischiano di far perdere oltre 1 miliardo di euro alla filiera del cibo made in Italy, con vino, olio, pasta e comparto suinicolo tra i settori più colpiti, «confermando», nota Luigi Scordamaglia, ad di Filiera Italia, «come sia sempre l’agricoltura a essere sacrificata». Divulga conferma che gli Usa sono il primo mercato extra Ue dell’agroalimentare: nel 2024 ha sfiorato gli 8 miliardi di euro. Il prodotto più colpito sarà il vino che subirà dazi per un impatto di oltre 290 milioni, cifra che rischia di salire ulteriormente in base all’andamento del dollaro. Subito dopo c’è l’olio extravergine di oliva, dove i dazi porteranno un costo aggiuntivo superiore a 140 milioni. Colpita anche la pasta di semola, con quasi 74 milioni di euro in più. Stabili invece i formaggi, già gravati da dazi tra il 10% e il 15%. Più preoccupante è la stima che fa l’Unione italiana vini che misura un impatto per 317 milioni di euro (pari al 16,5 del fatturato del vino in Usa), mentre per i partner commerciali d’oltreoceano il mancato guadagno salirà fino a quasi 1,7 miliardi di dollari. Il danno salirebbe a 460 milioni di euro qualora il dollaro dovesse mantenere l’attuale livello di svalutazione.
Lamberto Frescobaldi che è presidente di Uiv afferma: «È ora più che mai fondamentale attivare un’alleanza tra la filiera italiana del vino e i partner Usa o il secondo semestre di quest’anno sarà molto difficile». Anche perché la fascia premium del vino - quella meno sensibile ai rincari - rappresenta solo il 4% dei 482 milioni di bottiglie che spediamo oltreoceano. Qui decisivi saranno gli accordi commerciali per ripartire tra produttori e importatori l’incidenza delle tariffe memori del fatto che l’ondata dei dazi del primo governo Trump (2019) significarono una perdita secca del 20% del mercato. Da Palazzo Chigi si è fatto osservare che «il governo resta impegnato, insieme alla Commissione europea e agli altri Stati membri Ue, per incrementare ulteriormente nei prossimi mesi, come previsto dalla dichiarazione congiunta, i settori merceologici esenti, a partire dal settore agroalimentare».
Per una preoccupazione sempre più evidente c’è però anche un dato soddisfacente: è dell’industria farmaceutica che temeva dazi assai più pesanti del 15%. Fa osservare Marcello Cattani - presidente di Farmindustria - che «quella raggiunta è la migliore soluzione ipotizzabile». Cattani ringrazia perciò Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Anche Stefano Collatina, presidente di Egualia (produttori di farmaci equivalenti), condivide la valutazione positiva, definendo la decisione «importante e lungimirante». Peccato che si faccia fatica a brindare a questo successo.