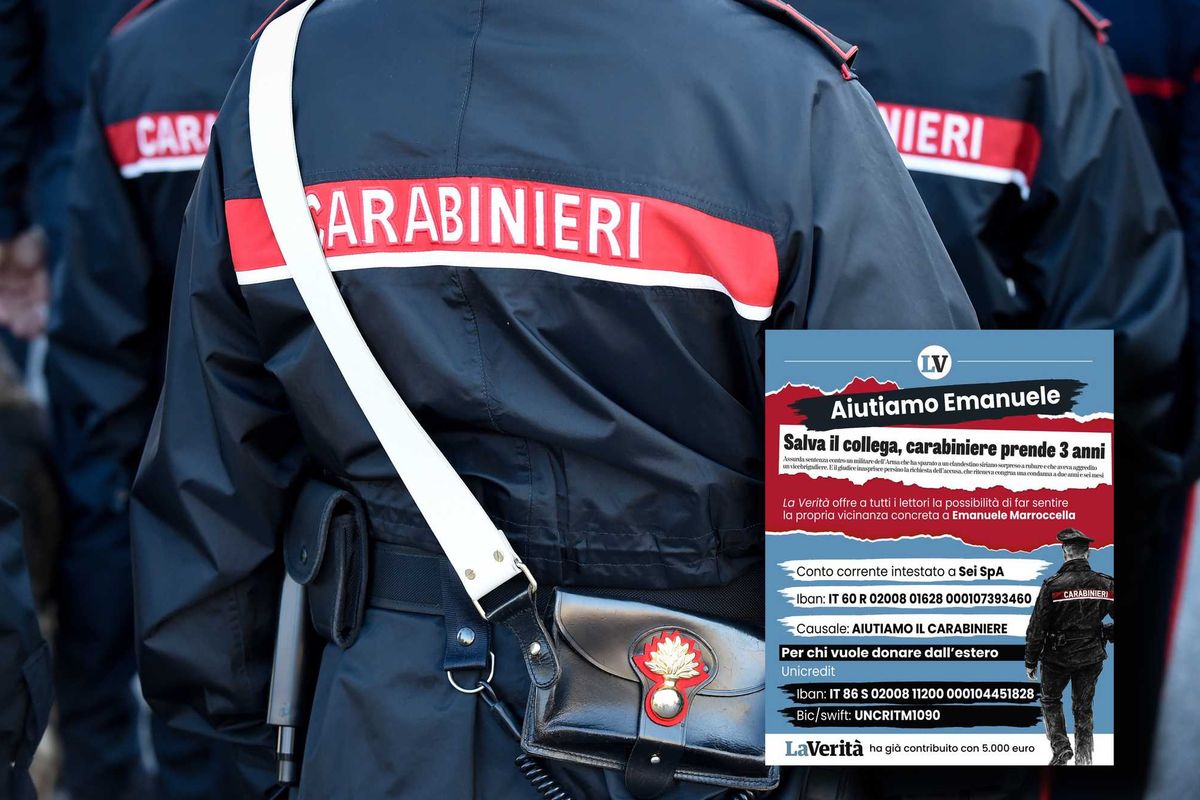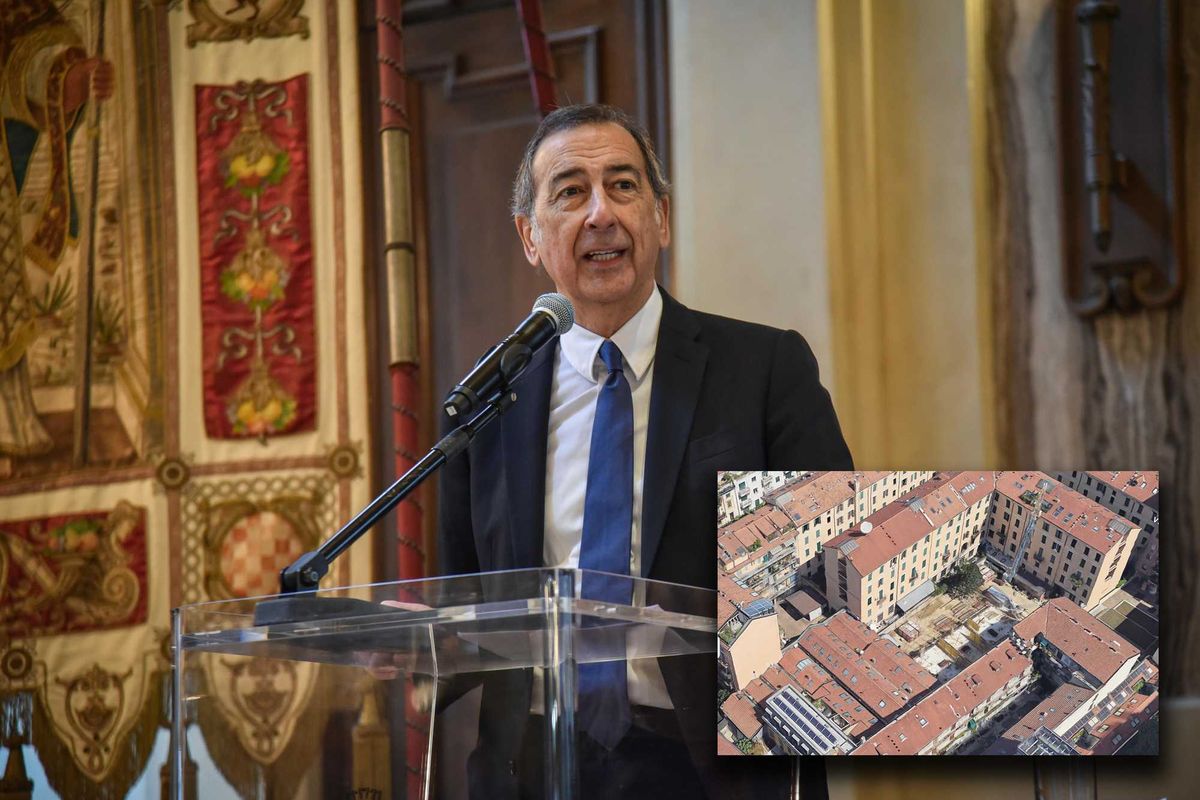Giordano Bruno Guerri: «Altro che “Unione”. Nell’Europa in crisi ognuno pensa per sé»

Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Vittoriale degli italiani, lei era stato individuato come uno dei papabili ministri della Cultura. Le è dispiaciuto per la mancata nomina?
«Avrei accettato l’incarico per senso del dovere, gusto della sfida e perché credo che avrei potuto fare qualcosa di buono. Ma per me è meglio così: la mia vita sarebbe stata devastata. Del resto, Gennaro Sangiuliano è un amico, è bravo e si muove molto meglio di me nel mondo della politica».
S’era parlato di un veto della Chiesa nei suoi confronti: lei è troppo libertario.
«Non ne so niente. Secondo me Giorgia Meloni ha voluto una squadra compatta, senza tiratori liberi. Basta Vittorio Sgarbi…».
Il governo sta lanciando dei segnali. Il pugno duro con le Ong, ad esempio, ha sollevato il velo su un’ipocrisia europea: accordi di redistribuzione solo formali, mentre l’Italia si accolla il peso degli sbarchi. Questa strategia funziona?
«In campagna, la Meloni ha annunciato il suo futuro governo con lo slogan: “Siamo pronti”. Essere pronti significa avere un programma. E il programma di un esecutivo nuovo, di centrodestra, non può che essere decisionista. Decisioni sono state prese, benché sia presto per stabilire se giuste o sbagliate. Tutti i governi del mondo, comunque, nei primi 100 giorni godono - o soffrono - di un attivismo particolare».
È scongiurato il rischio di una Meloni troppo schiacciata sul draghismo?
«A me, una Meloni che ripercorra la strada di Mario Draghi non dispiacerebbe affatto. In questo momento ci occorre proprio un governo molto attento all’economia e rispettabile nel mondo».
Be’, il braccio di ferro con Parigi ha avuto l’effetto opposto a quello che forse qualcuno si aspettava: a finire isolato non è stato il governo «sovranista», che ha invece compattato i mediterranei Cipro, Grecia e Malta, bensì il governo francese. Germania e Spagna hanno respinto l’appello dei transalpini a interrompere le intese con l’Italia.
«Sui migranti andava presa una posizione netta. Non è possibile che la maggior parte del peso degli arrivi degli extracomunitari illegali sia sopportato dall’Italia. Il problema andava posto. È stato posto magari in un modo drammatico, sulla pelle di povera gente. Ma questa povera gente è stata tutta messa al sicuro, o in Italia o in Francia».
Emmanuel Macron ha fatto autogol?
«La reazione della Francia è stata soprattutto di sorpresa verso la mossa inaspettata e insolita di Roma. Ed è dovuta a problemi politici interni di Macron, che patisce un’opposizione fortissima sia da destra sia da sinistra. Lo avrebbero fatto nero, se non si fosse opposto a nuovi sbarchi».
Chi ci impartisce lezioni di umanità, comunque, randellava i migranti alla frontiera, a Ventimiglia e a Bardonecchia.
«Questo è abbondantemente dimostrato da immagini drammatiche. La Francia ha sempre avuto norme e comportamenti rigidissimi e adesso si mette a fare la buonista. Anzi, non si tratta nemmeno di buonismo: ci chiede di rispettare vecchie regole, che però vanno cambiate. Il Trattato di Dublino va ridiscusso».
In tutto ciò, la grande assente continua a essere l’Europa?
«Faccio una premessa. Insieme alla grande Ida Magli, a metà degli anni Novanta, fondai un movimento che si chiamava Italiani liberi: era il primo movimento anti europeista del nostro Paese. Da noi, all’epoca, l’Europa era considerata sacra, parlarne male era impossibile. All’estero, invece, c’erano già 48 movimenti antieuropeisti».
Quindi?
«La nostra critica era culturale: ritenevamo che non si potessero unire popoli con storie diverse su base economica, creando un governo che governasse i governi».
A Bruxelles si straparla di solidarietà, ma sui dossier concreti, dall’energia all’immigrazione, non si trova una quadra. E stanno persino proliferando trattati bilaterali tra gli Stati fondatori. L’Unione dov’è?
«A mio parere, la situazione è anche più grave. Certo, in materia economica, pure io mi sono dovuto arrendere: non proporrei mai più di uscire dall’Unione europea, sarebbe una rovina».
E allora?
«L’Ue si è fondata sull’economia, ma proprio sull’economia sta fallendo: lo abbiamo visto, appunto, sul tetto al prezzo del gas, come su decine di altri dossier cruciali. In questo senso, il problema dei migranti è marginale».
Be’, per noi mica tanto.
«È più appariscente. La gente discute di spartizione dei migranti, non se la Germania stanzia 200 miliardi per il caro energia. Ma è grave che, in momenti di crisi, ognuno cerchi di salvare sé stesso, agendo per i fatti propri. Questa non è un’unione; è una divisione».
Giulio Tremonti diceva che il peccato originale dell’Ue è stato non inserire mai la parola «crisi» nei trattati. Concorda?
«Certo: le crisi, al contrario, vanno previste, perché sono inevitabili».
Sarebbe giusto tentare di costruire un’egemonia culturale di destra, per soppiantare quella di sinistra?
«No: sarebbe lo stesso errore a rovescio. La cultura non può essere di destra o di sinistra, non può essere sezionata come una torta: ne uscirebbe mutila. La cultura vive a 360 gradi».
Difficile mantenere un respiro così ampio, sotto la cappa del politicamente corretto.
«L’indicazione di un pensiero unico è un fenomeno pericoloso, che non riguarda solo l’Italia, ma l’intero Occidente. Adesso si parla tanto di pericolo fascista, ma il pericolo fascista non è quello dei manganelli e delle camicie nere».
E qual è?
«È il pericolo di controllo sempre maggiore sulla cultura dei cittadini, praticato attraverso il politicamente corretto, ma anche tramite gli algoritmi, le multinazionali, le decisioni assunte a livello mondiale, dalle istituzioni sovranazionali».
È il caso di chiamarlo proprio fascismo? Shoshana Zuboff, a proposito della pervasività degli algoritmi, parla di capitalismo della sorveglianza.
«Usavo l’etichetta di “fascismo” solo per intenderci. Il riferimento alla sorveglianza è calzante».
Quando lei fu assessore in Calabria, a Soveria Mannelli, prese la delega al «Dissolvimento dell’ovvio». Cosa significava?
«Smembrare le idee ricevute, le convenzioni, le abitudini, le cose ripetute per stanchezza e desiderio di normalità. La cultura non dovrebbe essere solo conservazione dei beni, ma anche innovazione delle idee».
Una sfida alla retorica e al conformismo?
«A Soveria Mannelli organizzai la prima notte bianca d’Italia. La chiamai Smoc, Soveria Mannelli orario continuato. Ma anziché farla di sabato, la feci di lunedì».
Come andò?
«Strepitosamente: un paesino sulla Sila tutto sveglio, tutti felici come una Pasqua. Un altro momento di dissolvimento dell’ovvio fu il monumento al cassonetto».
Ci racconti.
«Avevano messo i cassonetti nel punto più bello del paese, sul belvedere. E non li volevano togliere per comodità. Allora presi il più brutto, il più rovinato e lo misi in mezzo a un’aiuola. Vi piacciono i cassonetti? Va bene, facciamone monumento… Fu allora che si convinsero a spostarli».
Sgarbi vorrebbe i musei gratis, Sangiuliano no. Lei come la pensa?
«Lo Stato ha il dovere di favorire l’ingresso dei cittadini nei musei. Il principio della gratuità, dunque, è giusto, ma non come si fa oggi: la prima domenica del mese, per tutti, milionari inclusi».
Qual è la soluzione?
«Il Vittoriale, essendo privatizzato, non aderisce alle domeniche gratis: sarebbe una rovina economica, senza finanziamenti pubblici. Abbiamo la facoltà di decidere in proprio e l’aumento dei nostri visitatori dimostra che la nostra politica è giusta. Ecco, io credo che anche un museo statale dovrebbe poter scegliere quando concedere l’ingresso gratuito. È l’approccio statalista quello che non funziona».
Lei contesta il «pensiero in blocco»: se sei di destra, tutti si aspettano che tu assuma certe posizioni. Mancano le nuances?
«È la politica trasformata in tifo: la mia squadra ha sempre ragione».
Questa deriva sta deteriorando la qualità delle nostre democrazie?
«Direi che le cose sono sempre andate così. Certo, è una logica deleteria, un modo d’intendere la politica inelegante e grossolano, perché all’avversario bisognerebbe dare atto quando ha ragione, o almeno accettare le sue scelte».
Forse, negli ultimi anni si è verificato uno scatto ulteriore: prima si era d’accordo su cos’era la realtà e non sul modo di gestirla. Oggi, si fatica persino ad accordarsi su cosa sia un «fatto». Sembra esserci una totale incomunicabilità tra certi settori della società.
«Pure questo è sempre successo. È che oggi ci sembra tutto amplificato a causa dei social: riceviamo i pareri di tutti, come se visitassimo simultaneamente tutti i bar e tutte le famiglie d’Italia. Però bisogna prestare attenzione a un dettaglio».
Che dettaglio?
«Nei bar e nelle famiglie d’Italia si applica quella varietà di opinioni che gli esponenti di partito non sono in grado di assumere. La gente è capace di uscire al di fuori dello schieramento per cui vota. I politici no».