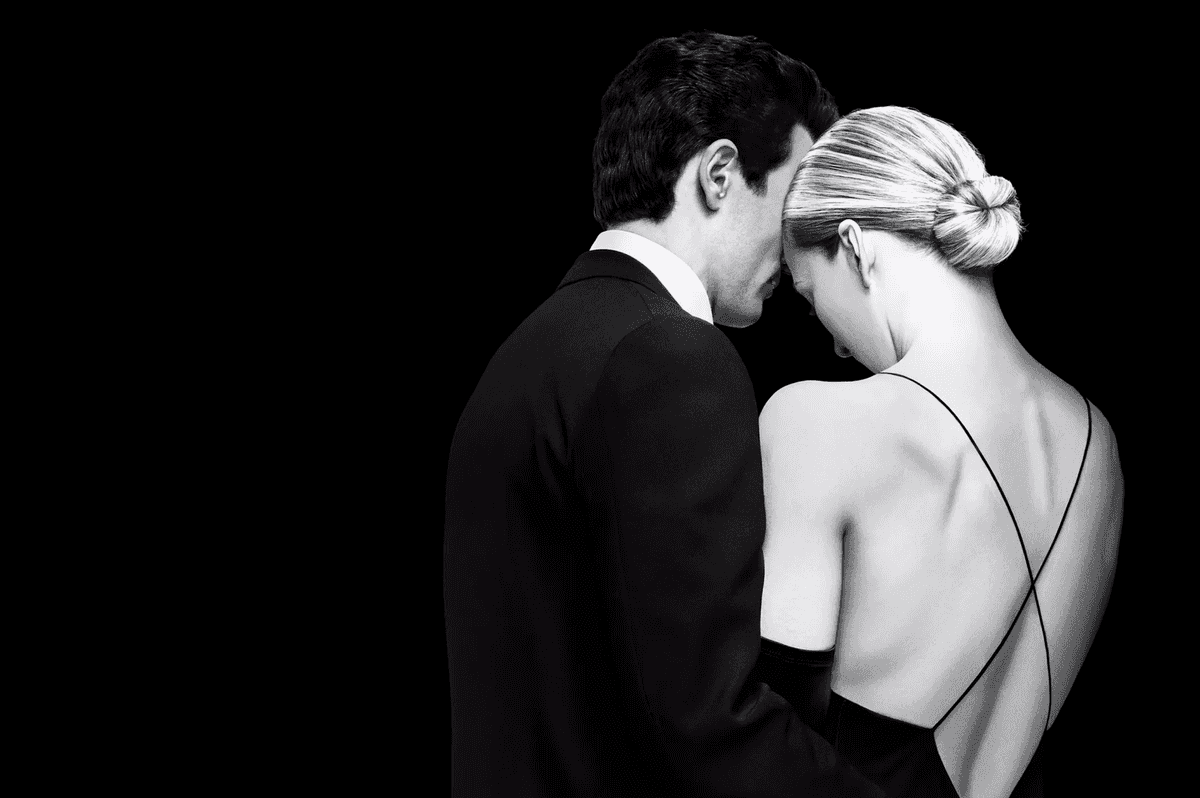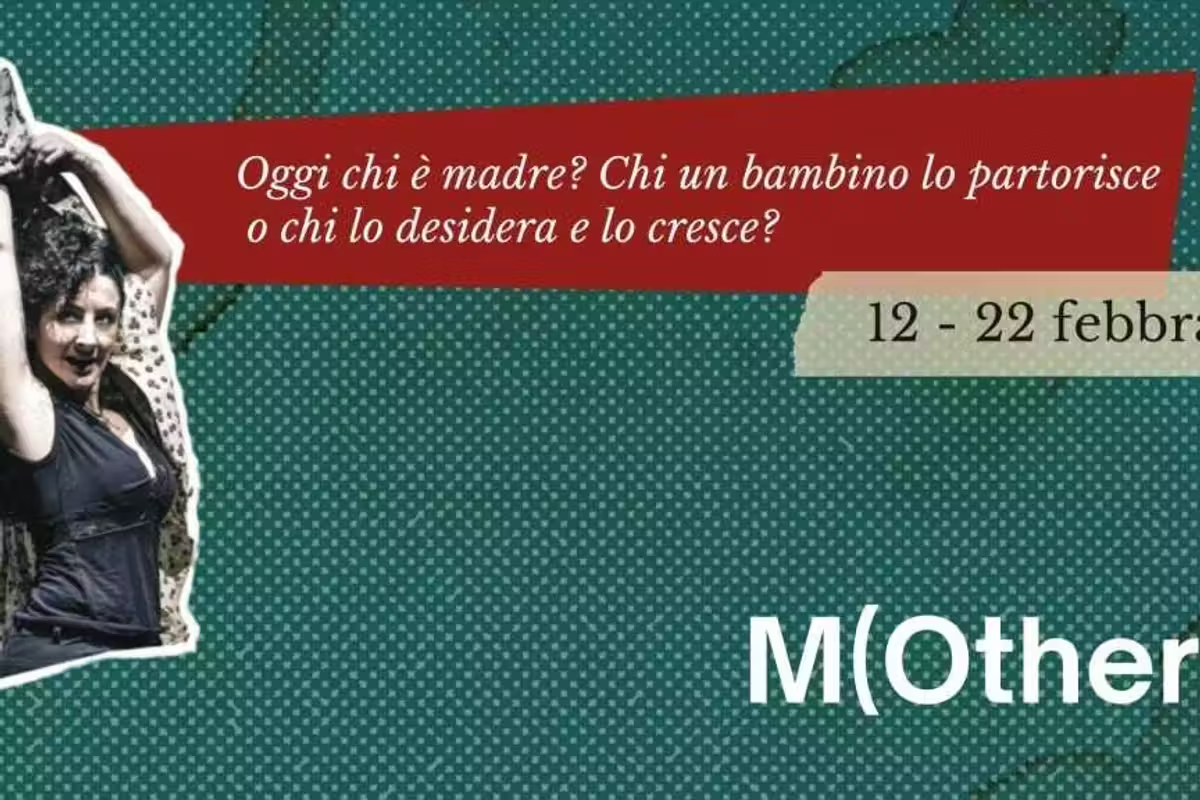I cugini d’Oltralpe hanno fatto saltare gli accordi di Minniti sui flussi dalla Libia

Nel 1930 i francesi costruirono un forte in Niger, vicino ad Agadez e a due passi dalla Libia. All’epoca venne tirato in piedi per fermare l’espansione italiana dalla Libia al Fezzan e poi a Sud nel Sahel. A distanza di quasi 100 anni, l’Europa è cambiata così tanto che adesso i ministri francesi, se vogliono (grazie al Trattato del Quirinale), possono partecipare ai nostri cdm. Ma in Africa i cambiamenti sono diversi.
Il forte esiste ancora e al suo fianco è stata costruita una moderna base militare che, inserita in un programma congiunto Ue avrebbe dovuto ospitare fino a 500 nostri militari. Cosa praticamente mai avvenuta. Il condizionale è d’obbligo perché le vicende successive al 2018 hanno travolto i vecchi equilibri. L’ascesa di Khalifa Haftar in Cirenaica, il potenziamento del terzo incomodo di Misurata e soprattutto l’arrivo di turchi e russi nell’area hanno destabilizzato l’intero deserto e cancellato (in Mali) o drasticamente ridotto (in Niger, Burkina Faso e Mauritania) il potere francese. Ma la base Madama vicino al forte in realtà è servita sempre per contenere qualunque avanzata italiana nell’area.
Come? Semplice evitando di fermare i flussi di migranti verso Nord e quindi diretti alle coste dell’Europa via Italia. Nel forte Madama la missione dei legionari era quella di contrastare le mosse dei jihadisti. La base militare è, però, posta su una strada carovaniera. Nel 2016, sotto gli occhi dei militari francesi, sono passati, secondo fonti Iom, qualcosa come 291.000 migranti. Nessuno è mai stato fermato o controllato, nonostante le dotazioni della base: dai Mirage ai droni. Nessuno si è mai premurato di bloccarli nel tratto più a Nord, nel Fezzan. Dove, già durante l’era di Muhammar Gheddafi, c’era una certa anarchia e dopo la sua uccisione è scoppiata una faida tribale dal nome singolare: «guerra della scimmia». Guerra dai duplici risvolti. Da un lato il tentativo, da parte delle milizie basate sulla costa, di ampliare la propria influenza nelle aree meridionali attraverso una strategia di alleanze variabili con le tribù del Fezzan. Dall’altro sulla «tradizionale conflittualità tra Tebu e Tuareg si innesta così una dimensione di scontro ulteriore, che vede nelle due fazioni un’estensione, rispettivamente, dell’Enl e del governo di Tripoli», si legge in un interessante report del Cesi. Dinamica dispiegata nell’evoluzione degli scontri della zona di Sebha. In una prima fase, tra il 2012 e il 2014, la contrapposizione verteva essenzialmente sul controllo dei traffici e vedeva schierate da un lato le tribù Tuareg e Awlad Suleiman (che nel 2011 avevano combattuto contro Gheddafi) e dall’altro quelle Tebu e Qadhafa (quest’ultima è la tribù di origine del Colonnello e lo ha difeso fino agli ultimi giorni della rivolta). «Il rapporto di forza è sensibilmente mutato con l’arrivo della potente milizia di Misurata che ha preso il controllo delle basi militari di Brak al-Shati e Tamenhint», scriveva sempre il Cesi all’inizio del 2017. Formalmente inviato con la funzione di arrestare gli scontri, il gruppo misuratino ha di fatto appoggiato gli Awlad Suleiman, eminenza del luogo, con il duplice scopo di garantire riaprire i collegamenti logisitici e indebolire gli avversari. In questo complicatissimo scenario vanno inseriti gli accordi targati Marco Minniti, l’abile ministro dell’Interno che ha cercato di inserirsi a metà strada tra la costa e la presenza militare francese. Va ricordato che la dottrina di Parigi è sempre stata basata sulla presenza militare. La nostra purtroppo no. Così Minniti ha giocato di sponda. L’intento era quello di trovare qualcuno in grado di regolare i flussi. A gennaio del 2017 i primi abboccamenti e poi a marzo la firma tra l’Italia e una sessantina di capi tribù. Denaro, protezione e sostegno in loco. Ad aprile i flussi registrati verso l’Italia erano ancora in forte crescita. Oltre un 40% in più rispetto allo stesso mese del 2016. A luglio è iniziato il calo. Dai 23.000 dello stesso mese 2016 a poco più di 11.000. Un trend rimasto calante per tutto l’anno. Al tempo stesso, gli sbarchi sulle coste della Spagna aumentarono di oltre il 100%.
Ovviamente non è possibile sigillare i confini, ma indirizzare i flussi sì. Purtroppo non è stato possibile scoprire sul lungo termine gli effetti della mediazione dell’ex esponente Pd. Perché qualcuno è intervenuto per farli saltare: i francesi, ovviamente. Parigi, all’epoca, tramite alcuni giornali, accusò l’Italia di fare accordi sottobanco. Cioè esattamente quello che i francesi fanno da secoli. Da lì l’idea di scardinare pezzo a pezzo ciascuno dei 60 sotto accordi firmati. Il motivo dell’intervento contro la nostra sicurezza nazionale si spiega per un semplice motivo. L’altro lato della medaglia dell’accordo in Fezzan era un aumento della presa italiana nella regione, come abbiamo scritto sopra, fondamentale per lo scontro tra Tripoli e Bengasi. Questo non è piaciuto e da lì l’intervento che in quegli anni il premier di allora, Paolo Gentiloni, si è ben guardato dal denunciare per evitare il rischio di veder diminuire a Roma o nell’Ue il numero di chi sfoggia la Légion d’honneur.
Il resto è cronaca quotidiana. Sbarchi dopo sbarchi. E quindi alle repliche stizzite dei francesi, finti sostenitori dei diritti dei migranti, si risponde solo in un modo. Riprendendo a siglare accordi in Africa. Va bene sia sopra che sotto il banco.