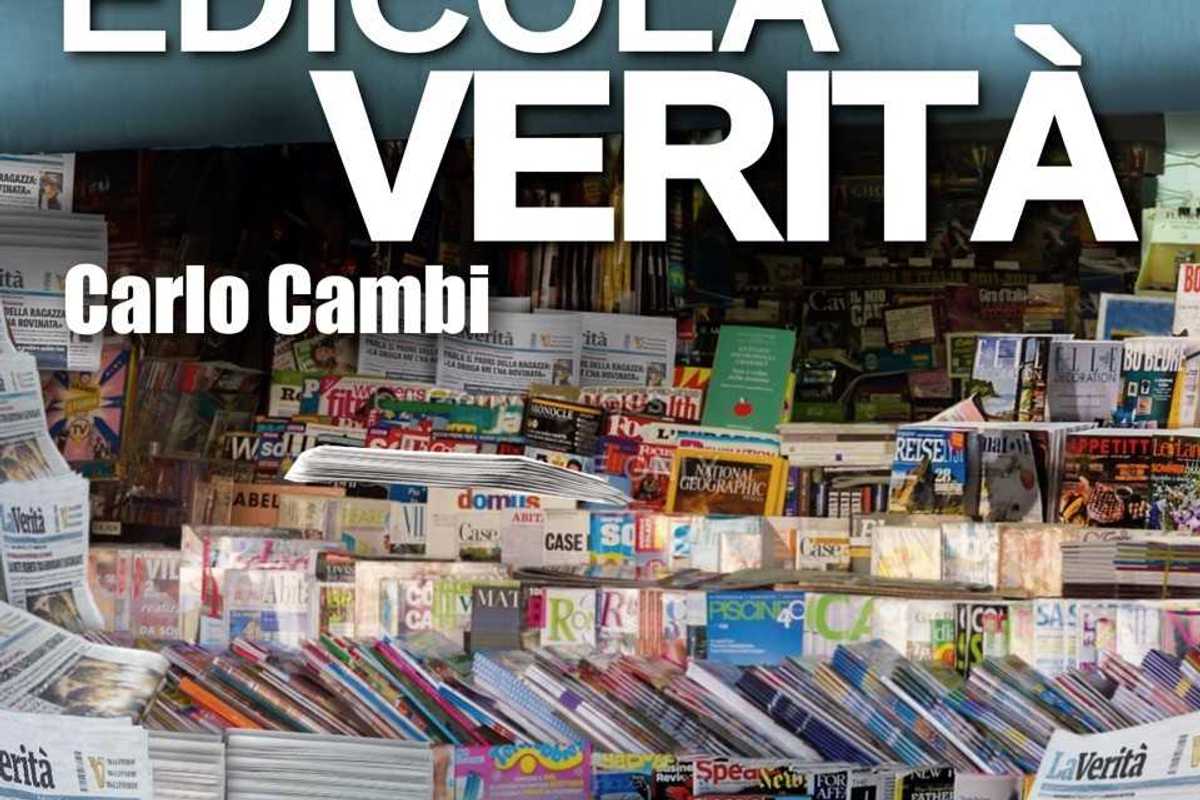Vittorio Sgarbi: «Evola è un diamante tra i depensanti. Per questo è escluso»

Solo Vittorio Sgarbi poteva riuscire in un’impresa del genere: portare al grande pubblico le opere di uno dei pensatori più straordinari ma anche più odiati che l’Europa abbia avuto. Julius Evola (1898-1974) è un autore che la «cultura ufficiale» continua a considerare sulfureo, impresentabile, maledetto. Sgarbi ha avuto l’idea di dedicargli una imponente e splendida mostra al Mart di Rovereto, aperta fino al 18 settembre. Si intitola Julius Evola. Lo spirituale nell’arte (a cura di Beatrice Avanzi e Giorgio Calcara), e va dritta al cuore. «Intanto, a Trento, si apre la grande mostra di Banksy», rilancia subito Sgarbi.
Banksy è un artista «mainstream», va molto di moda.
«Questa mostra è interessante, anche considerando la popolarità di Banksy e la sua dimensione di artista che interpreta istanze che potremmo definire populistiche, molto condivise da un’umanità che procede per ovvietà. Certo, Banksy dice anche cose giuste relativamente alla società dei consumi, alla violenza del potere che fa la guerra. In fondo in un tempo come questo, in cui abbiamo guerrafondai dappertutto, è evidente che una posizione come la sua può sembrare persino meno popolare di quanto sia stata fino a qualche giorno fa».
Veniamo a Julius Evola.
«Julius Evola è esattamente l’opposto di Banksy. È un artista che è stato condannato, umiliato, messo in carcere, processato e poi assolto. Evola fu accusato di golpe in un’epoca in cui il fascismo era stato ripudiato, ma in cui alcune componenti fasciste venivano tutto sommato tollerate. L’antimodernismo di Evola, invece, non poteva essere tollerato. Questo ha fatto sì che egli abbia vissuto fino a poco prima di morire in una dimensione di assoluta esclusione».
Non è stato l’unico...
«Sì, ma per altri è stato diverso. Prendiamo i futuristi. Il futurismo ha avuto uno sviluppo durante il fascismo, ma di Marinetti tutti noi parliamo ancora oggi. E questo vale anche per Depero, grande futurista recentemente celebrato da una mostra».
Di Evola invece parlano in pochi, i suoi cultori più arditi.
«Evola ha lavorato come pittore tra il 1915 e il 1922, in tempi che, con una brutta forma, si potrebbero chiamare “non sospetti”, perché il fascismo non c’era ancora. Eppure l’opera pittorica di Evola è stata completamente rimossa. Tanto che questa è la prima mostra pressoché completa della sua opera, che era già stata sdoganata e riproposta da un critico certamente non di destra, ma con una struttura mentale che gli consentiva di vedere oltre il pregiudizio e il paraocchi dell’ideologia. Evola era stato riscoperto da Enrico Crispolti, che gli dedicò una mostra nel 1963».
Come andò?
«Nel 1959 ci fu un incontro memorabile tra Crispolti e questo strano personaggio che se ne stava sempre chiuso in casa. Crispolti andò a vedere le opere di Evola e capì che erano rivoluzionarie, gli parlò ma egli gli rispose in maniera molto turbata. Poi arrivò il gallerista Claudio Bruni, che era impegnato a ricostruire i fenomeni del secondo futurismo, e i due stabilirono di fare una mostra, in cui furono esposte opere di Evola che sarebbero poi state acquistate dai musei civici di Brescia, i primi a esporre in uno spazio pubblico lavori dipinti cinquant’anni prima. Insomma, siamo di fronte a un ritardo storico molto singolare».
Un altro grande intellettuale che non ebbe paura di Evola fu Vanni Scheiwiller.
«Fu un grandissimo editore. Aveva pubblicato cose molto sofisticate, era parente dello scultore Adolfo Wildt, che a sua volta fu riabilitato molto tardi. Grazie a Scheiwiller ci fu la prima rottura del muro di silenzio che aveva nascosto Evola fino all’inizio degli anni Sessanta, quando fu pubblicato Il cammino del cinabro, il suo testo autobiografico poi ristampato da Edizioni Mediterranee. Possiamo dire che a Evola non sia stato perdonato nulla».
Forse non gli è stato perdonato - più di tutto il resto – il tradizionalismo. Evola era ostile alla modernità. Mentre il futurismo guardava alla macchina, il suo sguardo era rivolto altrove. Questo lo ha reso più indigesto?
«C’è da dire che il futurismo è stato così eversivo che alla fine non ha patito poi molto, per mille ragioni. Ha incrociato la modernità, ed è passato tutto sommato indenne dalla fase fascista. Di recente ci sono state alcune grandi mostre che gli hanno dato pieno riconoscimento. Evola era vicino ai futuristi, ma li considerava piuttosto superficiali. Aveva verso di loro un atteggiamento di superiorità intellettuale. Dopo tutto il suo collegamento con la comunità internazionale era molto più vasto di quello dei futuristi, egli aveva rapporti con Duchamp, con Cocteau, con Tzara. C’è una singolare corrispondenza diretta tra l’inventore del dadaismo ed Evola. Il quale in effetti iniziò col futurismo, ma poi notò che - a parte l’elemento rivoluzionario - il futurismo aveva inclinazioni che poco c’entravano con le sue. Del futurismo Evola disse che lo infastidiva “tutto il lato chiassoso ed esibizionistico, una grezza esaltazione della vita e dell’istinto”. Ed è meraviglioso che lui rinneghi i futuristi non durante il fascismo, ma subito, nel 1920 e nel 1921. Fu lì che entrò in rapporti con Tzara, a cui nel 1920 scrisse: “Aderisco con entusiasmo al dadaismo al quale senza saperlo mi ero avvicinato già da tempo in tutte le mie opere e che dichiaro essere il più importante movimento originale che sia comparso fino ad oggi nell’arte”».
A ben vedere il dadaismo coltiva l’elemento spirituale caro a Evola, sfugge al «regno della quantità» moderno per muoversi in altre direzioni.
«Questo è uno dei motivi per cui ho pensato che fosse opportuno mostrare l’intera opera di Evola, perché secondo me si tratta di un fenomeno che appartiene non tanto al futurismo quanto all’astrattismo di Kandinskij, pittore tra i più ammirati e amati. Il che è paradossale: Kandinskij così vicino a Evola, eppure quest’ultimo è stato ignorato mentre il russo è considerato il grande della modernità. Il saggio fondamentale di Kandinskij si chiama Lo spirituale nell’arte. Io ho voluto mutuare il titolo e chiamare così la mostra di Evola. Ho voluto in questo modo innalzare la valutazione di Evola, attraverso il dadaismo di Tzara, fino al livello di Kandinskij».
Noto però che, ancora desso, non è così facile parlare di Evola, dargli visibilità.
«Anche questa mostra purtroppo è stata tenuta in un ghetto, mentre altre vengono celebrate e recensite con trionfalismo. Si potrebbe pensare che questo sia il destino metafisico del povero Evola, anche se le sue opere sono un capolavoro di pittura astratta. Tra l’altro, io sono un critico che ha sempre guardato con sospetto l’arte astratta, non quella primordiale, non quella di Kandiskij… Ma quando un artista contemporaneo fa l’astratto mi sembra che sia una scorciatoia. Ebbene, nonostante questo ho consacrato il capofila di un movimento che ha portato tanta ovvietà nell’arte cosiddetta contemporanea: quell’arte viene da un uomo che era tutto meno che ovvio, di una cultura straordinaria, che è stato un pensatore, un mago, un alchimista».
Il pensiero e le opere di Evola, oggi, come ci parlano?
«Il suo pensiero assomiglia a quello di José Bergamin, che scrisse un libro intitolato Decadenza dell’analfabetismo, come a dire che l’analfabetismo fosse una forma di cultura rispetto all’ovvietà del pensiero oggi predominante. Quello attuale è un mondo di idioti, gente senza testa che non ha pensiero: dei depensanti. In un mondo di depensanti, chi pensa viene considerato pericoloso. Evola era guardato così, nonostante fosse una delle personalità più originali del Ventesimo secolo».
A qualcuno succede anche in queste ore di essere guardato in quel modo.
«Oggi penso a Massimo Cacciari, che non è in sintonia con il pensiero dominante. Nel passato, Indro Montanelli ha vissuto un lungo periodo in cui è stato considerato un demente reazionario finché non ha ceduto alla sinistra voltando le spalle a Berlusconi. Montanelli ha avuto questa trovata finale particolarmente efficace sul piano del marketing, quella di ribellarsi a un padrone che non era mai stato un padrone. Io lo ho attaccato come nessuno, per questo motivo, e ne sono orgoglioso. Evola invece, come un diamante puro, non ha mai ceduto di un millimetro rispetto alle sue posizioni».