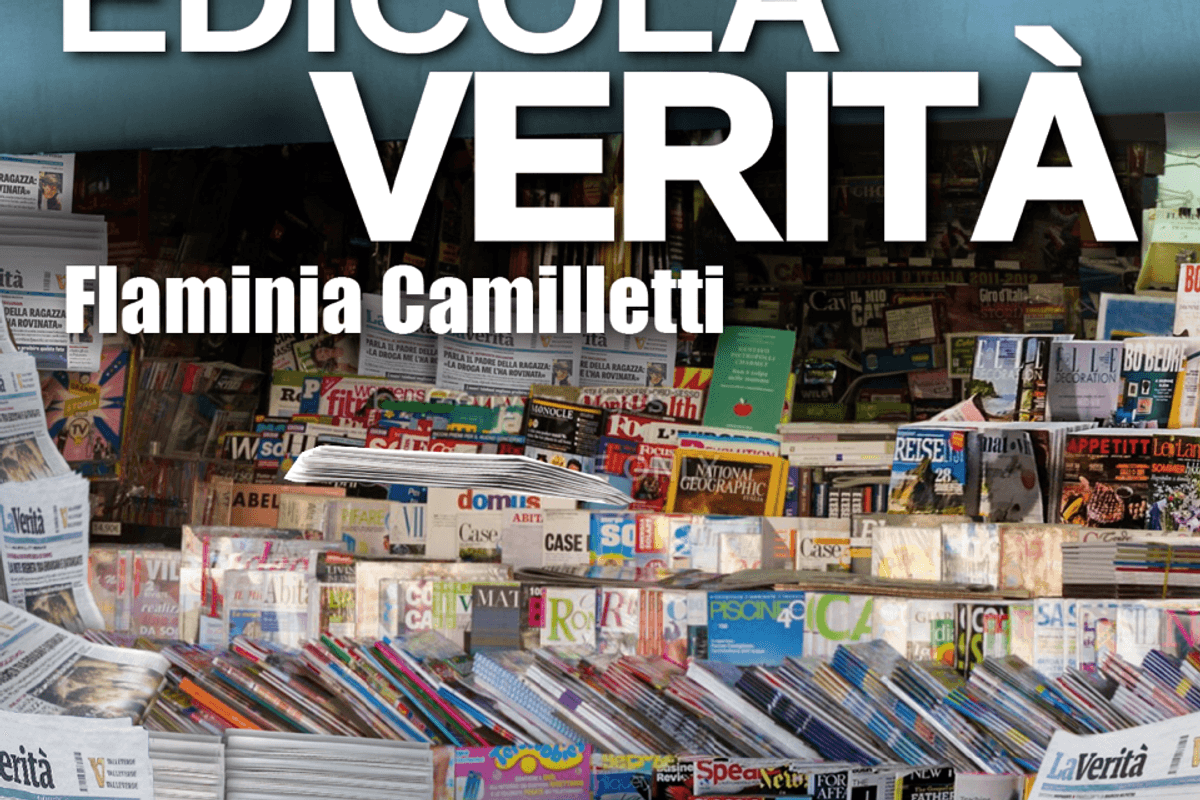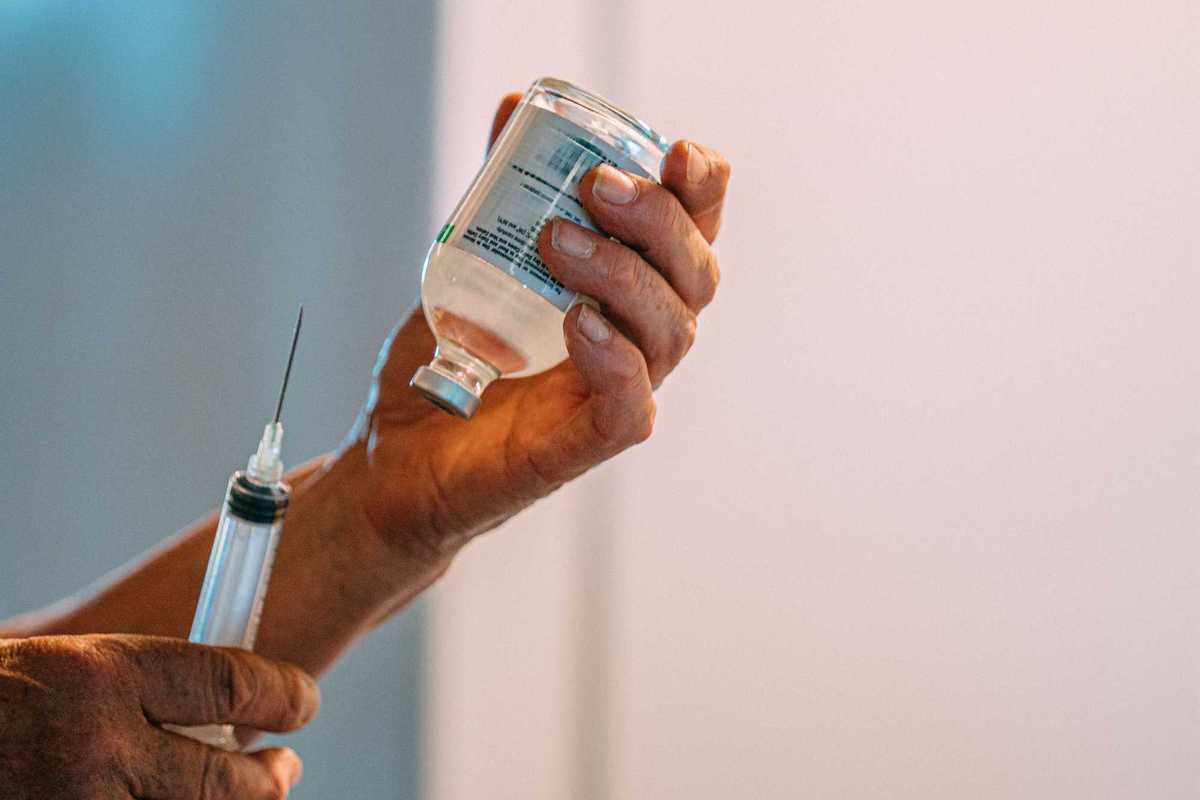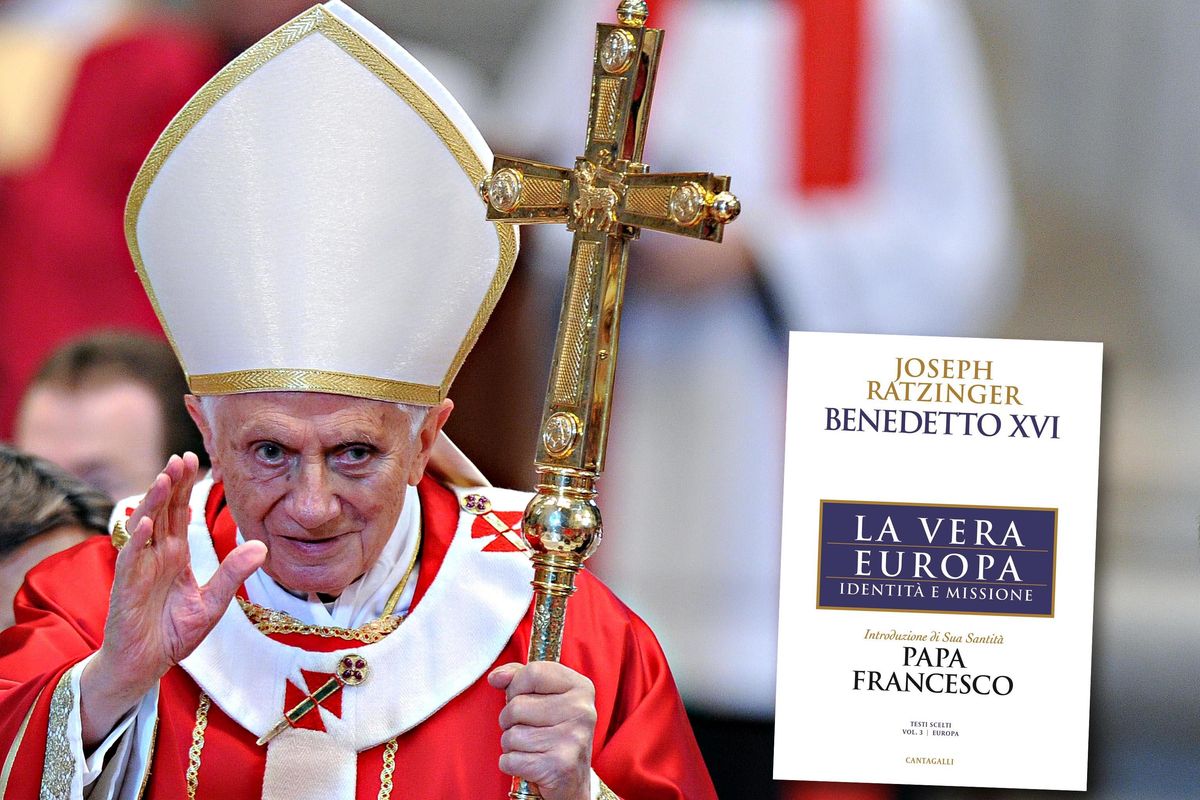
L’Europa è, come parola, come idea geografica e spirituale, una creazione dei greci. Già il vocabolo in sé è significativo: si rifà probabilmente alla comune definizione semitica per sera (ereb) e rimanda quindi a quel fatidico dialogo dello spirito semitico con quello occidentale che appartiene all’essenza dell’Europa. Lo spazio delimitato dalla parola si amplia progressivamente dal punto di vista geografico: dapprima esso comprende solo l’area della Tessaglia, della Macedonia e dell’Attica, ma già in Erodoto, nella suddivisione delle tre parti della terra – Europa, Asia e Libia – figura come una delle tre grandi zone geografiche e culturali che sono contigue nell’area del Mediterraneo. L’Europa sembra perciò costituita innanzitutto di spirito greco. Se dimenticasse la sua eredità greca, non potrebbe più essere Europa. [...]
L’eredità cristiana
Il vescovo Graber ha fatto notare che nel racconto della Pentecoste in Luca (At 2,11), nell’enumerazione dei popoli che rappresentano la terra, in un primo momento vengono nominati soltanto quelli asiatici. Solo quasi all’ultimo posto si parla anche di «stranieri di Roma». Il punto di partenza del Vangelo si trova allora in Oriente. Luca sottolinea (come anche Giovanni e tutto il Nuovo Testamento) la radice rappresentata da Israele: la salvezza viene dai giudei (Gv 4,22). Ma Luca aggiunge una strada che apre una nuova porta. La strada che mostrano gli Atti degli Apostoli conduce da Gerusalemme a Roma; è la strada verso i pagani che distruggeranno Gerusalemme, ma che pure la riprenderanno in sé in un nuovo modo. Il cristianesimo è quindi la sintesi, operata in Gesù Cristo, tra la fede di Israele e lo spirito greco. Wilhelm Kamlah ha descritto tutto ciò in modo molto efficace. Su questa sintesi si fonda l’Europa. [...]
L’eredità latina
Un terzo strato del concetto è legato al fatto che nel VI secolo con «Europa» veniva intesa la Gallia e che in seguito l’impero carolingio avanzò la pretesa di essere l’Europa e di esaurire il contenuto di questa definizione. Nel corso del successivo sviluppo venne di nuovo attenuata quest’identificazione, mai accettata del tutto. Un’equiparazione del Sacro Romano Impero dell’alto Medioevo all’Europa non ha avuto luogo: il concetto di «Europa» copriva uno spazio più ampio di quello dell’impero, che si considerava una forma modificata in senso cristiano dell’impero romano. L’Europa venne ora a coincidere con l’Occidente, e cioè con l’ambito della cultura latina e della Chiesa, per cui questo territorio latino comprendeva non solo i popoli neolatini, ma anche quelli germanici, anglosassoni e una parte di quelli slavi, soprattutto della Polonia. La res publica christiana, come si definiva l’Occidente cristiano, non era un costrutto politico, bensì una totalità reale e vivente nell’unità della cultura, nei «sistemi giuridici che si estendevano dalle tribù alle nazioni, nei concili, nella creazione delle università, nella fondazione e diffusione di ordini monastici e nella circolazione della vita spirituale e religiosa attraverso Roma, che ne rappresentava il ventricolo». [...]
L’eredità moderna
Come quarto strato di ciò che costituisce l’Europa bisogna menzionare l’irrinunciabile contributo portato dallo spirito dell’epoca moderna, anche se forse diventa qui percepibile in modo più forte quell’ambivalenza che è insita in ogni singolo livello. Eppure questo non può in nessun caso portare a quel rifiuto dell’epoca moderna che si è presentato in ambito cattolico come tentazione sia nel XIX secolo con il romanticismo medievale, sia tra le due guerre mondiali. Tra gli elementi che caratterizzano l’epoca moderna in senso positivo annovero la separazione di fede e legge, che nella res publica christiana del Medioevo era rimasta piuttosto nascosta e che ora invece viene attuata in modo coerente; considero positivo che in questo modo la libertà nelle cose della fede ottenga gradualmente nella differenziazione degli ordinamenti giuridici civili una forma chiara, e così le richieste interiori della fede vengono differenziate da quelle fondamentali dell’etica su cui si fonda il diritto. I valori umani fondamentali per la visione cristiana del mondo rendono possibile, in un dualismo fruttuoso di Stato e Chiesa, la libera società umana, nella quale è assicurato il diritto alla libertà di coscienza e con esso i diritti fondamentali dell’uomo. In questa società possono coesistere diverse forme di fede cristiana e possono trovare spazio diverse posizioni politiche, che tuttavia dialogano con un canone di valori centrale, la cui forza vincolante è anche difesa della più ampia libertà. [...]
oltre il consumismo
Non tutta l’unificazione politica ed economica che si realizza in Europa può già significare, in quanto tale, il futuro dell’Europa. Una mera centralizzazione delle competenze economiche o legislative potrebbe anche portare a un rapido declino dell’Europa se, per esempio, sfociasse in una tecnocrazia il cui unico criterio fosse la crescita dei consumi. Al contrario, tali istituzioni hanno valore in un più ampio contesto in quanto superamento del culto della nazione e come parti di un ordine pacifico nella partecipazione collettiva ai beni di questo mondo. La loro legge fondamentale non può certamente essere un egoismo di gruppo, esteso ai popoli ricchi che difendono i propri privilegi. La ricchezza collettiva deve essere intesa come responsabilità collettiva per il mondo nel suo complesso e in questo senso l’Europa deve essere, anche nei suoi meccanismi economici, un sistema aperto. Al posto dell’idea del dominio del mondo e dell’annessione coloniale delle restanti parti del mondo deve subentrare l’idea di una società aperta e di una responsabilità reciproca. Questo orientamento di fondo, che si ricava dal concetto di Europa che è stato sin qui elaborato, può essere sviluppato in quattro tesi, parallele alle quattro dimensioni dell’essenza dell’Europa appena delineate.
quattro tesi
Tesi numero 1. Sin dal suo sorgere nell’Ellade, elemento costitutivo dell’Europa è l’intima correlazione di democrazia e di eunomia, di un diritto che non si lascia manipolare. Di fronte alla supremazia dei partiti e alla dittatura come dominio dell’arbitrio, l’Europa ha scelto il dominio della ragione e della libertà, che può durare solo come supremazia del diritto. La limitazione, il controllo e la trasparenza del potere sono elementi costitutivi della comunità europea. Il loro presupposto è l’impossibilità di manipolare il diritto, l’inviolabilità del suo spazio. A sua volta, il presupposto di un simile diritto è di nuovo quello che i greci chiamavano eunomia, ovvero il suo poggiare su criteri morali. Considero quindi antidemocratico fare di «law and order» un insulto: ogni dittatura comincia con la messa sotto accusa del diritto. Bisogna essere d’accordo con Platone anche sul fatto che ciò non dipende tanto da un determinato tipo di meccanismi di formazione della maggioranza, quanto piuttosto dalla realizzazione del valore intrinseco dei meccanismi democratici ciascuno nel modo più sicuro a seconda delle possibilità date, cioè il controllo del potere da parte del diritto, e l’inviolabilità del diritto da parte del potere e della normazione del diritto in base all’etica. Chi combatte per l’Europa combatte quindi per la democrazia, ma nel vincolo indissolubile con l’eunomia, secondo il contenuto del concetto appena delineato.
Tesi numero 2. Se l’eunomia è il presupposto della stabilità della democrazia come opposizione alla tirannide e alla oclocrazia, d’altra parte il presupposto dell’eunomia è il timore dei valori morali e il timor di Dio, collettivo e vincolante per il diritto pubblico. Ricordo ancora una volta l’importante affermazione di Bultmann: «Uno Stato non cristiano è fondamentalmente possibile, ma non uno Stato ateo». In ogni caso alla lunga quest’ultimo non resterebbe uno Stato di diritto. Dio non può essere spostato del tutto nel privato, ma deve essere riconosciuto anche pubblicamente come il valore supremo. Questo senz’altro non esclude – e vorrei sottolinearlo in maniera molto decisa – la tolleranza e lo spazio per l’uomo ateo e non può avere nulla a che fare con la costrizione in materia di fede. Ma la situazione dovrebbe essere sotto certi aspetti contraria rispetto ai suoi sviluppi attuali: l’ateismo comincia a essere il dogma pubblico fondamentale e la fede viene tollerata come opinione privata, ma così in ultima istanza non è tollerata nella sua essenza. [...]
Tesi numero 3. Il rifiuto del dogma dell’ateismo come presupposto del diritto pubblico e del dogma della fondazione dello Stato, e un timore di Dio riconosciuto anche pubblicamente come il fondamento dell’etica e del diritto, significa rifiutare sia la nazione, sia anche la rivoluzione mondiale come summum bonum. Di fatto, il nazionalismo non ha solo portato storicamente l’Europa sull’orlo della distruzione; anche se ha dominato gli ultimi decenni della storia europea, esso contraddice quello che l’Europa è, per sua natura, sia spiritualmente sia politicamente. Perciò sono necessarie istituzioni politiche, economiche e giuridiche sovranazionali, che tuttavia non devono avere il senso di costruire una super-nazione, ma al contrario dovrebbero restituire alle singole regioni dell’Europa una fisionomia e un peso rafforzati. Le istituzioni regionali, nazionali e sovranazionali dovrebbero intrecciarsi in modo tale da escludere in egual misura sia il centralismo che il particolarismo. Soprattutto, il libero scambio e l’unità nella molteplicità dovrebbero essere nuovamente ravvivati in grande misura da istituzioni e forze culturali e religiose non statuali. [...]
Tesi numero 4. L’Europa si deve fondare sul riconoscimento e la tutela della libertà di coscienza, dei diritti umani, della libertà della scienza e quindi su una società umana liberale. Queste conquiste dell’epoca moderna vanno tutelate e sviluppate, senza cadere nell’inconsistenza di una ragione senza trascendenza, che neutralizza dall’interno la propria libertà. La politica europea dei cristiani deve misurarsi su questi criteri, in base ai quali completerà il proprio compito politico.