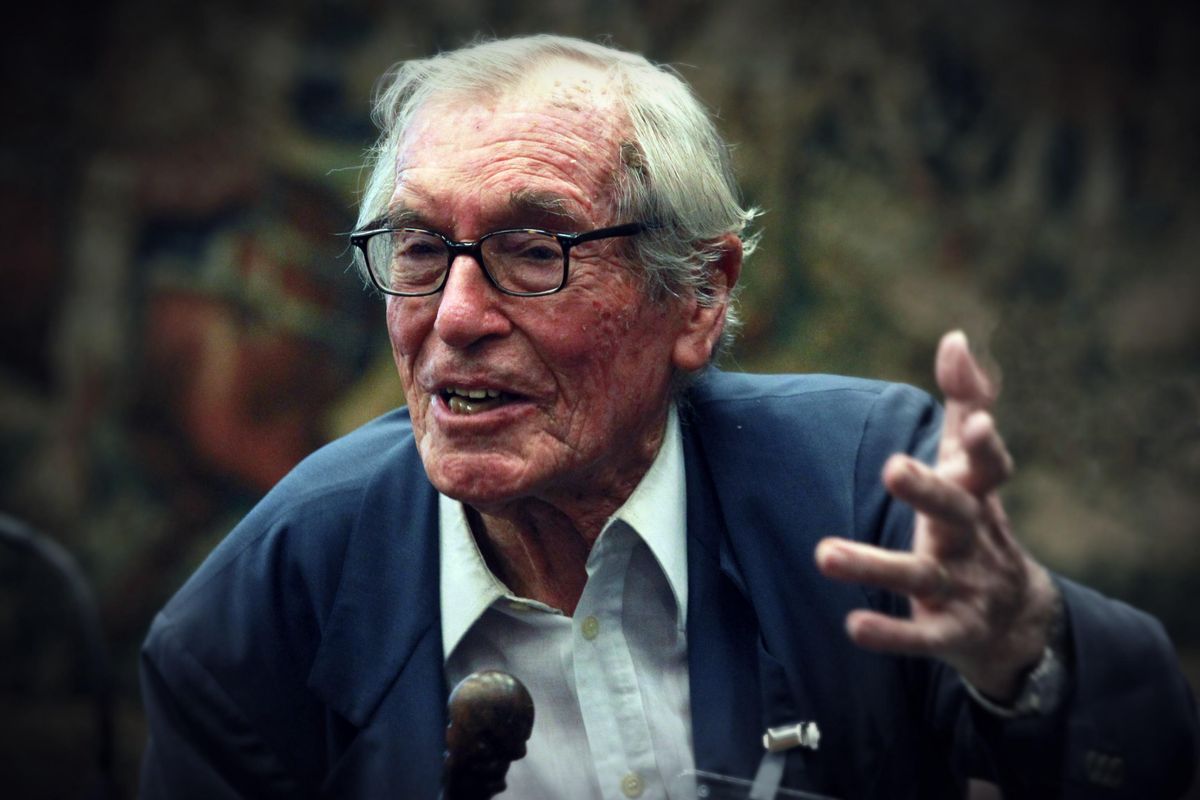
Da dove viene l’ispirazione? Dall’anima? In ebraico, l’anima è un vento che non si sa da dove spiri, da dove venga e quale sia la sua origine. L’ispirazione è un momento di particolare tensione interiore, qualcosa che avvolge tutto l’individuo e che riguarda il suo modo di sentire.
Sicuramente la creatività dell’artista dipende da una forza superiore. L’arte autentica è una conquista dello spirito, che fa scaturire dall’oscurità e dal nulla momenti di gioia incancellabile: abbatte i limiti e le convenzioni, offrendo un modo nuovo di sentire e di vivere. L’artista è un soggetto indipendente e libero e qualsiasi costrizione o regola può mettere in pericolo la sua capacità creativa. Tuttavia, un soggettivismo senza freni scade nell’arbitrio e conduce a risultati che non si accordano con la realtà della vita. Un’opera davvero grande racchiude in sé un’infinità di di potenzialità: è l’immagine del finito nell’infinito, l’unico luogo in cui le contraddizioni si placano. La capacità creativa è un dono naturale; la facilità nell’invenzione melodica è una caratteristica di pochi autori. Per esempio, l’assenza quasi totale di correzioni o rifacimenti nelle partiture autografe di Mozart è la testimonianza di una spontaneità immediata: acqua pura che zampilla senza ostacoli. Da ciò ne deriva il senso di eterna giovinezza che la sua musica possiede. In Beethoven il processo creativo procede all’inverso. Ce lo rivelano i suoi quaderni di appunti: la semplicità dei suoi temi rappresenta una conquista. La sua creatività va dal caos alla semplicità. Il celebre tema iniziale della Quinta sinfonia sembra concepito di getto. In realtà, è frutto di decine di tentativi, abbozzi e appunti che lo precedono e che lo hanno portato alla forma definitiva.
Che cosa è l’interpretazione? È la ricreazione della volontà dell’autore? Una confessione di se stessi? Una simbiosi con l’autore? Un libero volo della fantasia? Proverò a dare alcune risposte. Con la scrittura musicale, il compositore non può rivelare completamente la propria volontà all’interprete, che pertanto deve approfondire tutti gli elementi utili per capire le intenzioni del compositore, anche attraverso la conoscenza del periodo storico e del contesto sociale in cui è vissuto. Per comprendere quello che dico basti pensare alla lettura della poesia. È evidente: uno studente e un attore la leggono in modo diverso. L’autore ha scritto le parole, ma non ha indicato con quale enfasi e con quale dinamica devono essere lette. L’interprete può essere al tempo stesso il notaio attento e scrupoloso delle indicazioni dell’autore, ma anche del ricreatore dell’opera musicale, alla quale aggiunge la propria sensibilità ed esperienza. Secondo alcune testimonianze storiche, gli stessi compositori cambiavano il modo di interpretare i loro brani, a seconda dell’ispirazione del momento. L’interprete ideale è colui che unisce passione e disciplina, mente e cuore, in un giusto equilibrio, senza che nessuno di questi elementi prevalga sull’altro. A proposito del rapporto fra creazione ed interpretazione, vorrei raccontare quando Cesar Franck, uno dei maggiori compositori della seconda metà dell’Ottocento, assistette, insieme ad un suo allievo, alla prima esecuzione della celebre Sonata in La Maggiore interpretata da Eugéne Ysaye e a cui venne dedicata. Alla fine della esecuzione, il compositore belga manifestò il suo entusiasmo di come la sua musica fosse stata eseguita. Il suo allievo però, manifestando alcuni dubbi, fece notare al compositore che numerose sue indicazioni scritte nello spartito non corrispondevano. Invece Franck esclamò: «Ysaye ha ragione!». Questo per dimostrare che talvolta una grande esecuzione può andare oltre le intenzioni dello stesso compositore.
Un altro aneddoto riguarda Arturo Toscanini che dopo aver ascoltato l’a solo di oboe di un brano che stava dirigendo, si rivolse all’esecutore affermando: «Lei fa il contrario di ciò che ho pensato, ma va bene lo stesso!».
Naturalmente non vi è una unica soluzione per arrivare alla verità. Importante è che i vari sentieri confluiscano nella via che conduce verso l’assoluto. Roman Vlad, compositore, pianista e musicologo, racconta in un suo libro, un episodio che spiega quanto possa variare una interpretazione. Scrive Vlad: «In tema di aleatorietà dell’interpretazione voglio riferire un fatto significativo. Negli anni 1910-11, il direttore d’orchestra russo Sergej Kusewickij organizzava delle tournée musicali sul fiume Volga: aveva affittato una nave sulla quale imbarcava un’orchestra sinfonica, celebri solisti, personalità del mondo della cultura e critici musicali. Ad una di queste gite partecipò anche il nostro Alfredo Casella. Ogni sera il battello si fermava in una delle città situate sul fiume e la cittadinanza era invitata, per acculturarsi, ad assistere ad un concerto sinfonico. Il solista principale di queste manifestazioni artistiche era Alexsandr Skrjabin, grande compositore e celebrato pianista, che eseguiva il suo Concerto per pianoforte e orchestra. Una giornalista tedesca, invitata a far parte della comitiva, riferì che lo ascoltò suonare 11 volte questa composizione e che le era parso di ascoltare 11 concerti diversi! Credo che questo sia un esempio estremamente concreto: ogni composizione musicale deve conoscere sempre una rinascita ad ogni esecuzione, una ri-creazione del testo originale, senza che mai si possa pretendere un’identità assoluta tra quella immaginata, sognata e notata dal compositore, e quella effettivamente eseguita. Se l’espressionista Schoenberg esaltava il postulato romantico della libertà di interpretazione, il neoclassico Strawinskij esigeva un assoluto rigore esecutivo. Come si è già ricordato, diceva che voleva essere considerato un notaio il cui dettato andava eseguito alla lettera: «Voglio esecutori, non voglio interpreti!». Non me ne voglia Strawinskij, ma sull’interessante scritto di Roman Vlad aggiungerei soltanto che, su questo punto, non sono d’accordo!






