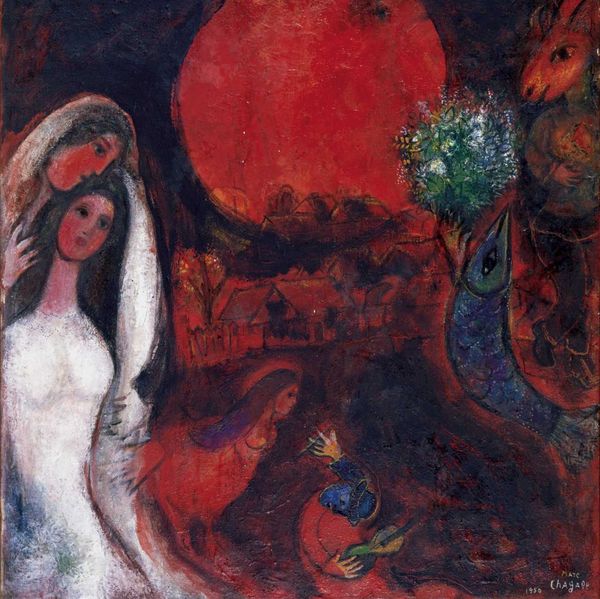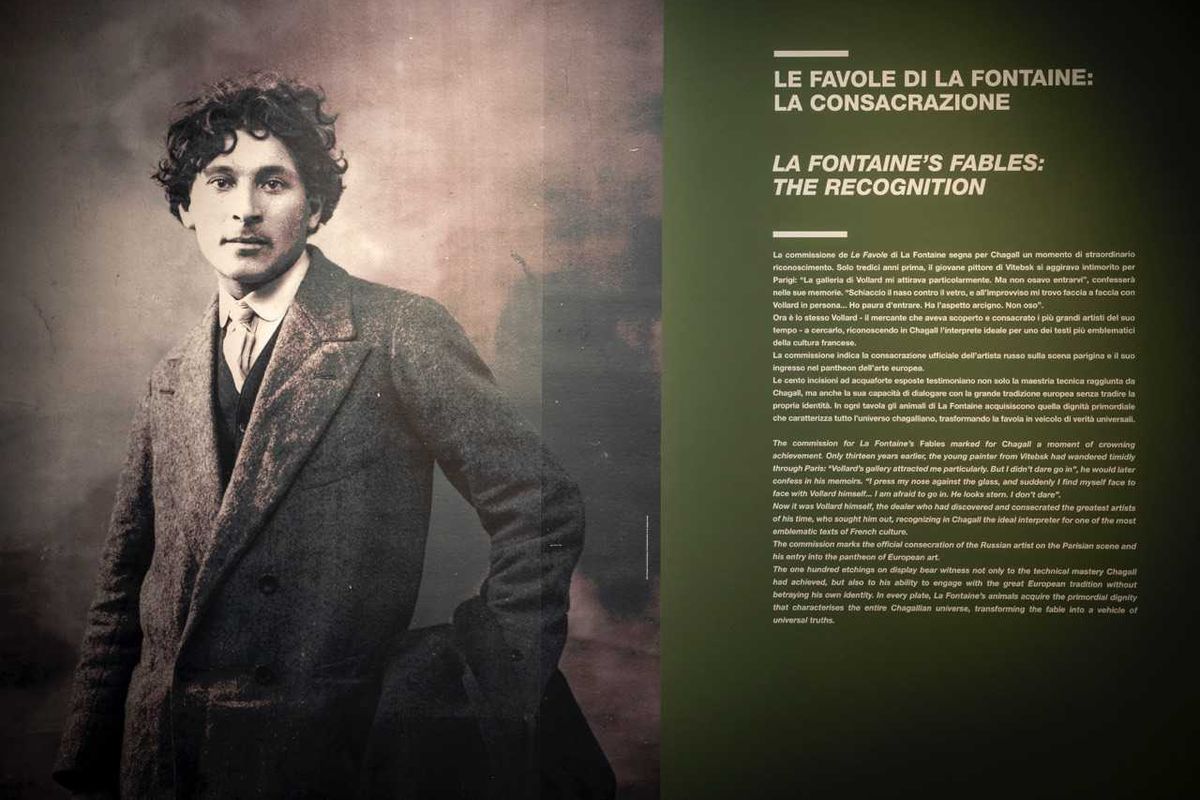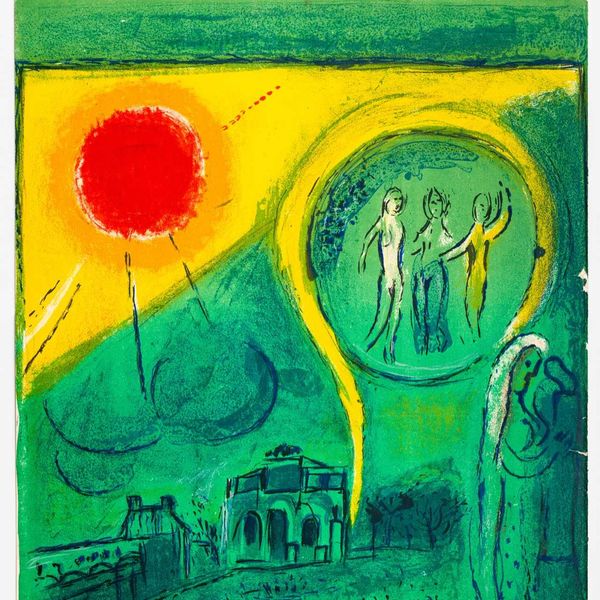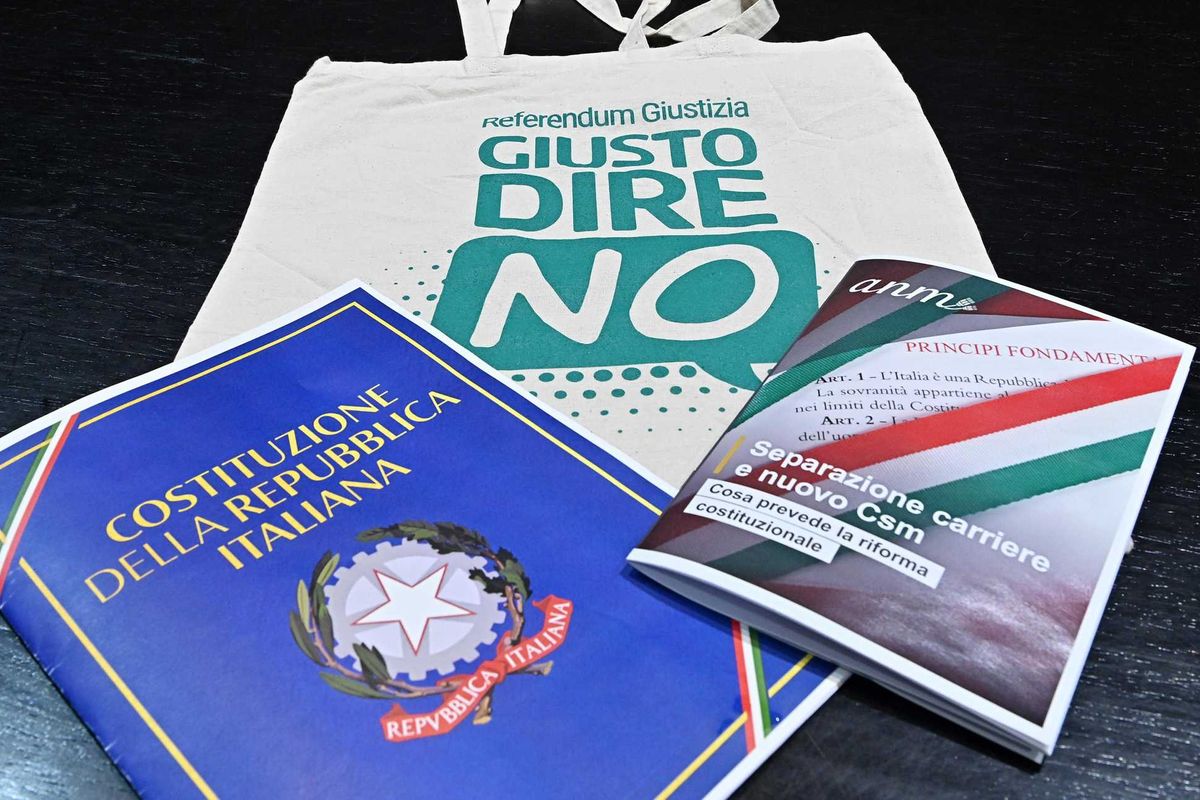Educare all’ascolto salva i più giovani dal bombardamento di suoni senz’anima

Secondo Zoltan Kodaly, se si vuole una comunità formata da esseri umani completi, l'educazione alla musica deve iniziare molto presto, addirittura nove mesi prima della nascita del bambino. Questo perché l'ascolto di brani classici può produrre impressioni che dureranno tutta la vita. È risaputo che nella prima età possono agire sul bambino influenze benefiche, sia psicologiche che biologiche. Vorrei citare i risultati di uno studio condotto dal giapponese Masaru Emoto. Dopo aver congelato acqua purissima e osservato i cristalli di ghiaccio formatisi, lo scienziato notò variazioni sensibili nella struttura a seconda del tipo di musica immessa da una vicina sorgente sonora. Se si trattava di opere di Beethoven o di Mozart, i cristalli di ghiaccio assumevano forme geometriche perfette. Se si trattava di suoni «metallici», duri e pesantemente ritmati, i cristalli assumevano forme caotiche. Questa esperienza quindi suggerisce alcune conclusioni fra cui quella che l'educazione all'ascolto di «suoni validi» o alla visione delle belle arti, dia ai giovani un'impressione duratura che li orienta positivamente. A mio avviso, il primo incontro di un bambino con la musica, all'inizio della sua avventura esistenziale, deve avvenire con il canto, che è modello di ogni strumento. A contatto con il canto, il bambino viene stimolato nella sua immaginazione, nelle sue emozioni, nei suoi sogni e forse anche nelle sue futuribili aspirazioni.
Oggi siamo bombardati da sensazioni sonore che non hanno niente a che fare con la musica: si può sentire senza ascoltare, si può guardare senza vedere. Per leggere un libro non basta guardare le parole: bisogna elaborarle con la mente per comprenderne il contenuto. È necessario l'ascolto lasciandosi accompagnare da un pensiero che determini poi l'emozione. Senza l'accompagnamento di questo pensiero, ci si riduce ad ascoltare musica di sottofondo, come un semplice passatempo che ci distrae.
A questo proposito Daniel Barenboim, nel suo libro La musica sveglia il tempo, cita un pensiero di Thomas Mann (dalla Montagna Magica) e che amo molto: «La musica sveglia noi al raffinato godimento del tempo, e in quanto sveglia è morale. Morale è l'arte in quanto ci sveglia. Ma se invece fa il contrario? Se stordisce, se addormenta, se reagisce all'attività e al progresso? Il narcotico è roba del demonio perché produce stordimento, immobilità, inerzia, servile ristagno».
La musica quindi richiede silenzio, concentrazione, predisposizione spirituale. L'uso improprio che si fa oggi della musica, quando si accostano le pagine sublimi di Mozart alle immagini o alle cose più banali e consumistiche, è un'offesa alla cultura. Bisogna che l'ascolto non debba essere inteso come attività passiva, ma come fonte di armonia interiore tra noi e il mondo. Dobbiamo abituare i giovani all'ascolto dei capolavori senza proporre musiche complesse che richiedono una preparazione troppo specifica e pretendendo per giunta un risultato immediato. Penso che sarebbe importantissimo se gli interpreti dedicassero una parte del loro tempo a spiegare ai giovani e agli studenti, il significato delle musiche che eseguono. A parte questa considerazione, chi dovrebbe selezionare il materiale musicale da fare ascoltare? E come? Alcuni anni or sono, venni invitato a partecipare a una giornata dedicata alla musica, organizzata dal ministero della Pubblica Istruzione, proprio su questo argomento. Rimasi allibito dalla banalità delle musiche che furono proposte ai giovani. Non c'era stato nessun criterio di scelta qualitativa, essendovi peraltro una miniera ricchissima di capolavori che aspettano di essere conosciuti e che avrebbero potuto affinare il gusto e dare gioia a milioni di giovani. Cedere alle mode nell'illusione di accattivarsi i giovani è una strada sbagliata: senza le basi necessarie per poter capire e discernere, è impossibile elaborare qualsiasi progetto educativo di crescita culturale. E così vi è sempre più la tendenza in molte chiese di vedere diminuire vistosamente la esecuzione di brani sacri dei grandi compositori, da Bach a Palestrina, a favore di musica di quarto ordine. E quanta musica corale invece si esegue negli edifici di culto di rito ortodosso, dove il canto è parte principale della messa. A proposito poi dell'istruzione musicale, è stata introdotta una riforma che equipara gli studi di Conservatorio all'università. A mio avviso la ritengo completamente sbagliata. Chiunque abbia una conoscenza musicale deve sapere che lo studio di uno strumento deve avvenire nei primissimi anni dell'infanzia in modo da permettere all'esecutore la naturalezza necessaria che viene di pari passo con il suo sviluppo fisiologico.
Ho sempre sostenuto l'importanza di aiutare i giovani e per supplire alla mancanza di opportunità didattiche e professionali, ho voluto fondare a Roma un festival che contribuisse ad arricchire il panorama musicale. Il festival è nato in primo luogo come risposta polemica al silenzio delle istituzioni, le quali spesso rivelano scarsa lungimiranza, visto che non mettono i giovani al centro della strategia culturale. Ho voluto quindi formare un'orchestra di giovani studenti o diplomati nei vari conservatori italiani e ho offerto loro la possibilità di farsi ascoltare e di acquisire preziose esperienze di lavoro. La musica è un'espressione artistica senza barriere, lo sappiamo; e il festival si spegnerebbe se rimanesse entro i normali confini della fruizione musicale.
Ci esibimmo perciò non solo nei luoghi più suggestivi della Capitale, ma anche negli ospedali, nelle carceri; non posso dimenticare l'accoglienza ricevuta nel carcere di Rebibbia: la forza della musica seppe trasformare un luogo di condanna e di rassegnazione in uno spazio di speranza.
Qualche giorno dopo, un piccolo gruppo ebbe il permesso di assistere a un concerto che eseguii in una basilica romana: erano tutti in prima fila ad ascoltarmi, attenti e commossi. Tra gli ospiti che hanno voluto donare il loro contributo artistico al festival, desidero ricordare Carlo Maria Giulini, Mstislav Rostropovič, Goffredo Petrassi, George Pretre, Wolfgang Sawallisch, Franco Zeffirelli, Giorgio Albertazzi, Umberto Veronesi e Rita Levi Montalcini. Nel corso del tempo, il festival è rimasto fedele alla sua filosofia di fondo: promuovere la musica, valorizzare la creatività dei giovani, esaltare quei valori di bellezza, poesia e magia dell'arte oggi soffocati da una società che corre veloce sulle ali dell'omologazione.
Ripenso anche ai concerti che ho tenuto nei piccoli centri della provincia italiana: non conquistano le prime pagine dei giornali, ma salvaguardano sapere e sensibilità inestimabili. Prima di «Uto Ughi per Roma», avevo organizzato un festival analogo a Venezia, città che amo molto. L'obiettivo, allora, era più strettamente artistico, e mi permise di portare in Laguna i massimi musicisti del tempo. Si chiamava «Omaggio a Venezia». Ne sono stato il fondatore e il direttore artistico dal 1970 al 1984. Molti artisti di fama internazionale accettarono con entusiasmo di dare il loro contributo, totalmente gratuito.
Ricordo che vollero testimoniare la loro ammirazione per una delle città più belle del mondo Artur Rubinstein, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Nathan Milstein, Andres Segovia, Daniel Barenboim, Martha Argerich, Carlo Maria Giulini. Nel corso del tempo, questi festival sono rimasti fedeli alla loro filosofia di fondo: promuovere la musica, valorizzare la creatività dei giovani, esaltare quei valori di bellezza, poesia e magia dell'arte oggi soffocati da una società che corre veloce sulle ali dell'omologazione.
Per concludere, vorrei far constatare che questo virus ha inferto un colpo molto grave alla cultura. Come i teatri, le sale da concerto sono state chiuse. A differenza di discoteche, assembramenti da shopping compulsivo, mancanza di una vera organizzazione preventiva relativamente ai trasporti di milioni di studenti nelle scuole e tante altre manchevolezze, si è voluta invece usare la massima severità nei confronti della cultura. Il danno è enorme. La domanda che mi pongo è se questa pandemia stia creando una sensibilità nuova, perché, da quello che sembra, prevalgono, sempre di più, interessi egoistici di parte che soffocano e impediscono di ricostruire il futuro in uno spirito di concordia e volontà di rinascita collettiva.
In questa senso le parole di Papa Francesco risuonano come un monito: la pandemia è una tragedia, ma sarebbe ancora più grave se l'Uomo non avesse imparato.