È una civiltà che celebra la morte: perciò spopolano i film dell’orrore
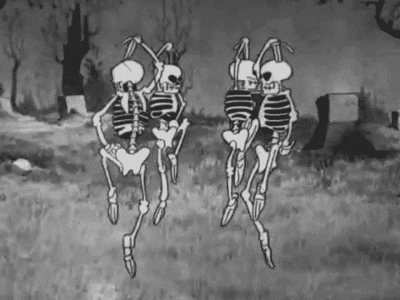
Perché abbiamo così tanto horror? Perché siamo sull'orlo della terza guerra mondiale.
A una terza guerra mondiale, nucleare, forse potremmo non sopravvivere. E poi ci sono stati Chernobyl e Fukushima.
Il mondo può finire, ci dicono, anche per sovrappopolazione, per inquinamento per modificazioni climatiche irreversibili. Sarà vero, sarà falso, ma anche se non ci crediamo, siamo sempre immersi in questa narrazione di disastro totale. L'horror rappresenta il potere totalitario e genocidario. Il secolo XX è stato il secolo dei grandi totalitarismi e dei genocidi.
Per comprendere il totalitarismo abbiamo Hans Christian Andersen, con la sua fiaba I vestiti nuovi dell'imperatore. Per quanto una verità possa essere sotto gli occhi di tutti, tutti la negheranno. Non solo in bizzarri film, ma sui libri di scuola fascismo e il nazismo sono descritti come un branco di lupi su un inerme e recalcitrante popolo di agnelli. Magari! Il fascista e il nazista sono descritti come cattivissimi, psicotici, delle specie di serial killer: la realtà è l'opposto. La realtà è la banalità del male. La stessa persona che nel 1920 era un birraio, nel 1930 era un Ss e negli anni Cinquanta si è messo su un ristorante. Solo i più forti riescono a non conformarsi.
Il consenso al nazismo e al fascismo è stato enorme. I totalitarismi sono stati fenomeni di massa. Questo consenso è stato infranto dalla sconfitta bellica e senza quella sconfitta sarebbe rimasto intatto. E non parlo sono del consenso in Germania e in Italia, ma dell'enorme consenso nei Paesi che riuscirono a restare democratici e opporsi. Il partito «nazista» svizzero era forte, quasi come quello canadese, australiano e inglese. Iosif Stalin è stato uno degli uomini più amati al mondo. D'altra parte, per definizione le democrazie sono «squallide», possono andare bene solo per chi ha l'idea adulta che bisogna accontentarsi dell'ingiustizia minore.
Per chi ha l'idea «infantile» della giustizia più giusta del reame, scintillante come una lama, sono le dittature che brillano di luce e giustizia.
C'è un'affermazione del compagno Stalin, che di morti ammazzati è stato il secondo grande esperto mondiale: «Un morto è una tragedia, un milione di morti è una statistica». L'idea sarebbe che del singolo ucciso ingiustamente nelle democrazie, di cui abbiamo nome, cognome e foto, tutti si indignano, mentre dei milioni di morti macinati senza foto né nomi nei gulag sovietici e nei laogai, (i lager cinesi), non gliene importa un fico a nessuno. In più sono giustificati dal paradiso di giustizia futuro che, chissà come mai, resta sempre nel futuro.
La realtà è infinitamente peggiore. La ferocia di un capo causa ammirazione. Le regole morali sono recenti. L' amore per la ferocia, il fascino che esercita su di noi, è arcaico. Se c'è un capo feroce è più facile sopravvivere essendone un seguace che essendone un nemico. Tanto più alto è il numero di milioni di morti, tanto più alto è il consenso. Molti intellettuali in Europa, tutta la mia generazione, non riescono a nascondere la loro ignobile e immonda ammirazione per il criminale Mao Tze Tung, un assassino, certo, ma un «grande assassino».
La prima azione genocidaria che troviamo in Europa è la crociata dei pastorelli. Questo nome molto vezzoso è stato dato allo sterminio compiuto dalle popolazioni spontaneamente, senza direttiva dall'alto, in occasione la peste del Trecento. La peste era sostenuta da un microrganismo assolutamente sconosciuto al sistema immunitario degli europei; di conseguenza, la peste del Trecento fu infinitamente più catastrofica di quella del Seicento, poi descritta da Alessandro Manzoni. Durante questa prima epidemia di peste, morì un europeo su tre; per noi è inimmaginabile.
Gli ebrei furono accusati di avere avvelenato le fonti causando la peste: molti di loro confessarono sotto tortura e, di conseguenza, furono sterminati insieme ai lebbrosi, bruciati vivi sulle piazze. Interi ghetti sono scomparsi, e sono stati bruciati anche i bambini, anche i neonati.
Analizzando questa catastrofe possiamo vedere che nei genocidi è necessaria la percezione di una qualche superiorità dell'aggredito: in questo caso la capacità tecnica di causare la malattia. Gli ebrei sono sempre stati odiati per la superiorità culturale. Il non aver perso l'alfabetizzazione nemmeno durante l'immane catastrofe del crollo dell'Impero romano, cui si aggiunse la capacità delle professioni liberali e del mercato - le uniche loro concesse - hanno aumentato l'odio. Anche il genocidio del Ruanda e quello della Cambogia contengono l'odio assoluto degli analfabeti per gli alfabetizzati: nel primo caso fu distrutta la «classe borghese» (cioè quelli che sapevano leggere e scrivere), nel secondo l'etnia tutsi (watussi), che era l'aristocrazia culturale dopo essere stata nei secoli passati l'aristocrazia guerriera.
È nel XIV secolo, in occasione di questa doppia azione genocidaria: la peste che uccide tutti e i cristiani che sterminano gli ebrei, che nasce una rappresentazione molto particolare: la «danza macabra». La danza macabra compare come opera teatrale o pittorica. I muri di Europa si riempiono di scheletri ghignanti che trascinano via povere creature disperate strappandole alla vita. Uno di questi scheletri, curiosamente fornito di lanterna, è sull'orologio astrologico di Praga. La danza macabra è la morte che si autonomizza. Non ha nulla a che vedere con il mito di Proserpina, anzi, ne è l'esatto contrario. Il mito di Proserpina rappresenta la morte come parte irrinunciabile del proseguimento della vita, l'inverno senza il quale non sarebbe possibile la primavera. La danza macabra - probabilmente il nome viene da danza dei maccabei - è lo scheletro che uccide la vita, è l'archetipo del potere genocidario.
Scompare dopo il XIV secolo per ricomparire nel XX. Sono danza macabra gli zombie, vari tipi di fantasmi e il non morto per eccellenza, il conte Dracula di Transilvania, che trascinano i viventi verso la distruzione; ne sono la versione moderna. Anche la fantascienza contiene la danza macabra, la nasconde nel pericolo nucleare, la variazione del clima, la pandemia, l'eventuale arrivo di extraterrestri cattivissimi a forma di scolopendra, macchinari che si ribellano, l'iceberg del Titanic su cui da 60 anni tutti viaggiamo, mentre la signora Sarah Connor in Terminator cerca di mettere al mondo il futuro messia, e il tenente Ripley in Alien cerca di non mettere al mondo il maledetto alieno: libri e film si alternano nel ricordarci la paura che il mondo noto finisca in una catastrofe totale.
C'è un picco verticale di adrenalina che ci coglie quando compare il bestione del film Alien. Per quanto possiamo essere disincantati, quando le fauci del mostro escono dal buio c'è un momento di assoluto terrore e che è assolutamente identico a quello che ci prende nell'ultima parte di Hotel Rwanda, quando uno dei machete degli inseguitori striscia sull'asfalto. Cercare di discutere o di trattare con le milizie hutu sarebbe altrettanto folle che cercare di discutere con il bestione di Alien, con i nazgul, o con i terminator. Meglio di tutti sono gli zombie, versione sottoproletaria e pezzente del vampiro che da tre generazioni vengono a succhiarci il cervello, metafora del genocidio: quello che fino a ieri era il vicino di casa oggi è diventato il morto vivente, ha subito il contagio della psicosi collettiva, non viene a chiedere in prestito un uovo e una tazza di farina ma ha in mano in machete e viene a sterminare tutti.
Il potere genocidario ossessivamente presente nell'horror, sotto forma di mostri non umani, è cieco e sordo. È un potere puro e incorruttibile, un potere con cui non si tratta e non si contratta. Qualsiasi richiesta di pietà è ridicola. E poi c'è l'aborto, il diritto di uccidere il «grumetto di cellule» che diventerebbe il nostro bimbo. Siamo una cultura di morte. Lo abbiamo messo nell'horror.






