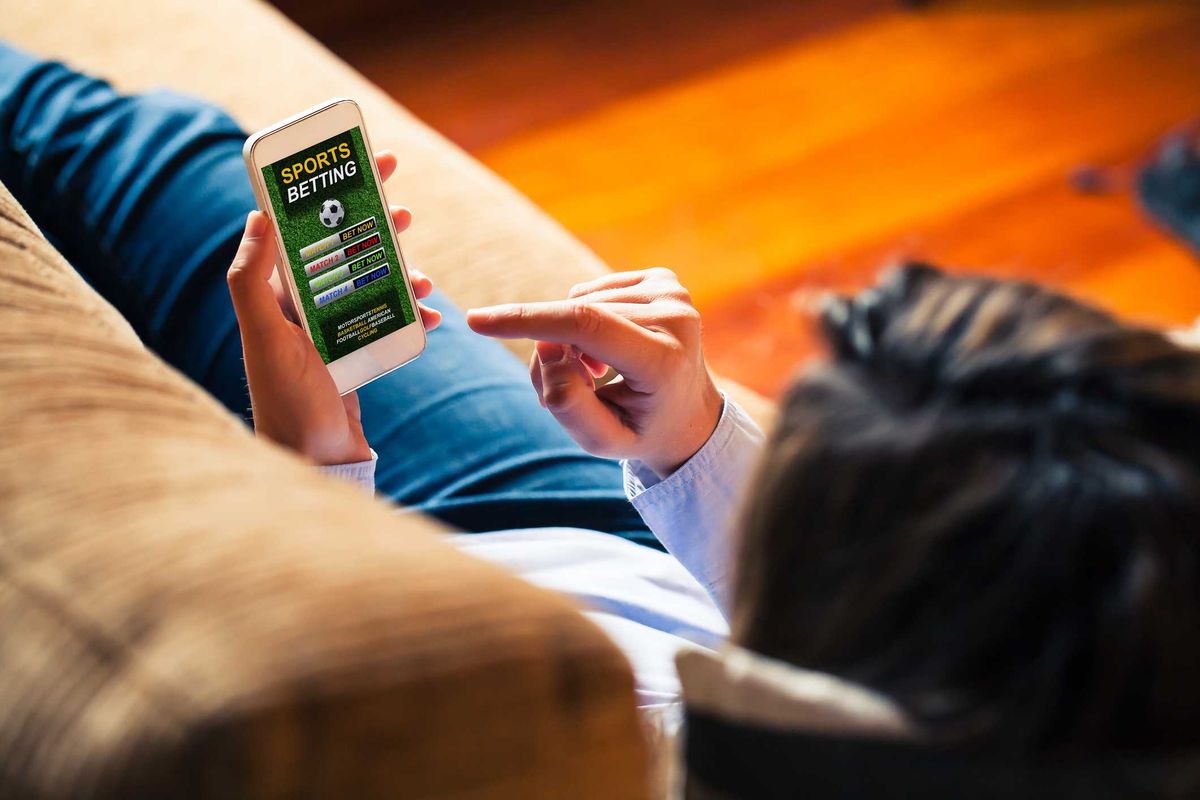2020-09-29
E un film riscopre il D’Annunzio celebrato (ma spiato) dal Regime
Sergio Castellitto nel film «Il cattivo poeta» (01 Distribution)
Esce a novembre «Il cattivo poeta», con Sergio Castellitto nei panni del Vate. La pellicola, tratta da un libro dello storico Roberto Festorazzi, racconta gli ultimi anni di vita dell'artista.Mentre sbarca nelle librerie il secondo tomo della pompatissima biografia romanzesca di Benito Mussolini firmata da Antonio Scurati e Rai Storia si appresta a mandare in onda una docufiction su Margherita Sarfatti, già amante del Duce, dal 5 novembre arriverà nei cinema anche Il cattivo poeta, film diretto da Gianluca Iodice e dedicato alle gesta dell'ultimo Gabriele D'Annunzio. Fenomeno rivelatore: come sempre accade, l'osceno è proprio ciò che da cui non riusciamo a togliere lo sguardo. Allo stesso modo, più divampa l'antifascismo isterico e questurino, più gli italiani sembrano attratti da un certo immaginario. Il cattivo poeta, in particolare, sembra un'operazione che merita di essere seguita: prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris, in collaborazione con Rai Cinema, il film è stato girato con più di 200 comparse al Vittoriale, l'immaginifica villa museo sul lago di Garda in cui il Vate visse il suo crepuscolo, ma anche a Brescia e Roma. Nei panni del poeta, un Sergio Castellitto con pizzetto e pelata d'ordinanza, seppur più in carne e più vispo del D'Annunzio senescente di cui si racconta nella pellicola. Parliamo infatti degli ultimi anni di vita del poeta, quelli della segregazione dorata nella sua villa, tra gli ultimi sprazzi di genialità poetica e l'incedere decadente dei suoi vizi privati, ma soprattutto del periodo della difficile convivenza con il regime fascista. Il cattivo poeta è la trasposizione cinematografica, non sappiamo ancora quanto «libera», di un libro dello storico Roberto Festorazzi, D'Annunzio e la piovra fascista, edito nel 2005 da Il Minotauro e ripubblicato recentemente in una nuova edizioni da Il Silicio. Il saggio si basa sulla testimonianza inedita lasciataci dal federale di Brescia, Giovanni Comini, autore di un memoriale autobiografico di ottocento pagine. Comini, dal 1935 al 1938 fu l'uomo a cui il segretario del Pnf, Achille Starace, affidò il ruolo di controllore di D'Annunzio. Non fu il solo fascista a ricevere questo incarico: come scrive Festorazzi, tale sorveglianza di partito «si aggiungeva a un'altra vigilanza attiva da circa quindi ci anni: vigilanza statale, ministerial-poliziesca, burocratica, ovracea, ma, appunto, non strettamente di partito». Per capire perché tanta attenzione, bisogna accennare al complesso rapporto che legava D'Annunzio a Mussolini. Sodali, ma mai veramente amici, camerati, ma sempre diffidenti l'uno con l'altro, il poeta e il politico hanno condiviso, nel primo dopoguerra, il compito di rivendicare lo spirito delle trincee contro la cosiddetta «vittoria mutilata». Sono stati gli incendiari dell'Italia uscita da Vittorio Veneto, ma lo hanno fatto con tempi, modi, stili, obbiettivi profondamente diversi. Un poeta e un politico, del resto, parlano lingue troppo differenti. Scrive Festorazzi: «Che D'Annunzio non fosse un capo politico, lo si comprese quasi subito. Pur essendo dotato di un notevole carisma, che lo portava a mischiarsi tra le folle dei suoi legionari consumando il rancio con loro, l'autore della Beffa di Buccari non aveva le qualità dello statista. In lui il realismo politico cedeva sovente il passo al sentimento poetico che lo portava a inghirlandare il mondo». Fatta la marcia su Roma, dopo anni di rapporti altalenanti fra i due, D'Annunzio fu messo di fronte al fatto compiuto. Il Vate era, allora, l'unica personalità carismatica che avrebbe potuto sterzare le forze nazionaliste e arditesche verso un progetto alternativo a quello mussoliniano. Il Duce si assicurò che ciò non accadesse. Ne nacque una sorta di compromesso più o meno tacito: la trasformazione del poeta in monumento vivente in cambio della sua rinuncia a ogni pretesa politica. D'Annunzio, nota Festorazzi, «scelse di barattare una parte rilevante della propria libertà in cambio della definitiva consacrazione del proprio mito. Trasformando in monumento nazionale la propria dimora, cedendo i propri manoscritti e statizzando l'edizione delle proprie opere, il Vate conservò diritto di cittadinanza nel panorama culturale e civile della nazione, nella speranza di prolungare la propria memoria e lo sforzo di comprensione del proprio operato oltre le generazioni e oltre i limiti angusti imposti da un regime oggettivamente liberticida». Parallelamente, egli «sopravvisse a se stesso nella quiete agitata di un vero e proprio confino, sia pure dorato. Per un quindicennio, fu l'uomo più sorvegliato e controllato d'Italia». Sbagliano, quindi, i croati e gli antifascisti italiani che hanno protestato contro la recente inaugurazione di una statua del poeta a Trieste, equiparando il letterato al fascismo tout court. Ma sbagliano anche gli smaniosi del recupero a tutti i costi di D'Annunzio, sbrigativamente riabilitato in quanto implausibile antifascista. Più in generale, sbaglia chiunque concepisca la storia attraverso i manicheismi morali e faccia dello storico una sorta di pm del passato. Rispetto all'accusa di fascismo, D'Annunzio non può essere né assolto né incriminato. Diffidenti e manipolatori l'uno dell'altro, Mussolini e D'Annunzio furono però figli di una stessa temperie culturale. Furono fratelli nemici. Certamente nemici, ma comunque pur sempre fratelli.