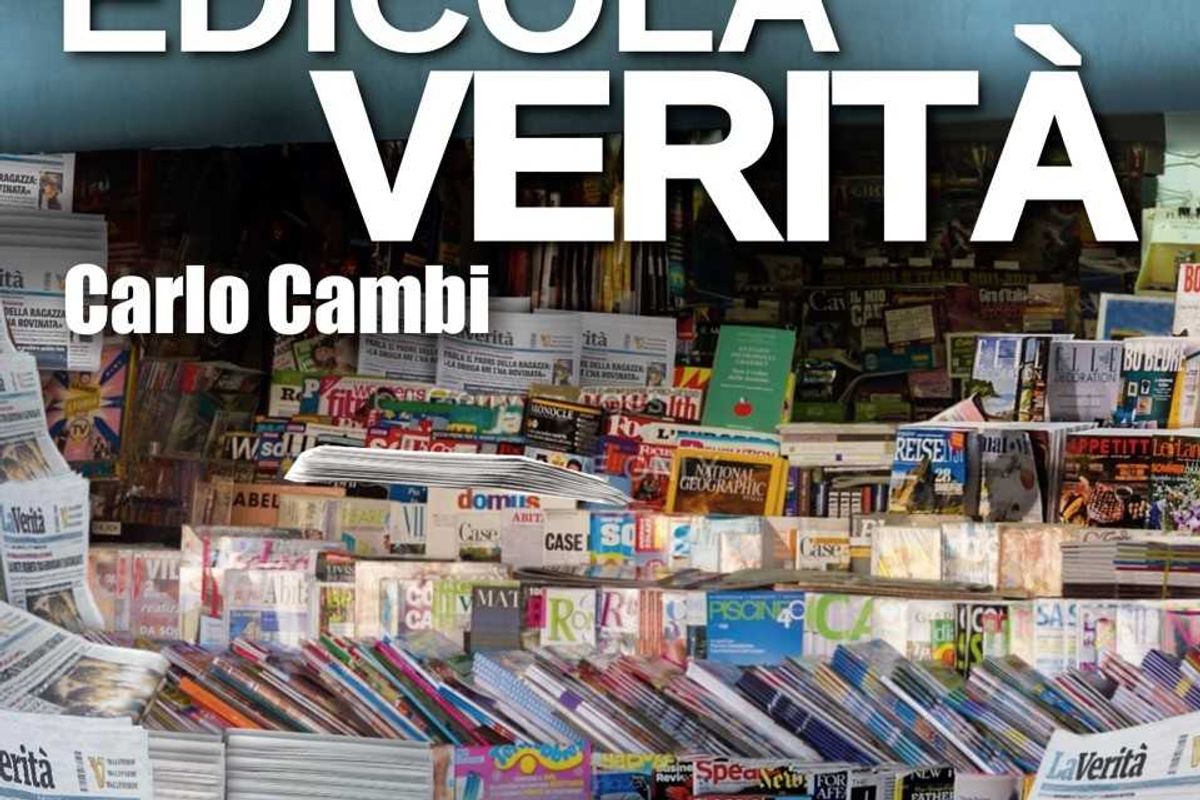Prima gli italiani. Ma in senso letterale: prima di tutti sono venuti gli italiani. Qui, sulla terra che calpestiamo e indegnamente abitiamo ancora oggi, all'alba dei tempi si sarebbe sviluppata la più grande delle civiltà antiche, da cui poi sarebbero nate tutte le altre che abbiamo studiato a scuola.
L'ipotesi - visionaria ma affascinante - non è nuova, anzi. Si tratta di una suggestione che ha attraversato i secoli, alimentata da una cultura underground ma che spesso ha intersecato anche quella ufficiale. E che, anche in questi giorni, rimbalza nell'attualità libraria. Accade così che Melchisedek, casa editrice del gruppo Lindau, ristampi il saggio Sulla tradizione occidentale, di Arturo Reghini, pubblicato originariamente nella rivista Ur nel 1928 per contestare la pretesa, avanzata soprattutto da alcuni esoteristi francesi, che Roma non abbia ospitato una tradizione degna di questo nome, quasi fosse esclusivo appannaggio della Grecia e dei Paesi orientali. Ma, in senso più ampio, si trattava di ribadire un concetto molto caro agli studiosi che si riunivano attorno a Ur, ovvero l'antichità e addirittura la primazia del patrimonio spirituale delle genti italiche.
Personaggio particolare, il Reghini: massone e teorico della massoneria, riconduceva tutta la «libera muratoria» a un percorso spirituale di tipo pitagorico e, neanche a dirlo, schiettamente italico, considerando tutto l'aspetto lobbistico e affaristico delle logge come una derivazione moderna di marca anglosassone. Visione certamente poco realistica della massoneria contemporanea, ma che testimonia comunque il senso di una temperie culturale tipica di quegli anni.
Temperie che funge da espediente narrativo, e anche qualcosa più di un espediente, anche per un romanzo appena pubblicato dalla casa editrice Altaforte: L'occhio del Vate, di Carlomanno Adinolfi. Una sorta di Codice da Vinci in chiave romano-italica, ma in cui la traccia culturale e spirituale assume ben altra profondità. Al centro del romanzo c'è Valerio Pillari, di mestiere cacciatore senza scrupoli di testi antichi e libri rari per ricchi collezionisti.
La sua vita cambia quando un enigmatico cliente gli commissiona il ritrovamento di un ipotetico e sconosciuto seguito de Le vergini delle rocce di Gabriele D'Annunzio, mentre per altri versi si ritrova a dover indagare circa un misterioso medaglione appartenuto proprio al Vate. Le ricerche portano Pillari alle prese con le forze arcane che tentarono di influenzare gli esiti delle due guerre mondiali e che, forse, sono in azione ancora oggi per una battaglia spirituale dietro le quinte delle sfide politiche. Intreccio narrativo a parte, il romanzo funge anche da ottima guida sul tema del «primato italico», fiume carsico di tutto il volume. Un po' per volta, nel libro scorrono tutti i nomi degli studiosi che nel corso degli anni e dei secoli hanno toccato il tema.
Si tratta, insomma, di un «mito bimillenario», come ha scritto lo studioso Paolo Casini in un saggio critico uscito qualche anno fa per il Mulino, L'antica sapienza italica. Cronistoria di un mito (ma può un «mito» - termine che in Casini suona al pari di «favola» - agire sugli spiriti per duemila anni e non essere, in qualche modo, «vero», cioè foriero di effetti sul reale?).
Snodo fondamentale per la costruzione del mito fu la pubblicazione, nel 1840, del saggio Delle origini italiche e della diffusione dell'incivilmento italiano all'Egitto, alla Fenicia, alla Grecia e a tutte le nazioni asiatiche poste sul Mediterraneo, scritto da Angelo Mazzoldi. Questo visionario studioso ipotizzava l'esistenza di una Tirrenide primordiale, ovvero un'Italia geologicamente configurata in maniera completamente diversa rispetto a oggi, abitata da tribù altamente civilizzate. Sulla Tirrenide si sarebbe però abbattuta una gigantesca manifestazione di tipo vulcanico che cambiò completamente la superficie dell'area geologica e costrinse molti popoli italici a migrare in Grecia, in Egitto e nella Mezzaluna fertile, fondando le relative civiltà. Insomma, la vera Atlantide sarebbe stata... l'Italia.
L'opera di Mazzoldi ebbe grande successo, generando tutta una serie di epigoni, tra i quali ricordiamo Camillo Ravioli (Prima tellus, 1859), Ciro Nispi-Landi (Roma monumentale dinanzi all'umanità: il Settimonzio sacro, 1892), Guido Di Nardo (La Roma preistorica sul Palatino, 1934), Evelino Leonardi (Le origini dell'uomo, 1937), Giuseppe Brex (Saturnia tellus, 1944). Si tratta, beninteso, di studiosi genialoidi ma dai forti tratti monomaniaci, pronti a sacrificare il rigore filologico alla ricerca di «verità» accattivanti ma indimostrabili.
Eppure il libro di Mazzoldi ebbe profonda influenza anche su Vincenzo Gioberti, che nel 1843 scrisse il suo Del Primato morale e civile degli italiani, uno dei testi cardine del Risorgimento. Anche Giuseppe Mazzini lesse con interesse il testo di Mazzoldi, traendone l'idea dell'archetipo eterno di Roma. Ma non bisogna dimenticare che il mito del primato italico aveva avuto anche illustri precedenti, come il De antiquissima italorum sapientia di Giambattista Vico (1710) e il romanzo storico Platone in Italia di Vincenzo Cuoco (1806), che facevano anch'essi dell'Italia arcaica la sede di una sapienza purissima, in grado di illuminare tutte le grandi civiltà circostanti. Fantasie? Non le peggiori a cui da queste parti si sia creduto, in ogni caso.